di Stefano Montes
Da tempo immemorabile non andavo a un concerto. Ebbene sì, lo confesso, per anni, preso da tutt’altro, nella mia vita ho messo da parte la musica e le sue ragioni intime, la chitarra, i plettri e i ritmi indiavolati o rasserenanti delle emozioni in fase diretta con il mondo spensierato dell’improvvisazione e del fare estemporaneo. Niente più suoni? Niente più musica? Fino alla fine dei giorni? Non proprio, non esattamente: mi sono dedicato soprattutto agli incastri di ritmi materiali e simbolici dell’esistenza. Per dirla semioticamente, mi sono lasciato attrarre dalla musica del piano del contenuto dei linguaggi della cultura.
L’etnografia, più di altro, ha preso posto nel fluire dei miei piani d’azione e cognizione scacciando il resto, relegando suoni e musica in un cantuccio irrequieto e mesto. Soltanto in apparenza, tuttavia, ben sapendo che, in quanto traduzione di un fatto sociale totale, volenti o nolenti, una etnografia include (o dovrebbe comunque includere) «ciò che le persone ascoltano ogni giorno […], il proprio modo sonico di conoscere ed essere nel mondo» (Feld, Brenneis 2004: 462). Il primo passo, al di là di una qualsiasi impostazione teorica (eventualmente più incentrata sui significanti oppure sui significati), è dunque ammetterlo: suoni e rumori ci circondano e avvolgono la nostra vita, configurandoci costantemente destinatari di messaggi vari ed eterogenei; suoni e rumori sono inoltre attivamente prodotti da noi stessi nello svolgersi delle nostre azioni, configurandoci pure emittenti pervasivi di altri messaggi. Bisogna, in primo luogo, prenderne coscienza: la nostra vita è inscindibile dall’accompagnamento – magari in sottofondo, come un basso per un violino, ma pur sempre accompagnamento presente, interattivo e determinante – di suoni e rumori del mattino e della sera, del giorno e della notte.
A Tallinn, nel fine settimana, vado immancabilmente a letto la sera tardi con gli schiamazzi di ragazze e ragazzi che, al ritorno dal centro e diretti verso l’alloggio studenti, passano sotto la mia finestra, al primo piano, con qualche bicchiere di birra in più nel corpo e la lingua sciolta come acqua corrente: parlano e parlano, ridono e camminano, si fermano e allungano il passo, le foglie al piede scricchiolano mentre nelle mie orecchie il treno in lontananza corre e la mia vita scorre stretta ai suoni insorti all’ordine delle convenzioni diurne e delle ottuse regole disciplinari. Le voci mi tengono compagnia nel silenzio straniante della notte estone, soprattutto in quei momenti, magici e indescrivibili, in cui le mie dita corrono sulla tastiera del portatile, i pensieri crepitano sotto il fuoco della lenta sonnolenza e il lato cupo del mio essere ignoto a me stesso si mescola, di riserbo privo, con la coscienza del compito da portare a termine, oltremodo attento a non ripiegare sulla sola intenzione d’inizio. Di giorno, durante le mie fredde alzatacce mattutine per accompagnare mio figlio a scuola, la vita sembra rarefarsi come i suoni nell’aria, raccogliersi come il fumo che scantona dai tetti di legno mentre gli spazzini imbacuccati colpiscono il suolo, in un andante moderato, come a volerlo accarezzare, producendo il solo sfrigolio dell’alba che sento in disaccordo con la nerezza sbiadita della notte sofferente: in questi frangenti liminari, la pace interiore, la gratuità della contingenza e un disseminato esistere senza necessità sembrano coniugarsi in un tutt’uno indissolubile.
Incominciamo dunque a porci, ognuno di noi, molto semplicemente, la domanda: qual è il mio modo di conoscere il mondo attraverso suoni e rumori? Farlo significa, tra l’altro, sottolineare il principio imprescindibile che la ricerca antropologica non esula dal quotidiano, dai gusti personali e dalle preferenze di ognuno di noi. Nonostante sia soprattutto noto per le sue ricerche più esotizzanti con i kaluli di Papua Nuova Guinea, fa bene Feld a ricordarlo, a proposito del suo maestro, dicendo che la musica faceva parte del quotidiano di Turnbull, che aveva addirittura un clavicembalo nel suo ufficio, che suonava musica classica a pranzo per il piacere di farlo. Ma la cosa più sorprendente è che Turnbull, tra le altre cose più accademiche, suggerisce a Feld di ascoltare anche i Beatles e gli fa dono di una copia di Let it be, da lui considerata una delle più belle canzoni mai scritte. L’ipotesi di Feld è che proprio questa commistione antiaccademica di generi musicali e di punti di vista presenti nell’ordinario di Turnbull trasmette quel forte senso di suono e luogo presente nelle sue registrazioni e nei suoi scritti, persino in quelli più accademici e convenzionali: «è quel tipo di ascolto sociale attivo, quotidiano, che consente di sviluppare una profonda consapevolezza della presenza e significato del suono» (Feld, Brenneis 2004: 462).
Secondo Feld, quindi, ascolto sociale e suono vanno insieme, capacità di ricezione della società e sonorità sono ineludibilmente compresenti: meglio ancora, come nel caso di Turnbull, se ciò avviene attivamente. Mi chiedo allora: non si tratta forse – al di là della giusta pertinentizzazione sonora su cui si mette l’accento qui – di dialogo, cioè di produzione e ricezione di atti comunicativi? Benché a livelli diversi di competenza e specializzazione, siamo infatti tutti produttori ed emittenti, siamo riceventi e destinatari; i suoni, per di più, si mescolano inestricabilmente ai rumori, i messaggi vengono scambiati senza sosta anche a nostra insaputa. Riconoscerlo significa, nella mia prospettiva di antropologo dei linguaggi, darsi a un innovativo campo di studi – sia in luoghi esotici sia in luoghi a noi prossimi – la cui mira teorica include l’interrogazione generale sulla soggettività nelle sue diverse sfaccettature, recuperando dimensioni trascurate dell’osservazione-partecipante quali le sfere sensoriali (uditive, tattile, etc.) nella loro ampiezza, ricomponendone la sintassi spesso stereotipata e l’influenza reciproca sull’atto diversificato di cognizione.
Una riflessione sistematica e approfondita sulla – talvolta tanto lodata, talvolta tanto biasimata – osservazione-partecipante dovrebbe tenere conto degli accorpamenti della dimensione visiva con le diverse sfere relative alle altre sensazioni e delle parallele proiezioni sintattiche durante l’azione e nella trasposizione testuale. Come ricorda Augé (2007: 27), «Colui che osserva, che lo voglia o no, non cessa di interpretare e paragonare». E, per paragonare, sono necessarie almeno due istanze simmetriche e complementari: quelle da comparare nell’oggetto e quelle del soggetto che si sposta nel tempo rendendosi ‘doppio’ di se stesso. Riconoscere questa dimensione sonora della socialità (e la parallela socialità dei suoni) significa ancora, a mio parere, esplorare insieme le nozioni di soggetto e di dialogo nella loro più ampia portata, persino tra realtà talvolta considerate in alternativa: al di là, persino, della stessa e sola dimensione sonora acusticamente intesa. E, nel dirlo, già dall’inizio di questo mio saggio mi si lacera il cuore d’un languore latente: affinché la ricerca avanzi, è necessario rinunciare a occupazioni predilette? Suonare la chitarra appartiene a una dimensione che era, per me, alternativa rispetto a quella della ricerca, così come la dimensione soggettiva potrebbe sembrare in alternativa a quella dialogica. Forse, e me ne convinco sempre più, queste sono false opposizioni e io dovrei tornare a suonare la chitarra senza rinunciare alla ricerca scientifica. Dovrei, anzi, saltare continuamente da una frontiera all’altra: dal passatempo per sollazzo alla ricerca e viceversa. Per il gusto di farlo.
Un esempio radicale a questo riguardo? Come un lungo singulto, mentre mi dirigo a passo spedito all’Estonia Kontserdisaal di Tallinn dove ho deciso di andare a sentire (e vedere) il concerto di Al Jarreau, mi passa adesso per la testa l’esempio di Stoller. Secondo lui, l’apprendistato della stregoneria, più che una condizione psicologica originaria e intaccabile, significa porsi «nella condizione di potere stare su entrambi i lati della frontiera». (Stoller 2009: 27). Nei miei termini di antropologo dei linguaggi, saltando da una parte e dall’altra della frontiera posta tra due modi di concepire mondi (occidentale e songhay), Stoller instaura sul campo (e, non dimentichiamolo, nella sua vita) un dialogo tra questi mondi e queste concezioni. La figura del dialogo, credo, sia in ultima analisi l’emblema dell’antropologo come individuo in costante transito, tra entità diverse, sulla frontiera dell’essere nel ‘qui rassicurante’ e al contempo in un ‘altrove indefinito’: un antropologo è alla ricerca di una loro integrazione a partire da un posizionamento che valorizza comunque il situarsi ‘nel mezzo’, nella duplicità del movimento, nella tensione del divenire.
La questione della duplicità – in fondo, il dialogo non è altro che il situarsi del ‘due’, in potenza e in atto, nella comunicazione – e della soggettività si pone quindi a partire da alcune dimensioni sensoriali trascurate, quali, tra le altre, proprio quella uditiva (già intrinsecamente sociale) di cui parla Feld, inglobante incessantemente la nostra vita in tutti i suoi aspetti. Fino a che punto, in definitiva, ritornando a Feld e alle sue ricerche, l’esperienza uditiva (e, non dimentichiamolo, la socialità in quanto dimensione sonora) è parte integrante della nostra vita ordinaria contribuendo a modellare, col suo martellamento instancabile, le diverse configurazioni della soggettività? Da quanto affermato, la risposta è evidente, per quanto, con sorpresa, mi sono stranamente reso conto che l’esplorazione sistematica delle relazioni instauratesi tra i vari soundscapes globali e le specifiche configurazioni di soggettività è un fatto relativamente recente. Un elemento è assodato: negli autobus, nel metrò, nelle strade, nei centri commerciali siamo persistentemente inondati di suoni; persino i mezzi tecnologici che utilizziamo per metterci al riparo da altri suoni e rumori che rifiutiamo possono costituire un modo per comunicare – e, soprattutto, pensare comunicando – con noi stessi e con gli altri (telefonini, computer, walkman, etc.). Come sottolinea Bull, nel suo studio relativo all’uso dei walkman, «ho inteso gli artefatti tecnologici nei termini del (e attraverso il) soggetto dell’esperienza. L’uso dei walkman mostra che tecnologia ed esperienza sono reciprocamente mediate» (Bull 2000: 195).
Volenti o no, emittenti o riceventi, instauriamo un dialogo continuo non soltanto con il nostro prossimo in carne e ossa, ma, anche, con i suoni e i rumori (che produciamo e riceviamo) e con i mezzi tecnologici di cui ci serviamo. Sempre più, ci piaccia o no, la realtà deve essere allora intesa nel suo rapporto con i diversi gradi di simulazione che la tecnologia ci consente; sempre più, i sensi devono essere compresi come forme di estensione mediata dalla tecnologia (Turkle 2011) : nel bene e nel male. Realtà e simulazione sono, oggigiorno, strettamente intrecciate e ridefiniscono, dialogicamente, i nostri modi di essere e concepire l’una e l’altra. Consapevolmente o meno, in sostanza, viviamo in un flusso di emittenze e ricevenze, incredibilmente incrociate e sovrapposte tecnologicamente, che consentono (o talvolta impongono) di ripensare la nozione di dialogo e di includervi, tra le altre cose, lo scambio di voci e suoni tra interlocutori in carne e ossa, ma, anche, tra enti più astratti e immateriali, nonché tra le diverse istanze costitutive la coscienza di uno stesso individuo.
Il secondo passo consiste dunque nell’accettare il principio che i dialoghi – cognitivi, emotivi e percettivi, così come quelli pianificati o improvvisati, intenzionali o casuali – affidati a ritmi regolari e irregolari, a battute cadenzate o scombussolate, fanno parte integrante della nostra vita comune e ordinaria e vanno studiati antropologicamente. Viviamo musicalmente, dialogicamente: ordinatamente e disordinatamente, in modo ordinario o straordinario, a casa nostra e sul campo. Questo principio dialogico di base, dunque, vale non soltanto per il permeante universo sonoro a cui sono tanto legato, ma, anche, per altre dimensioni cognitive e sensoriali, legate ad altri sensi e percezioni, che si scambiano messaggi e comunicano incessantemente, talvolta indipendentemente dal soggetto in carne e ossa, sovente inteso – ingenuamente, a mio parere – come fonte originaria di effetti. Un esempio, sottovalutato, che possa valere per tutti? Persino quando crediamo di ‘essere all’interno della nostra testa’, chiusi nel nostro piccolo mondo quotidiano, in apparenza lontani da ogni forma di comunicazione con chicchessia, instauriamo invece quel particolare dialogo cognitivo ed emotivo con noi stessi che gli specialisti definiscono endofasia o discorso interiore. Che voglio dire con questo, più esattamente? Siamo tutti dei pazzi che intavoliamo chiacchierate con noi stessi o dei lunatici che pensano senza controllare i propri flussi di pensiero incontrollati? Per attenermi strettamente al principio dialogico che qui difendo, prendo le distanze da me stesso e lascio parlare due valenti studiosi russi.
Nel saggio dedicato ai rapporti tra cultura e comunicazione, infatti, Lotman e Uspenskij si curano di distinguere adeguatamente due forme di comunicazione: “IO-EGLI” e “IO-IO”. Il primo caso riguarda la comunicazione che avviene da un soggetto (IO) all’altro (EGLI); il secondo caso riguarda la comunicazione che va dal soggetto (IO) a se stesso (IO). I due autori sono attenti a includere, oltre la più evidente funzione mnemonica, quei casi in cui uno scrittore legge da un suo testo a stampa (la lettura dal testo produce infatti una significazione supplementare) e le annotazioni diaristiche «che si fanno non per fissare il ricordo di determinate notizie, ma allo scopo, per esempio, di chiarire il proprio stato d’animo, chiarimento che senza un’annotazione non avverrebbe»(Lotman e Uspenskij 1973: 113). È interessante notare subito il fatto che lo stato d’animo per i due autori, solitamente inteso da alcuni studiosi come elemento sito nell’interiorità inespugnabile, può invece essere il risultato di un forma di scrittura (quella diaristica) e di un mutamento di codice. Come dire: per studiare le emozioni è necessario studiare pure le forme di autocomunicazione tipologizzate all’interno di una cultura sulla base delle commistioni dei diversi codici e non soltanto per ‘sondaggi psicologici’ dell’interiorità in sé, avulsa dai contesti culturali, isolatamente dalle forme di traduzione testuale che l’accompagnano come un basso continuo e inseparabile dal resto dell’orchestra.
L’altro punto che emerge dalla citazione dei due studiosi russi riguarda l’importanza della scrittura: intesa non tanto come traccia neutrale di un vissuto da riportare, ma come elemento attivo di trasformazione e consapevolizzazione degli stati d’animo. I due studiosi russi precisano inoltre: «Le culture orientate sull’autocomunicazione sono in grado di sviluppare una grande attività spirituale; spesso risultano però meno dinamiche di quel che richiedano i bisogni della società umana» (Lotman e Uspenskij 1973: 133). Direi che, in sé, questo è un programma di ricerca aperto che coniuga discipline linguistiche e culturali. Ma un’altra questione si collega qui, in maniera complementare, a ciò che dicevano Lotman e Uspenskij sulle annotazioni diaristiche: il rapporto che, più specificamente, intrattengono scrittura etnografica e autocomunicazione. È noto: una volta tornato a casa l’etnografo raccoglie appunti e annotazioni e trasforma la propria esperienza in testo bell’e buono per i colleghi e per il pubblico (due forme di ricezione che, sovente, mal si coniugano). Ma non è finita qui, qui viene il bello per me. Una forma di autocomunicazione che instaurano molti etnografi – anch’io lo sto facendo adesso, in questo stesso momento, impegnandomi al contempo in un dialogo sincretico con me stesso, altri autori e pubblico potenziali – riguarda la rivisitazione della propria etnografia il cui fine non è soltanto il pubblico a cui viene rivolta, ma, anche, se stessi e il rapporto tra un ‘qui’ e un ‘altrove’ semioticamente pregnanti: i contesti (quello di ricerca più lontano nel tempo rispetto e quello odierno), i codici (dall’etnografia vera e propria al genere ‘commento’) e i metalinguaggi (la teoria richiede immancabilmente almeno un linguaggio che verte su un altro linguaggio).
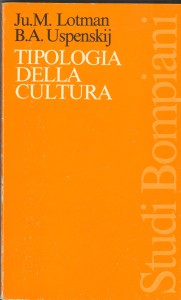 In questa prospettiva, un bell’esempio di autocomunicazione da passare a setaccio – non è possibile farlo qui per ovvie ragioni – sarebbe il testo curato da Puddephatt, Shaffir e Kleinknecht sulle rivisitazioni di etnografie in cui, già dal proposito, si evince l’interesse interdisciplinare dell’impresa: invitare gli autori delle etnografie a «rivisitare i loro lavori al fine di considerare, a posteriori, ciò che ha dato forma alle loro idee e di considerare il modo in cui l’organizzazione particolare del loro lavoro si era svolta. Più ampiamente, gli autori avrebbero dovuto riflettere su loro errori e omissioni ed esaminare il loro lavoro col senno di poi, acquisito grazie a sviluppi più recenti» (Puddephatt, Shaffir, Kleinknecht 2009: XVIII). Non è forse anche questa una forma di autocomunicazione, benché molto complessa e particolare? Fin qui tutto chiaro, spero (attenzione, parlo con il lettore, ma – ormai il gioco è evidente – comunico liberamente, improvvisando anche con me stesso e i miei pensieri, per rassicurami, attraverso una vera e propria forma di auto comunicazione!). Ciò che invece potrebbe portare fuori strada il lettore è l’idea che – “ci risiamo”, direbbero gli anti-postmodernisti – non farei altro che affermare il valore della scrittura sull’esperienza vissuta sul campo nell’intento di cogliere una cultura altra. Il testo o l’esperienza vissuta? Io direi tutt’e due tenendoli strettamente legati: senza il testo non si potrebbe veicolare l’esperienza etnografica; a sua volta, l’esperienza è una componente essenziale di una etnografia che richiede attenzione. Come sottolinea Geertz – il quale ha dedicato un libro intero alle strategie narrative degli etnografi – io «non sono affatto tra quelli che credono nell’autonomia ‘ontologica’ dei testi» (Geertz 1990: 7). Sono ben consapevole del fatto che sarebbe molto difficile conservare e trasmettere gli elementi di una cultura senza i testi; sono pur consapevole del fatto che i testi vanno analizzati e commentati in sé e per le traduzioni interculturali che contengono. Se parlo qui di testi è per cercare però di arrivare all’esperienza e al dialogo che si produce nei diversi livelli della significazione.
In questa prospettiva, un bell’esempio di autocomunicazione da passare a setaccio – non è possibile farlo qui per ovvie ragioni – sarebbe il testo curato da Puddephatt, Shaffir e Kleinknecht sulle rivisitazioni di etnografie in cui, già dal proposito, si evince l’interesse interdisciplinare dell’impresa: invitare gli autori delle etnografie a «rivisitare i loro lavori al fine di considerare, a posteriori, ciò che ha dato forma alle loro idee e di considerare il modo in cui l’organizzazione particolare del loro lavoro si era svolta. Più ampiamente, gli autori avrebbero dovuto riflettere su loro errori e omissioni ed esaminare il loro lavoro col senno di poi, acquisito grazie a sviluppi più recenti» (Puddephatt, Shaffir, Kleinknecht 2009: XVIII). Non è forse anche questa una forma di autocomunicazione, benché molto complessa e particolare? Fin qui tutto chiaro, spero (attenzione, parlo con il lettore, ma – ormai il gioco è evidente – comunico liberamente, improvvisando anche con me stesso e i miei pensieri, per rassicurami, attraverso una vera e propria forma di auto comunicazione!). Ciò che invece potrebbe portare fuori strada il lettore è l’idea che – “ci risiamo”, direbbero gli anti-postmodernisti – non farei altro che affermare il valore della scrittura sull’esperienza vissuta sul campo nell’intento di cogliere una cultura altra. Il testo o l’esperienza vissuta? Io direi tutt’e due tenendoli strettamente legati: senza il testo non si potrebbe veicolare l’esperienza etnografica; a sua volta, l’esperienza è una componente essenziale di una etnografia che richiede attenzione. Come sottolinea Geertz – il quale ha dedicato un libro intero alle strategie narrative degli etnografi – io «non sono affatto tra quelli che credono nell’autonomia ‘ontologica’ dei testi» (Geertz 1990: 7). Sono ben consapevole del fatto che sarebbe molto difficile conservare e trasmettere gli elementi di una cultura senza i testi; sono pur consapevole del fatto che i testi vanno analizzati e commentati in sé e per le traduzioni interculturali che contengono. Se parlo qui di testi è per cercare però di arrivare all’esperienza e al dialogo che si produce nei diversi livelli della significazione.
In definitiva, più che l’affermazione del valore del testo in sé o dell’esperienza intesa isolatamente, mi preme ribadire le qualità portentose del dialogo che si instaura tra l’uno e l’altra, così come tra un testo che la veicola e il suo autore: le rivisitazioni, comunque sia, prima ancora che un resoconto scritto per il pubblico, sono una forma (poco esplorata teoricamente) di autocomunicazione in cui l’autore deve rendere conto a se stesso del processo esperienziale in ‘divenire divenuto altro’ (un film, uno scritto, una registrazione, etc.), instaurando un dialogo con se stesso e con gli altri, con i testi e con le riscritture di ogni tipo prodotte sul campo e altrove (abbozzi, annotazioni, commenti, disegni, foto, etc.). Infine, se non cerco di valorizzare il peso della scrittura sull’esperienza, che ipotesi cerco di avanzare (anche questo mio enunciato, attenzione, proprio mentre lo scrivo, è una commistione di auto ed etero comunicazione)? Ciò che vorrei, per dirla in breve, è «mettere in evidenza il fatto che il parlare un linguaggio fa parte di un’attività, o di una forma di vita» (Wittgenstein 1967: 21) che implica forme di comunicazione che oscillano immancabilmente tra (almeno) due poli: quindi, in definitiva, dialoghi (con il proprio sé e quello degli altri, con i propri e altrui testi). E la rivisitazione di una propria etnografia è una forma particolare di autocomunicazione in cui si dialoga con se stessi e i propri testi.
 Una precisazione, a questo punto, va fatta ancora su una questione che potrebbe prestarsi a fraintendimenti: l’autocomunicazione di cui parlano Lotman e Uspenskij è intimamente connessa a tutte le altre forme di comunicazione, soprattutto in etnografia, secondo me, in cui i vortici di rimando tra esperienza e forme diverse di testualizzazione sono intensi e frenetici. Cito nuovamente a titolo di esempio due autori, ambedue ragguardevoli a mio parere, benché diversi tra loro: Marc Augé e Steven Feld. Il caso di Augé è davvero interessante antropologicamente perché conferma il principio che un autore non è una monade indifferenziata (e chiusa al dialogo con se stesso e con gli altri), ma un soggetto in evoluzione (rispetto alle proprie teorie e ai propri scritti con i quali instaura, per l’appunto, un dialogo nel tempo). Solitamente etichettato come l’autore che ha formulato il concetto di nonluoghi (autostrade, sale d’attesa, supermercati, metrò, etc.), Augé viene criticato da alcuni studiosi perché in effetti i nonluoghi, in quanto luoghi di transito, privi di una concrezione identitaria forte, non sarebbero tali per tutti e per sempre, invariabilmente. Per coloro i quali abitano e frequentano i cosiddetti nonluoghi, questi sarebbero invece, secondo i critici, luoghi che conferiscono loro identità. A più riprese, Augé si è affrettato a chiarire il principio che i nonluoghi non sono da vedere in sé, in quanto sostanze, in maniera fissa: sono piuttosto entità spaziali da cogliere in termini di relazioni strutturali con coloro i quali li frequentano. Il problema, in questa prospettiva strutturale, ovviamente non si pone più: in rapporto agli individui che li abitano o attraversano, a volte si tratta di luoghi, a volte di nonluoghi. Augé stesso afferma, a una ventina d’anni dalla sua ricerca (Augé 1992), che il metrò non è un nonluogo nemmeno per lui: «il metrò non è un nonluogo […], in ogni caso per me, né per coloro che vi compiono regolarmente lo stesso tragitto. Nel metrò, essi hanno dei ricordi, delle abitudini, riconoscono dei volti e intrattengono con lo spazio di certe stazioni una sorta di intimità corporea» (Augé 2009: 31).
Una precisazione, a questo punto, va fatta ancora su una questione che potrebbe prestarsi a fraintendimenti: l’autocomunicazione di cui parlano Lotman e Uspenskij è intimamente connessa a tutte le altre forme di comunicazione, soprattutto in etnografia, secondo me, in cui i vortici di rimando tra esperienza e forme diverse di testualizzazione sono intensi e frenetici. Cito nuovamente a titolo di esempio due autori, ambedue ragguardevoli a mio parere, benché diversi tra loro: Marc Augé e Steven Feld. Il caso di Augé è davvero interessante antropologicamente perché conferma il principio che un autore non è una monade indifferenziata (e chiusa al dialogo con se stesso e con gli altri), ma un soggetto in evoluzione (rispetto alle proprie teorie e ai propri scritti con i quali instaura, per l’appunto, un dialogo nel tempo). Solitamente etichettato come l’autore che ha formulato il concetto di nonluoghi (autostrade, sale d’attesa, supermercati, metrò, etc.), Augé viene criticato da alcuni studiosi perché in effetti i nonluoghi, in quanto luoghi di transito, privi di una concrezione identitaria forte, non sarebbero tali per tutti e per sempre, invariabilmente. Per coloro i quali abitano e frequentano i cosiddetti nonluoghi, questi sarebbero invece, secondo i critici, luoghi che conferiscono loro identità. A più riprese, Augé si è affrettato a chiarire il principio che i nonluoghi non sono da vedere in sé, in quanto sostanze, in maniera fissa: sono piuttosto entità spaziali da cogliere in termini di relazioni strutturali con coloro i quali li frequentano. Il problema, in questa prospettiva strutturale, ovviamente non si pone più: in rapporto agli individui che li abitano o attraversano, a volte si tratta di luoghi, a volte di nonluoghi. Augé stesso afferma, a una ventina d’anni dalla sua ricerca (Augé 1992), che il metrò non è un nonluogo nemmeno per lui: «il metrò non è un nonluogo […], in ogni caso per me, né per coloro che vi compiono regolarmente lo stesso tragitto. Nel metrò, essi hanno dei ricordi, delle abitudini, riconoscono dei volti e intrattengono con lo spazio di certe stazioni una sorta di intimità corporea» (Augé 2009: 31).
L’altro punto, ugualmente centrale in antropologia, che chiarisce Augé riguarda la possibile mutevolezza dell’oggetto di ricerca e la sua ricezione da parte del pubblico. Soprattutto nella prospettiva dialogica che sto prendendo qui in conto, è interessante vedere come l’obiettivo stesso della ricerca non è infatti immutabile nel tempo, ma è sottoposto anch’esso ai processi di produzione e ricezione dei messaggi che non sempre coincidono tra loro: «è l’etnologo che spaccavo in due per cercare di fargli capire (di farmi capire) cosa significasse essere interrogato da qualcuno come me. Era questa la mia intenzione, ma i lettori hanno invece preferito prestare attenzione al quadro dell’inchiesta, vale a dire il metrò stesso» (Augé 2009: 17). Per sintetizzare, Augé non è un’‘entità’ fissa, ma in divenire, in costante dialogo con se stesso, i propri testi e i lettori: insomma, un autore dà origine a un testo, ma ne è in qualche modo catturato; un autore genera dei messaggi, ma viene letteralmente preso nel circuito complesso della comunicazione dei messaggi, nel circolo della produzione e ricezione.
 Più in generale, ed è questa la mia ipotesi, si può aggiungere che gran parte dell’opera di Augé può essere considerata un lungo e proficuo ‘esercizio di riflessività’ applicato alle categorie dell’antropologia e al soggetto stesso che le pratica. Ricorrendo nuovamente a Wittgenstein, infine, si potrebbe pertinentemente affermare che «immaginare un linguaggio significa immaginare una forma di vita» (Wittgenstein 1967: 17). L’immaginazione etnografica (e il suo linguaggio) non fa eccezione in questo. Similmente, un principio dialogico vale pure per Steven Feld, il quale lo applica nella sua ricerca sul campo in maniera gradevolmente amplificata, coinvolgendo direttamente i suoi amici-interlocutori e se stesso in quanto antropologo e autore di una etnografia sui kaluli del Bosavi di Papua Nuova Guinea. Qui e lì nel suo splendido lavoro, in cui confluiscono diverse discipline (antropologia, estetica, linguistica, ecologia), Feld non ha nessun imbarazzo nel mettere in risalto l’apporto di amici e maestri, in dialogo con lui prima e dopo la sua esperienza di campo. Per esempio, scrive che «Sia nell’orientamento teorico sia nello stile descrittivo, questo libro vuole essere complementare allo studio etnografico più generale sui kaluli di Edward L. Schieffelin, The Sorrow of the Lonely and the Burning of the Dancers. Diverse caratteristiche della vita sociale dei kaluli già discusse in quel testo son qui omesse o trattate molto brevemente» (Feld 2009: 25). E, ancora, a proposito dell’intuizione relativa agli stretti rapporti tra ecologia, suoni del mondo naturale ed espressione culturale: «Non era certo un’intuizione originale, derivata, da un lato, da anni di conversazioni con Buck e Bambi e, dall’altro lato, dalla ricerca sulla musica dei pigmei africani che avevo iniziato nei primi anni di università con Colin Turnbull» (Feld 2009: 31). Si noti che lo stesso Feld utilizza termini rilevanti dal punto di vista dialogico quali “complementare” oppure “conversazioni”.
Più in generale, ed è questa la mia ipotesi, si può aggiungere che gran parte dell’opera di Augé può essere considerata un lungo e proficuo ‘esercizio di riflessività’ applicato alle categorie dell’antropologia e al soggetto stesso che le pratica. Ricorrendo nuovamente a Wittgenstein, infine, si potrebbe pertinentemente affermare che «immaginare un linguaggio significa immaginare una forma di vita» (Wittgenstein 1967: 17). L’immaginazione etnografica (e il suo linguaggio) non fa eccezione in questo. Similmente, un principio dialogico vale pure per Steven Feld, il quale lo applica nella sua ricerca sul campo in maniera gradevolmente amplificata, coinvolgendo direttamente i suoi amici-interlocutori e se stesso in quanto antropologo e autore di una etnografia sui kaluli del Bosavi di Papua Nuova Guinea. Qui e lì nel suo splendido lavoro, in cui confluiscono diverse discipline (antropologia, estetica, linguistica, ecologia), Feld non ha nessun imbarazzo nel mettere in risalto l’apporto di amici e maestri, in dialogo con lui prima e dopo la sua esperienza di campo. Per esempio, scrive che «Sia nell’orientamento teorico sia nello stile descrittivo, questo libro vuole essere complementare allo studio etnografico più generale sui kaluli di Edward L. Schieffelin, The Sorrow of the Lonely and the Burning of the Dancers. Diverse caratteristiche della vita sociale dei kaluli già discusse in quel testo son qui omesse o trattate molto brevemente» (Feld 2009: 25). E, ancora, a proposito dell’intuizione relativa agli stretti rapporti tra ecologia, suoni del mondo naturale ed espressione culturale: «Non era certo un’intuizione originale, derivata, da un lato, da anni di conversazioni con Buck e Bambi e, dall’altro lato, dalla ricerca sulla musica dei pigmei africani che avevo iniziato nei primi anni di università con Colin Turnbull» (Feld 2009: 31). Si noti che lo stesso Feld utilizza termini rilevanti dal punto di vista dialogico quali “complementare” oppure “conversazioni”.
La questione più importante dialogicamente è tuttavia altra. Mentre Feld si trovava tra i kaluli, nel Bosavi, riceve una copia a stampa della sua etnografia sui kaluli. Incomincia a tradurre e leggere loro alcune parti del suo testo e si rende conto che le reazioni sono molte diverse e pertinenti antropologicamente, approfondendo quindi l’aspetto relativo alle loro interpretazioni della sua interpretazione affidata al testo. Insomma, il testo sui kaluli diventa il pretesto per un lavoro ulteriore sul dialogo che si instaura tra Feld e i kaluli sulla base della sua interpretazione precedente cristallizzatasi in etnografia. Questo lavoro diventerà parte integrante della seconda edizione e costituirà una vera e propria miniera di informazioni non solo sui kaluli e sul modo di considerare la traduzione, ma, anche, su quello che è un vero e proprio processo dialogico in vivo di reintrerpretazione di una cultura e di un testo etnografico che la rappresenta. Ai miei occhi, questo studio di Feld è una forma complessa di comunicazione che, con un neologismo, si potrebbe definire di autocomunicazione dialogica.
Per capirci e per infine concludere: qual è il punto, allora, al di là dell’etnografia e delle mie personali inclinazioni etnografiche? Il punto è che viviamo in un universo musicale e dialogico, inteso nel senso più ampio possibile, in cui individui – ma anche oggetti materiali e simbolici, enti più astratti e collettivi – si scambiano opinioni e punti di vista, suoni e messaggi, interagiscono per botte e risposte, storie e controstorie scritte e orali, visive e gestuali che hanno un qualche ritmo e cadenza di base. Per ritornare all’etnografia, nella mia prospettiva essa dovrebbe anche, tra le altre cose, cercare di seguire il ritmo libero, tutto sommato musicale, delle improvvisazioni e dei piani d’azione che si presentano nella vita di un individuo. Credo che questa sia una pista di ricerca fertile che potrebbe spostare l’accento dal (solo) concetto di cultura a quello di vita.
Vivere, per me, significa prodursi nell’alternanza di obiettivi che programmiamo e direzioni che prendiamo senza una preliminare preparazione, sull’orientamento del momento. Una ragione di più per parlare, quindi, in questo senso, di una vera e propria antropologia della vita. E, in tutto questo, nonostante non suoni più la chitarra e non vada più ai concerti come una volta, il mio piede continua tutt’ora a battere il tempo per suo conto sotto il tavolo mentre le dita delle mie mani invariabilmente picchiano adesso, dall’alto, sulla tastiera nera e monotona del mio innocuo portatile. Prova del fatto che, pur senza volerlo con la testa, il corpo preserva una qualche volontà d’azione, una funzione mnestica latente e diffusa fin agli alluci dei piedi e alle punte estreme dei capelli ribelli. Così, almeno, mi piace pensarla! E lo dico mentre arrivo all’Estonia Kontserdisaal, luogo in cui si terrà il concerto di Al Jarreau. Ho già il biglietto, ma devo comunque fare la coda. Non mi resta che decidere in quale delle due file inserirmi. Do una sbirciatina distratta all’una e all’altra. Quale sarà mai la meno lunga? C’è ancora tempo, però, per il concerto. Posso permettermi di improvvisare sulla base di una mia – innata? – preferenza per la sinistra e sceglierla, senza tenere conto del numero delle persone in fila. Decido. Vado a sinistra. Sono in coda. Mi rendo conto, ma è ormai troppo tardi per cambiare, che la fila è enorme.
 Mi viene in mente, senza nessuna ragione apparente, quel passaggio, molto bello, sul Rispetto di Sennett in cui l’autore parla del vibrato e dell’armonia necessaria al corpo, nella sua interezza, per ottenerlo come si deve: «Il vibrato è un movimento basculante della mano sinistra su una corda, che colora una nota attorno alla sua altezza precisa; onde di suono si diffondono nel vibrato come i cerchi prodotti da un sasso in uno specchio d’acqua. Il vibrato comincia dal gomito, passando attraverso l’avambraccio fino al palmo della mano e poi nelle dita» (Sennett 2004: 31). Il corpo ha le sue ragioni e Sennett le descrive benissimo, forse perché conosce a fondo la tecnica del vibrato per averla studiata per anni da musicista. Sennett suonava il violoncello e, per un brutto incidente alla mano, ha dovuto interrompere la carriera di musicista. È diventato comunque un famoso sociologo. A volte, penso e ripenso, mentre la fila si assottiglia e il piacere della musica si avvicina, che il caso, dall’esterno, impone una strada imprevista e spunta la capacità di libera improvvisazione che tutti noi abbiamo. Io ho deciso liberamente di smettere di suonare la chitarra per viaggiare e studiare altro. Chissà! Forse, è tempo di riprendere la chitarra in mano. Forse questo concerto di Al Jarreau è un auspicio. Forse, è così. Me ne convinco. Sono qui per questo.
Mi viene in mente, senza nessuna ragione apparente, quel passaggio, molto bello, sul Rispetto di Sennett in cui l’autore parla del vibrato e dell’armonia necessaria al corpo, nella sua interezza, per ottenerlo come si deve: «Il vibrato è un movimento basculante della mano sinistra su una corda, che colora una nota attorno alla sua altezza precisa; onde di suono si diffondono nel vibrato come i cerchi prodotti da un sasso in uno specchio d’acqua. Il vibrato comincia dal gomito, passando attraverso l’avambraccio fino al palmo della mano e poi nelle dita» (Sennett 2004: 31). Il corpo ha le sue ragioni e Sennett le descrive benissimo, forse perché conosce a fondo la tecnica del vibrato per averla studiata per anni da musicista. Sennett suonava il violoncello e, per un brutto incidente alla mano, ha dovuto interrompere la carriera di musicista. È diventato comunque un famoso sociologo. A volte, penso e ripenso, mentre la fila si assottiglia e il piacere della musica si avvicina, che il caso, dall’esterno, impone una strada imprevista e spunta la capacità di libera improvvisazione che tutti noi abbiamo. Io ho deciso liberamente di smettere di suonare la chitarra per viaggiare e studiare altro. Chissà! Forse, è tempo di riprendere la chitarra in mano. Forse questo concerto di Al Jarreau è un auspicio. Forse, è così. Me ne convinco. Sono qui per questo.
Dialoghi Mediterranei, n.13, maggio 2015
Riferimenti bibliografici
Augé M., Un etnologo nel metrò, Elèuthera, Milano, 1992 (1986)
Augé M., Il mestiere dell’antropologo, a cura di Marco Aime, Bollati Boringhieri, Torino, 2007 (2006)
Augé M., Il metrò rivisitato, Raffaello Cortina, Milano, 2009 (2008)
Bull M., Sounding out the city. Personal stereos and the management of everyday life, Berg, Oxford e New York, 2000
Feld S., Suono e sentimento, a cura di Carlo Serra, Il Saggiatore, Milano, 2009 (1990)
Feld S., Brenneis D., “Doing anthropology in sound”, American Ethnologist, Vol. 31, 4, 2004: 461-474
Geertz C., Opere e vite. L’antropologo come autore, Il Mulino, Bologna, 1990 (1988)
Lotman J. M.., Uspenskij B. A., “I due modelli della comunicazione nel sistema della cultura”, in Lotman J. M., Uspenskij B. A., Tipologia della cultura, Bompiani, Milano, 1973 (1973): 111-133
Puddephatt A. J., Shaffir W., Kleinknecht S W., Etnographies revisited. Constructing theory in the field, Routledge, Londra e New York, 2009
Sennett R., Rispetto, Il Mulino, Bologna, 2004 (2003)
Stoller P., The power of the between. An anthropological odyssey, The University of Chicago Press, Chicago e Londra, 2009
Turkle S., Il disagio della simulazione, Ledizioni, Milano, 2011 (2009)
Wittgenstein L., Ricerche filosofiche, a cura di Mario Trinchero, Einaudi, Torino, 1967 (1953)
________________________________________________________________________________
Stefano Montes, ha insegnato Letteratura francese, Antropologia Culturale e Semiotica nelle Università di Parigi, Catania, Tartu, Tallinn, Palermo e Agrigento. Al di là delle etichette disciplinari, s’interessa ai modi molteplici secondo cui dinamiche culturali organizzano forme testuali (letterarie ed etnografiche). Nelle sue ricerche, ha privilegiato le analisi delle narrazioni di vita, lo studio delle modalità di produzione della cultura in alcuni testi esemplari, l’enunciazione della soggettività nelle teorie e pratiche antropologiche. Da alcuni anni i suoi campi di interesse scientifico vertono sulle strategie di conversione religiosa e sull’esperienza turistica.
______________________________________________________________













