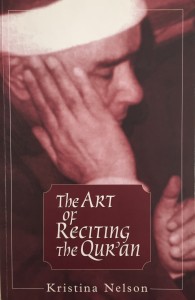di Elena Biagi
«Se avete trascorso qualche giorno sul Nilo o sulle sue rive, in prossimità di quel fiume maestoso che attraversa la città del Cairo e ritma le sue attività, senza dubbio serberete ancora il ricordo delle notti, in cui, prima dell’alba, il rumore sincopato dei rami che si tuffavano nell’acqua sotto le vostre finestre vi avrà risvegliato. Dentro un anfratto della vostra memoria, conservate il ricordo del colore associato a questo rumore: grigio liquido, arabeschi argentati di piccole gocce spruzzate dal corpo massiccio del fiume […]» (Atiya, 1985: 143).
La città del Cairo racconta la natura e le peculiarità della sua lingua: l’arabo. Città di acqua e di polvere: acque del Nilo, sabbia del deserto, pulviscolo della strada. Ogni essere o parola sono attraversati da questi elementi. L’odore dell’aria, dopo che è scivolata sull’acqua rubandone il sapore; le salmodie coraniche, che sulla superficie liquida si appoggiano, trovandone un’eco corposa e densa, per sollevarsi in un invito che è voce fluida, intonazione, preghiera; e la lingua, nella sua essenza di suono e nelle sue modalità di farsi parola.
Marginalizzato e occultato dalle nuove città in espansione, il deserto rimane luogo reale e traccia indelebile della lingua che lo ha abitato. La fonetica dell’arabo, in principio lingua di tribù di seminomadi, si costituisce infatti di una fisicità sabbiosa e calda: prevalgono fonemi consonantici, lettere velari, suoni che dalla faringe alla laringe richiedono l’emissione di un fiato (Versteegh, 1997). Aspirato, trattenuto o espulso, il respiro della lingua attraversa il corpo, sollecitandolo in un movimento interno che diviene partecipazione alla lingua stessa. Sonorità corporee, dunque, che sembrano incollarsi alle dimensioni della terra e, con essa, aderiscono alla vertigine sensuale dei sentimenti più estremi: «Hanno occupato la terra e disperso la gente, ma non sono riusciti a infrangere lo scudo di una sola delle mie lettere gutturali!» (Darwish, 2014: 128).
Il legame che la lingua araba intrattiene con la dimensione della corporeità, in particolare nella sua dimensione orale e uditiva, ci sembra assumere un ruolo significativo all’interno della riflessione qui proposta. L’attitudine al linguaggio, quale strumento di comunicazione con l’altro e, prima ancora, di espressione del Sé, è un processo individuale che si compone di molteplici fattori legati ad un’appartenenza: luogo, famiglia, società, cultura e, quale trait d’union, la lingua. Le peculiarità fonetiche dell’arabo, unite alle modalità del suo apprendimento e del suo utilizzo in quanto lingua cultuale, conferiscono un ruolo privilegiato alla dimensione estetica della lingua, e della parola, in quanto sonorità fisica ed evocativa insieme. La riflessione su alcune dimensioni e pratiche culturali interne al mondo arabo-islamico ci permetterà di evidenziare il come dell’egemonia che il significante spesso esercita sul significato: sul suono dell’arabo poggia la memorizzazione, metodo prediletto di acquisizione e di trasmissione del sapere tradizionale; attraverso la voce dell’arabo passano la percezione e l’assimilazione del testo coranico e, ancora, sono la voce e il suono della lingua a prestarsi, come vedremo, quali modalità di cura del disagio psichico, del malessere e della sofferenza.
Come acqua, la bocca si disseta alla lingua: liquido bevuto, suono incorporato. Ma, prima ancora, voce udita, ascoltata, ripetuta.
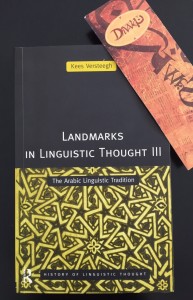 Ascolto e trasmissione del sapere
Ascolto e trasmissione del sapere
«Countless childhood memories [...] forever laced with the sounds of the Qur’an» (Haeri, 2003: IX): «Innumerevoli ricordi d’infanzia, legati per sempre ai suoni del Corano». Così Niloofar Haeri definisce il suo incontro con una lingua, l’arabo, conosciuta per la prima volta, negli anni dell’infanzia, nella sua dimensione di suono e di melodia. Persiana d’origine, essa apprendeva la lingua del testo sacro attraverso la voce del fratello e della madre, in un impatto emozionale che coinvolgeva la percezione del suono puro, al di là di ogni possibile comprensione del significato. Nei suoi viaggi da Tehrān a Boston all’Egitto, si solidificherà il legame con quella lingua udita in origine e «teneramente ed instancabilmente cullata» nella memoria (idem: 9).
Ancor prima dell’avvento dell’Islam, la dimensione orale della lingua rappresentava lo spazio privilegiato di trasmissione del sapere nelle culture arabofone. Relegata alla mera funzione legale-burocratica di “registro”, indice o trascrizione documentale, la kitāba o “scrittura” rappresentava, infatti, il sigillo fisico e simbolico di discorsi condotti oralmente: lungi dall’essere inteso come il tramite per preservare il sapere contro il cambiamento, il documento scritto fungeva da supporto di un patrimonio già custodito e garantito dall’oralità.
Al di fuori, dunque, di lettere, documenti privati o di natura “politica”, la kitāba lasciava docilmente il posto a quel primato dello “aural”, la dimensione “auricolare”, che suggestivamente, qui nell’inglese, mantiene un’assonanza emblematica con il termine “aura”. Dall’antica poesia araba alle genealogie, dai racconti tribali alle narrazioni di intrattenimento, dal materiale storico a quello di natura leggendaria, fino ai versetti della rivelazione coranica, il corpus del sapere veniva affidato al rāwī, il “trasmettitore” o “cantore” (il qāri’, nel caso del “recitatore coranico”), che se ne faceva custode e diffusore attraverso un’opera di memorizzazione e di recitazione. «Do not recite [i.e. learn] the Qur’ān from people who (merely) rely on Qur’ān codices (muṣḥafiyyūn) and do not convey knowledge (of the Ḥadīth obtained) from people who rely (only) on notebooks (ṣaḥafiyyūn)» (Schoeler, 2009: 36). É interessante notare, a conferma della “inferiorità” attribuita allo scritto rispetto alla memoria, come dalla medesima radice di “foglio” (ṣ-ḥ-f) derivi la parola araba taṣḥīf, ossia “corruzione, alterazione”. “Contro” la scrittura, prima e dopo l’Islam, oralità e ascolto venivano investiti di un’aura di quasi-sacralità, laddove la trasmissione della conoscenza non poteva che passare attraverso la voce: del poeta che recita, del maestro che espone, del discente che ascolta e ripete.
 Voci di Maestri: il suono, custode della conoscenza
Voci di Maestri: il suono, custode della conoscenza
Definibile nella sua base concettuale come una «pedagogia della recitazione» (Messick, 1996: 84), la modalità dello studio, caratterizzante ancora oggi, nelle culture arabo-islamiche, un certo approccio tradizionale al sapere, utilizza la “oral-medium formula” come strumento primario di apprendimento. Il passaggio attraverso l’oralità e la assimilazione via mnemonica ci sembrano importanti in quanto coinvolgono, a livello più ampio, il rapporto dell’individuo con la dimensione della conoscenza, nei modi della sua acquisizione, elaborazione e trasmissione.
Al riguardo, si rivela emblematica la tripartizione con cui lo studioso e giurista yemenita Muḥammad al-Shawkānī (m. 1839) descrive le tre categorie di testi più diffusamente adottati nei metodi tradizionali del darasa, o studio extra-coranico: maḥfūẓāt, “testi memorizzati”, maqrū’āt, “testi recitati” e masmū‘āt, “testi uditi” (Messick, 1996: 86-7, 91). Le tre radici linguistiche di queste tipologie testuali ruotano tutte attorno allo spazio della voce. Ḥafiẓa, “memorizzare”, deriva dalla radice del “custodire, conservare” e “proteggere”, laddove la parola udita viene iscritta internamente in un processo che attiene alla memoria, più intesa come “fissaggio nella mente” che non nei termini di un’elaborazione interiore. Testi memorizzati, dunque, spesso in modo affine a quello coranico. Accanto ad essi, i commentari o studi esplicativi del testo originale, anch’essi letti, o meglio “recitati”, dal maestro al discepolo: seppur comunemente utilizzato col senso di “leggere”, il termine qara’a include, significativamente, il campo semantico della “recitazione”, spesso ad alta voce. Dunque, nell’arabo, anche il concetto di lettura non rimanda tanto all’idea di uno spazio di silenzio o di meditazione quanto all’emissione di una voce.
Torna la voce quale oggetto di ascolto anche nella terza tipologia di testi, spesso costituiti dalle raccolte di ḥadīth o “detti profetici”, appresi per “audizione”: il mero atto dell’udire sembra qui proporsi come metodo sufficiente di acquisizione di un testo, e dunque di una conoscenza. Non casualmente, la radice del verbo sami‘a, “udire”, include nel suo campo semantico il senso dell’imparare: apprendere, per sentito dire.
Il sapere, dunque, suggestivamente passa attraverso la bocca, le orecchie, il suono della lingua: organi del corpo, forme dei sensi. Attraverso la parola vocale e udita transita la forma più legittima e autoritativa di apprendimento: dall’inizio alla fine di esso, il testo viene assimilato nella sua interezza e riprodotto nella sua consistenza; la parola è come bevuta, in una sorta di incorporazione del sapere, concetto che richiama analoghi processi di apprendimento propri della tradizione semitica ma non solo (Bourdieu, 2003).
La modalità orale e auricolare di trasmissione del sapere accentua, rendendolo indispensabile, il legame tra parola e corpo, che abbiamo già visto quale caratteristica peculiare della fisicità fonetica dell’arabo: il corpo dell’altro, ma anche il proprio corpo, cassa di risonanza della parola dell’altro. In primis, il passaggio della conoscenza necessita della presenza del maestro. Ricorre, nei resoconti sul percorso di formazione e di erudizione di un individuo, l’espressione araba bayna yadayhi, letteralmente “tra le sue mani”: dunque, non semplicemente “davanti a lui”, come traducibile in senso più lato, ma tra le mani del maestro si apprende, si studia, si impara. Espressione idiomatica sufficiente a rendere lo spazio fisico di una presenza. Sarà compito del sufismo, o misticismo islamico, rendere evidente il legame imprescindibile tra l’acquisizione di conoscenza e l’interiorizzazione, fisica e spirituale, della voce, del linguaggio, dello sguardo e del corpo stesso del maestro, nelle sue posture e nella sua gestualità, assorbiti al punto da rendere discepolo e shaykh indistinguibili (Bashir, 2011: 128):
«Ibn Bazzaz Ardabili reports that as Safi ad-Din Ardabili became closer to his master Zahid Gilani, following their initial meeting, his body began to acquire the properties of the master. Their eventual merging into each other is reflected in the verse: “Between the same veins, brain and skin, / one friend became colored with the same qualities as the other”».
Parola e corpo, nuovamente, convivono nell’identità etimologica che l’arabo attribuisce ai due termini balāgha e bulūgh, nei significati, rispettivamente, di “eloquenza linguistica” e “pubertà”. Una comune matrice, dunque, identifica il raggiungimento di una maturità fisica e sessuale con il processo di maturazione della capacità di padroneggiare la parola. Il percorso di apprendimento diviene un atto quasi fisico di assimilazione del sapere: la parola-suono tocca la pelle, chiamando ad una risposta emotiva, viscerale, prima e al di là di ogni filtro del senso.
 La voce del Corano: percorso di una lingua, storia di un testo recitato
La voce del Corano: percorso di una lingua, storia di un testo recitato
Il potere emozionale della parola araba e delle sue sonorità trova la più evidente mani- festazione nella recitazione del testo sacro: la memoria di chi viva o sia venuto a contatto col vissuto di una cultura arabo-islamica è, infatti, difficilmente slegabile dal segno del suono coranico. A livello personale o professionale, la recitazione del testo sacro è un evento intimo e familiare all’individuo e alla società. La lingua coranica, proferita o ascoltata nella voce del recitatore, diviene un atto condiviso: salmodiante e ascoltatore partecipano entrambi del potere evocativo del testo. Nell’innalzarsi esortante di un’incitazione, nell’eco vibrante di un ammonimento, nel prolungarsi della voce e nel silenzio fugace di una sua pausa, senso e suono si intrecciano, entrambi artefici del potere di quell’ iqra’ da cui la rivelazione ebbe inizio (Corano, 96: 1-5):
«Recita – iqra’- nel nome del tuo Signore che ha creato, / ha creato l’uomo da un grumo di sangue./ Recita. Il tuo Signore è il Generosissimo, / ha insegnato l’uso del calamo, / ha insegnato all’uomo quel che non sapeva».
Dall’imperativo “recita”, incipit dei primi versetti rivelati al profeta Muḥammad, prende il nome il testo sacro dell’Islam, al-Qur’ān, ossia “la recitazione”. É dunque nella recitazione salmodiata del testo che si esercita la sottile e magica seduzione del Verbo coranico, i cui contenuti sono imprescindibili dal suono della parola e dalla percezione quasi estatica che essa produce. Elemento essenziale ad entrambe le fasi della “produzione” e della trasmissione, l’oralità fu (e rimane ad oggi) prerogativa caratterizzante il testo coranico. In una sorta di sostituzione al rāwī preislamico, la trasmissione della sapienza coranica divenne privilegio del ḥāfiẓ, “colui che conosce a memoria il testo sacro”, tuttora epiteto distintivo e titolo di merito tra i musulmani.
Nei primi tempi, dunque, la Parola rivelata venne per lo più trasmessa oralmente e imparata a memoria dai discepoli; sporadici sembrano essere stati i tentativi di fissare la rivelazione, annotandola su foglie di palma, scapole di pecora o pezzi di tessuto. Solo dopo la morte di Muḥammad nel 632 d.C. divenne più pressante l’esigenza di formare un “libro”, sebbene siano ancora poco chiare le vicende attraverso le quali si giunse alla raccolta di un primo testo. Riunendo i frammenti sparsi, e sulla base di quanto era stato fedelmente memorizzato dai credenti più intimi al profeta, cominciò a prender forma la prima redazione scritta per uso privato (muṣḥaf o “raccolta di fogli”), custodita da Ḥafṣa (m. 665), figlia del secondo califfo ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb (m. 644) e vedova del profeta Muḥammad: facendo riferimento a questa redazione, nel 652 d.C. il terzo califfo ‘Uthmān ibn ‘Affān (m. 656) fece redigere la versione definitiva, o vulgata, del testo coranico. L’enfasi dell’islamistica occidentale sugli aspetti del Corano legati alla testualità, dall’esegesi alla filologia alla retorica, rivela la difficoltà diffusa nel comprendere la natura orale insita nella rivelazione coranica. Tale natura, e la relazione da essa intrattenuta con la scrittura successiva, sono invece dimensioni essenziali a costruire un’intelligenza del testo che ne riconosca le potenzialità e le peculiarità, e rappresentano la chiave di lettura di molte pratiche arabo-islamiche legate all’utilizzo del Corano e della sua lingua. Sebbene la sacralità del Libro, nella sua forma cartacea, sia spesso assolutizzata dagli stessi musulmani, ogni volta in cui si nega a mani considerate “impure” la possibilità di toccare una copia del testo, è importante ricordare che non testi bensì persone, in qualità di recitatori, vennero inviati dal profeta a diffondere il messaggio rivelato. Ciò a conferma del valore conferito alla trasmissione orale, custode fidata di un sapere, arbitro assoluto ed ultimo referente di ogni frammento di scrittura.
La prima caratteristica, su cui la natura originaria del testo coranico induce a riflettere, è quella legata alle dimensioni di fluidità, dinamicità e movimento che accompagnano la voce e la sapienza mnemonica. Il concetto di variazione è parte integrante della trasmissione della rivelazione, come dimostrano le differenti “versioni”, “varianti” e “letture” che caratterizzarono il Corano sin dalle origini (Nelson, 2001). Infatti, secondo un ḥadīth, frequentemente citato dai mistici musulmani e attribuito al noto recitatore coranico Ibn Mas‘ūd (m. 652), Muḥammad dichiarò di aver ricevuto il messaggio rivelato in sette cosiddetti aḥruf o “dialetti”, ma anche “aspetti” – awjuh – della rivelazione (Sands, 2006: 8), affinché potesse essere compreso dalle numerose tribù beduine della penisola araba; da essi derivarono, nell’VIII secolo, i sette “sistemi testuali” noti come qirā’āt o “letture”, legate ognuna ad una figura autorevole di recitatore. La possibile coesistenza di “letture”, o varianti fonetiche, si spiega con la peculiarità del sistema di scrittura arabo, che prevede un corpo per lo più consonantico della parola, diversamente leggibile a secondo della vocalizzazione. Se a ciò aggiungiamo il fatto che nel testo di ‘Uthmān la trascrizione delle lettere arabe non prevedeva la presenza dei punti diacritici, segni distintivi che permettono di diversificare grafemi altrimenti uguali, risultano inevitabili alcune considerazioni fondamentali.
Innanzi tutto, l’adattabilità dello scheletro consonantico del “primo” e ufficiale testo riconduce nuovamente alla subordinazione della scrittura rispetto alla voce ed all’oralità. Il Corano stesso, del resto, si propone non come scrittura ex novo ma come trascrizione di un archetipo celeste preesistente, già “tracciato” (masṭūr) e preservato in un’increata “Tavola ben custodita” (al-lawḥ al-maḥfūẓ, cfr. Corano, 85: 22). Tale trascrizione non vive autonomamente, poiché la kitāba si intreccia, da essa dipendendo e in essa vivificandosi, con il qur’ān, la recitazione. Scrittura e memoria, solidità e flessibilità, kitāba e qur’ān: caratteristiche che attraversano, complementari, la storia di trasmissione della sapienza araba e islamica. Infatti, in contrasto con l’irrigidimento in cui si intorpidirono ben presto l’approccio “ortodosso” al sapere e, in particolare, l’esegesi coranica, è importante osservare come, alle origini, il processo di audizione-ripetizione non si proponesse di per sé nei termini di una mera ripetizione di un sapere pre-costituito, ma lasciasse uno spazio di mobilità alla produzione del singolo. Nessun processo di de-soggettivazione caratterizzava quell’invece vivido e partecipe gioco di parti in cui il rāwī si faceva soggetto e artefice attivo del materiale trasmesso. E, come nella poesia il cantastorie correggeva errori di rima o abbelliva, così non del tutto innocuo fu il processo di trasmissione del testo coranico, laddove varianti e forme dialettali poterono agire sull’assenza in origine di un testo ufficiale e sul solo supporto di fogli contenenti il rasm o “disegno, tratto” della nuda struttura consonantica non vocalizzata. La valenza stessa dell’ascolto (samā‘) implicava infine, come abbiamo visto, la necessaria compresenza di maestro e discepolo e il diretto contatto con l’insegnante era il luogo di una trasmissione fatta di voce e di persone, di corpi, individui, soggetti. L’esacerbazione della modalità di apprendimento per memorizzazione, che caratterizzerà gran parte dello sviluppo successivo dei sistemi educativi nelle culture arabo-islamiche, porterà spesso e purtroppo ad una mortificazione di questo dinamismo originario, di cui fu ulteriore testimonianza l’originaria vitalità del pensiero interpretativo sul testo sacro.
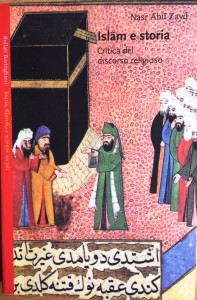 Shi‘r e shu‘ūr: la “poesia” della recitazione coranica
Shi‘r e shu‘ūr: la “poesia” della recitazione coranica
L’origine orale del Corano ci invita a riflettere sulla dimensione recitativa del testo e sull’incidenza che essa esercita da sempre nella quotidianità del musulmano. Se consideriamo le modalità della rivelazione (waḥy), così come descritte nei versetti della sūra 96, o “Sūra del grumo di sangue”, notiamo che la comunicazione tra Dio e l’uomo passa, in origine, esclusivamente attraverso l’atto del qara’a: il profeta Muḥammad è dunque il fruitore di un messaggio detto da un Altro e da lui fedelmente riprodotto. Il potere magico, incantatorio e salvifico del linguaggio coranico si esplica nel suo essere enunciato prima ancora che compreso, nel suo sedurre, incantare ed emozionare prima ancora che persuadere. Similmente, nella preghiera quotidiana (Abū Zayd, 2002) si riattualizza l’incontro uomo-Dio: non è l’orante che parla attraverso la lingua coranica, bensì la lingua coranica che parla attraverso l’orante. Garante di questo potere rimane la voce, nella recitazione come nella preghiera. Ecco allora che il Corano (17: 110) consiglia all’orante di «non alzare la voce e di non abbassarla troppo», ma di cercare «una via di mezzo», un tono intermedio che non disturbi chi prega né in qualità di recitante né in qualità di ascoltatore della sua stessa invocazione.
«Il Corano esisteva congiuntamente a Dio. Senza tempo, immutabile, perfetto. […] L’atto di ripetere le parole arabe, mentre passavano per la bocca e la gola e risuonavano nel petto, era una forma di transustanziazione: una forma di ingresso nel corpo umano di ciò che era divino. [...] I musulmani facevano passare Dio sotto forma di testo dentro e fuori la laringe».
Così lo scrittore pakistano Ali Eteraz (2009: 53) rievoca il suo incontro col testo sacro: sebbene la metodologia di insegnamento e di apprendimento del Corano, raccontata dall’autore, sia riconducibile ad una realtà storicamente e geograficamente definita, è in quel passaggio della parola attraverso il corpo che ci sembra ben espressa la modalità di trasmissione del testo fino a qui descritta. L’arabo insegnato al bambino è, sin dall’infanzia, l’arabo striato di suoni coranici, ripetuti e cantilenati, usati per cullare, confortare e ammonire; è lingua sacra e liturgica che pervade il quotidiano, chiedendo di essere «interiorizzata» prima di ogni comprensione. Da bocca a bocca passano i fonemi dell’arabo, riempiti del sapore appagante del suono, forma del senso. ‘Abīru ’l-Islām, “il profumo dell’Islam”, è il nome del protagonista del romanzo autobiografico di Eteraz: un nome che racchiude l’essenza di una lingua e della sua storia. Dalla radice di ‘abīr, “profumo”, nasce infatti la parola ta‘bīr, “espressione”, nel senso del “fare parola” di un pensiero o sentimento. La parola è dunque palpabile, inebriante quanto un profumo, vivida quanto una percezione sensoriale.
È probabile che alla base di questo processo di interiorizzazione per tramite della memorizzazione e della recitazione del testo ci sia il desiderio di ricreare ogni volta quella dimensione del meraviglioso così come vissuta e recepita dai primi auditori del Corano, quando «la ragione funzionava in un certo modo, prima dello strapotere della coscienza razionale» (Arkoun, 1982: 111). E chi meglio di un bambino può sentire il senso di questo meraviglioso, stupito e incantato da una parola che risuona nella piacevole nenia di una salmodia e che il più delle volte passa attraverso la voce dolce, suadente e confortante di una madre?
«He recites with his eyes closed, one hand tensely shaping the sound. … Suddenly the power of the phrase seizes the scattered sensibility of the crowd, focusing it, and carrying it forward like a great wave, setting the listeners down gently after one phrase and lifting them up in the rising of the next. The recitation proceeds, the intensity grows» (Nelson, 2001: XIII).
Dalla voce della madre a quella del qāri’, è pur sempre nella performance recitativa, rigorosamente in lingua araba, che il Corano svela quella miracolosa inimitabilità (i‘jāz) attribuitagli dai musulmani come caratteristica peculiare. Attraverso il salmodiante l’onda del suono ipnotizza e travolge, quale movimento fluido e incontenibile (ancora, acqua..), laddove la lingua, da cosa umana, rivendica la sua natura divina. Cortili antistanti una moschea prima della preghiera canonica, tende allestite per l’evento, inaugurazioni, ricevimenti privati o cerimonie pubbliche: i luoghi e le occasioni che si offrono alla recitazione del testo sono molteplici. Praticata per lo più da professionisti della materia, la salmodia del Corano diviene un’arte che compendia mirabilmente la sacralità di una lingua liturgica con le modalità di una pratica musicale. Il tajwīd, o l’arte della recitazione coranica secondo precise regole di pronuncia e di intonazione, diviene dunque una vera e propria tecnica, in cui acquista una certa mobilità il confine tra il linguaggio liturgico e quello più propriamente artistico: pur se percepita quale arte separata e non riducibile a possibili collocazioni, la recitazione melodica vive di un amalgama ambivalente di rito e musica, spirituale e mondano. Paradigmatico è il fatto che gli studenti del Conservatorio Musicale del Cairo imparino il tajwīd con uno studioso di scienze coraniche, al fine di migliorare pronuncia e dizione.
L’aspetto recitativo rende particolarmente evidenti le affinità del testo coranico con la poesia. Ricordiamo che gran parte della produzione letteraria nel periodo preislamico era affidata alle abilità del poeta o shā‘ir, termine arabo che, forse non casualmente, condivide la stessa radice di sha‘ara, “sentire”, nel doppio significato di “sentimento” e di “percezione sensoriale”: la parola poetica araba, infatti, vive della stessa immediatezza, tattile e insieme sfumata, della sensazione, laddove l’essere poeta si esercitava non nel carattere di scrittore o produttore letterario, bensì di improvvisatore e performatore di un’arte vocale. Perfetto padrone della lingua, lo shā‘ir improvvisava su un repertorio di formule, sfruttando appieno la peculiarità della morfologia dell’arabo, che ben si presta alla fissazione mnemonica e alla variazione su schemi sillabici (Owens, 2013). I paradigmi del passivo, del participio, del plurale, o ancora le idee di reciprocità, intenzionalità, causalità dei verbi: la lingua araba si struttura su schemi fissi, distinguibili in chiare sequenze ritmiche e cadenze vocaliche, che identificano nell’intonazione di una parola la sua specifica valenza semantica. Ci sembra importante sottolineare il legame profondo che il testo coranico intrattiene con l’arte poetica: in affinità con il linguaggio usato dall’indovino o “sacerdote”, kāhin, dell’Arabia pagana, il Corano, infatti, si esprime nel saj‘ o “prosa rimata”, che condivide con la poesia l’utilizzo della lingua attraverso quegli aspetti e strutture (versetti, rima, assonanze fonetiche, ecc …) che ne facilitano la memorizzazione.
La dimensione vocale, ritmica e sonora sottesa alla fissazione del libro sacro è dunque rilevante per comprenderne caratteristiche e usi. Da un punto di vista del contenuto, essa infatti ci fornisce una spiegazione della “discontinuità” strutturale del Corano. La non consequenzialità temporale tra le sure o “capitoli”, gli improvvisi spostamenti di soggetto, di argomenti e di atmosfere: un apparente disordine di significato sconforta il lettore non arabofono, o chiunque si accosti al Corano in traduzione, creando una diffidente “distanza” tra il testo stesso e chi spesso fatica, confuso, nell’orientamento di un senso.
Così si presenta il linguaggio coranico, quale linguaggio “umano” che si infrange in infiniti frammenti, schiacciato e manipolato dal peso irriducibile della Parola divina (Nasr, 1988: 47): «[…] human language crushed by the power of the Divine Word […] scattered into a thousand fragments like a wave scattered into drops against the rocks at sea». Sacralità e potere del testo risiedono però, ben oltre la dimensione sintattica e contenutistica, in quel qualcosa che attiene alla forma e che rende il Corano esclusivo ed intraducibile, marcandone l’originalità assoluta: il suono. Leggiamo nel racconto biografico del noto linguista egiziano Naṣr Abū Zayd (2004: 36):
«Il significato del Corano si dischiude veramente soltanto nella recitazione. Se ci si limita alla sua forma scritta si trascura l’aspetto rituale, lasciandosi così sfuggire quella che potrebbe essere definita la conoscenza estetica o sensibile della Rivelazione».
Oltre il contenuto, nell’irriproducibile peculiarità della sua forma, la lingua coranica trascina con sé chi dell’arabo conosce il sapore e quella capacità unica di mescolare significanti e significati, parole e cose. Poesia della sensazione, che tocca, pervade, conforta e guarisce. Forma perfetta, inimitabile, di per sé custode di un’integrità. Mediante il suono della lingua, nel suo potere quasi tattile ed evocativo insieme, supportato dal dogma di fede della sua origine divina, si realizza il passaggio dalla pratica recitativa del testo all’utilizzo della sua “voce” come modalità di cura.
La voce come modalità di cura: bere alla fonte del testo
Intorno alla dimensione fonetica, e successivamente anche grafica, della lingua si organizzano le modalità di “cura” del malessere, sia fisico che psichico, in molte pratiche popolari: queste ultime, infatti, prevedono di frequente l’utilizzo del testo sacro ed il ricorso alla parola coranica (Winkler, 2009).
Già agli albori dell’epoca islamica, che abbiamo visto privilegiare la dimensione non-scritta della comunicazione, il foglio impresso dei caratteri della scrittura acquisiva valenza e potere più nei termini di oggetto che di contenuto. Oggetto custodito, come i brevi scritti che suggellavano l’esito di trattati o di contratti tra le tribù e che venivano riposti spesso nella guaina di una spada; oggetto esposto, come nell’usanza di legare un documento scritto alla lama della propria sciabola; oggetto tramandato, poiché alla morte del possessore della sciabola o della guaina, il “foglio” ivi conservato veniva consegnato ai membri della famiglia. Similmente, secondo il resoconto dello storico al-Ṭabarī (m. 923), il profeta Muḥammad avrebbe tenuto un documento, sui risarcimenti pagati ai parenti di una vittima, «attaccato alla propria sciabola» (Schoeler, 2009: 17). Foglio e scrittura, dunque, venivano reificati, resi cose, emblemi di per sé di un potere, di un atto compiuto, di una decisione presa. Preludio di quello che sarà, più tardi, l’utilizzo della parola-scritta coranica quale oggetto apotropaico.
Pratica riscontrabile in ogni Paese musulmano, e permeante i più diversi strati sociali, è infatti quella di apporre nelle case riproduzioni, sotto ogni forma, di versetti del Corano. La tradizione musulmana parla di Khawāṣṣ al-Qur’ān o “Proprietà (miracolose) del Corano”, riferendosi in particolare ad alcuni versetti ritenuti possedere proprietà curative (vedi, ad esempio, le due sure conclusive, 113 e 114, note come al-mu‘awwidhatāni o “le scongiuranti”). Spesso ridotta alla funzione di un talismano scaramantico, la parola del testo, scritta su amuleti o recitata, assolve in questo caso alla funzione di oggetto magico, il cui potere curativo sussiste autonomamente e indipendentemente dalla ricezione più o meno consapevole che ne ha il fruitore. Svariate sono le pratiche di utilizzo della parola sacra riconducibili ad una simile modalità di approccio al testo. Talvolta, il “paziente” viene invitato a scrivere dei versetti coranici su un pezzo di carta o di vetro e, dopo averli immersi in acqua, a berne il liquido, incorporando in tal modo i benefici della parola divina. Ancora una volta, quale tramite di un sapere o quale mezzo di cura, la parola è precetto e medicamento che il corpo assorbe, digerisce: attraverso di essa impara, attraverso di essa guarisce.
Parole dissolte nell’acqua. Ritorna l’acqua, nella suggestiva comunanza etimologica che i termini arabi al-rāwī (“il narratore, cantore, trasmettitore”) e al-riwāya (“storia, novella, resoconto”) intrattengono con la radice del verbo rawiya, “dissetarsi” e rawā, “portare acqua” a qualcuno. Dall’etimo arabo del “dissetare” derivano anche la parola “rima” del verso poetico, così come i nomi della “fragranza”, degli aromi e delle essenze; e, ancora, il nome della “floridezza” e “pienezza” di un viso, del “lussureggiare” di un luogo, della “polpa succosa” di un frutto. Poetico e sensuale insieme, astratto e corporeo, l’atto del “narrare” (soprattutto oralmente) viene dunque già linguisticamente identificato con quello del “bere”. Dalle labbra del rāwī scorre la voce, attraverso il deserto, irrigato di parole; dalle labbra del qāri’ passa il fluido terapeutico delle virtù coraniche.
Recitazione, lettura, ripetizione mnemo- nica dei versetti, ascolto: ogni atto impastato di significante e di suono opera già da sé un effetto curativo per l’anima, per la mente e per la psiche. Se queste pratiche caratterizzano soprattutto la percezione “popolare”, in cui il confine tra magia e credenze religiose è labile e in cui il credo si mescola frequentemente con la superstizione, è interessante notare, però, come un simile presupposto animi, più o meno esplicitamente, anche alcuni approcci al disagio psichico che non si propongono come “alternativa popolare” alla cura, ma quale effettiva e “specialistica” modalità terapeutica. Lo dimostra un esperimento effettuato dallo psicologo Esaam Mohammad Zaydān e documentato in un articolo dall’eloquente titolo “The effect of joining Holy Qur’an Memorization Sessions in reduction of phobia and shyness of pupils in late childhood” (Zaydān, 2008). In conformità con quanto fino ad ora osservato, sottolineiamo come ognuna delle operazioni svolte durante l’esperimento rimandi ad una visione del testo sacro legata esclusivamente al suo aspetto formale e fonetico: se, infatti, l’adesione ai contenuti del Corano è considerata garanzia di un’integrità psichica e l’aderenza alla “retta via” viene proposta come una salvaguardia contro l’agitarsi di un malessere, è però e sempre la forma del testo a regnare incontrastata in tutte le sue dimensioni.
A conclusione della riflessione qui condotta, è indispensabile evidenziare che se, da una parte, come è stato ampiamente discusso, voce e memoria sono gli strumenti con cui il patrimonio culturale arabo si è prodotto e tramandato, sarebbe pregiudizioso dedurre che la forma, per quanto rilevante, eserciti un’egemonia assoluta sul significato, giustificando in tal modo le teorie generalizzanti di quanti affermano che l’arabofono sia più attento all’espressione che non al senso. Affermazioni a cui già si oppose energicamente il noto filologo arabo Ibn Jinnī (m. 1002), che pur in un capitolo del suo libro al-Khaṣā’iṣ (“Le caratteristiche”), dedicato all’origine della lingua, sottolineava come proprio nelle “sonorità” dell’arabo risiedesse la prova del suo essere rivelazione divina e non convenzione umana. È dunque con due riferimenti al pensiero di Ibn Jinnī che il presente contributo trova la sua migliore articolazione conclusiva, nel sottolineare come quella stessa dimensione sonora, che dell’arabo, ma non solo, è origine e bellezza, sia però al servizio, equilibrato e ordinato, del contenuto:
«Alcuni pretendono che all’origine di tutte le lingue si trovino i suoni uditi, quali l’urlo del vento, il rimbombo del tuono, il sussurro dell’acqua. […] Di qui, più tardi, sarebbero nate diverse parole. A mio avviso, quest’opinione è corretta e accettabile».
Le teorie di Ibn Jinnī, pervase di simbolismo fonetico, sono state riprese dallo scrittore e filosofo siriano Zakī al-Arsūzī (m. 1968), che sottolineò come i suoni stessi della lingua araba fossero di per sé dotati di significato (oscurità e luminosità, presenza e assenza…). Tuttavia, ciò non impedì ad entrambi di evidenziare il sottile, ma essenziale, equilibrio tra forma e contenuto, come reso evidente dal pensiero di Ibn Jinnī, là dove afferma che «l’espressione, la forma sonora […] rappresentano un mezzo, una via d’accesso a qualche cosa di assai più nobile, che è il senso», rivendicando la superiorità dell’arabo nella capacità di armonizzare senso e contenuto, espressione e aspetto sonoro (Anghelescu, 1993: 98-99).
In questi termini si propone la sfida, ancora attuale, delle culture arabo-islamiche, sospese tra una storia intrisa di oralità e un presente spesso incapace di slegarsi da un’adesione esacerbata al Testo. La lingua, quale esperienza dei sensi, chiede di essere lasciata libera di divenire esperienza del senso.
Dialoghi Mediterranei, n.19, maggio 2016
Riferimenti bibliografici
Abū Zayd, (Hāmid) Nasr (2004), Una vita con l’Islam, a cura di N. Kermani, Bologna: Il Mulino.
—- (2002), Islam e storia. Critica del discorso religioso, trad. di G. Brivio e G. Fiorentini, Torino: Bollati Boringhieri.
Anghelescu, Nadia (1993), Linguaggio e cultura nella civiltà araba, a cura di M. Vallaro, Torino: Silvio Zamorani ed.
Arkoun, Muhammad (1982), “Le merveilleux dans le Coran” in Lectures du Coran, Paris: Maisonneuve et Larose.
al-Arsūzī, Zakī (1972), Al-Mu’allafāt al-kāmila (“Opere complete”), Damasco: ‘Abd al-Ḥamīd al-Ḥasan ed.
Atiya, Nayra (1985), “Au fil du nil” in Autrement, n.12 – Février 1985: Le Caire. Des milliers d’articles de presse traduits en français, réunis en dossiér et présentés par E. Lambert et I. Vinatier. Paris: Ed. Seuil.
Bashir, Shahzad (2011), Sufi Bodies. Religion and Society in Medieval Islam, New York: Columbia University Press.
Bourdieu, Pierre (2003), Per una teoria della pratica. Con tre studi di etnologia cabila, trad. di I. Maffi, Milano: Raffaello Cortina ed.
Cardona, Giorgio Raimondo (2009), Antropologia della scrittura, Torino: UTET.
—- (2006), I sei lati del mondo. Linguaggio ed esperienza, Roma-Bari: Laterza.
Il Corano, a cura di A. Ventura (2010), Traduzione di Ida Zilio-Grandi. Commenti di A. Ventura, M. Yahia, I. Zilio-Grandi e M. Ali Amir-Moezzi, Milano: Mondadori.
Darwish, Mahmud (2014), Una trilogia palestinese, a cura di E. Bartuli, Milano: Feltrinelli.
Eteraz, Ali (2009), Il bambino che leggeva il Corano, trad. di F. Graziosi, Roma: Newton Compton ed.
Glassé, Cyril (2008) The Concise Encyclopaedia of Islam. 3rd ed. London: Stacey International.
Goody, Jack (2002), Il potere della tradizione scritta, trad. di D. Panzieri, Torino: Bollati Boringhieri.
Haeri, Niloofar (2003), Sacred Language, Ordinary People. Dilemmas of Culture and Politics in Egypt, New York: Palgrave Macmillan.
Ibn Manẓūr, Muḥammad b. Mukarram (1988), Lisān al-‘Arab, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
Massignon, Louis (2008), Il Soffio dell’Islam. La mistica araba e la letteratura occidentale, a cura di A. Celli, Milano: Medusa.
Messick, Brinkley (1996), The Calligraphic State. Textual Domination and History in a Muslim Society, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Nasr, Seyyed Hossein (1988), Ideals and Realities of Islam, Cairo: The American University in Cairo Press.
Nelson, Kristina (2001), The art of reciting the Qur’an, Cairo: The American University in Cairo Press.
Owens, Jonathan (2013), The Oxford Handbook of Arabic Linguistics, New York: Oxford University Press.
Sands, Kristin Zahra (2006), Ÿūfī Commentaries on the Qur’ān in Classical Islam, London and New York: Routledge.
Schoeler, Gregor (2009), The Genesis of Literature in Islam. From the Aural to the Read, in collaboration with and tr. by Shawkat M. Toorawa, Cairo: The American University in Cairo Press.
Versteegh, Kees (1997), Landmarks in Linguistic Thought III. The Arabic Linguistic Tradition, London and New York: Routledge.
Winkler, H. Alexander (2009), Ghost Riders of Upper Egypt. A Study of Spirit Possession, tr. by N. S. Hopkins, Cairo: The American University in Cairo.
Zaydān, Essam Mohammed (2008), “Athar al-iltiḥāq bi-jalasāt taḥfīẓ al-Qur’ān al-Karīm” (“Effetti della partecipazione a sessioni di memorizzazione del Corano Generoso”), affiancato dalla versione inglese “The effect of joining Holy Qur’an Memorization Sessions in reduction of phobia and shyness of pupils in late childhood”, in Arabic Studies in Psychology – Psychological Quarterly, vol. 7, No.3, Cairo: The Egyptian Psychological Association, July 2008: 591-636.
_______________________________________________________________________________
Elena Biagi, laureata in Lingue e Letterature Orientali presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, ha vissuto dieci anni in Egitto, dove ha conseguito il Master in Arabic Studies presso l’American University in Cairo. É docente di Lingua Araba per il Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica e Culturale e per il Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale presso l’Università degli Studi di Milano. Dal gennaio 2016 collabora anche con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, quale membro del Consiglio Direttivo e Docente Formatore per il Master di I livello “Fonti, storia, istituzioni e norme dei tre monoteismi. Ebraismo, Cristianesimo e Islam”.
________________________________________________________________