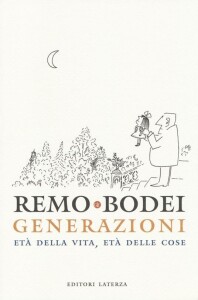CIP
di Nicolò Atzori
Nel 2015 vedeva la luce Generazioni. Età della vita, età delle cose, in cui il compianto Remo Bodei traccia una agile parabola dell’oggetto alla luce del progredire delle generazioni che progressivamente se ne servono; dove queste, non di rado, risultano connotarsi sia grazie alla loro attitudine alla reciprocità, al dono e allo scambio che in virtù di una peculiare cultura tecnico-pratica che la trasmissione intergenerazionale dei beni materiali garantisce. Il libro, insomma, è un inno involontario al valore simbolico dell’oggetto, la cui grammatica attraversa il tempo superando sé stesso e, perduto il carattere funzionale, si proietta nella dimensione della nostalgia, della musealità e, aggiungerei, della pedagogia materiale in cui antropologi e museologi vorrebbero riconoscere il senso delle collezioni: educare ad esistere.
Pochi anni dopo, nel 2017, Frank Trentmann propone una visione meno romantica dell’ipertrofia oggettuale nei cui ranghi siamo costretti, e il suo L’impero delle cose [1] tenta una critica approfondita e una restituzione storiografica della società dei consumi e dei suoi caleidoscopici esiti tecnici. Dal volume sembra emergere come il concetto di consumo, prossimo a significare il deperimento fisico, l’epilogo materiale (e d’uso) e il “finire un po’ per volta”, sembri oggi da un lato venire scavalcato dalla sostituzione di dispositivi multifunzione (prima singolarmente espletabili dallo sforzo fabbrile) e, dall’altro, dalla sovrapproduzione di supporti che trasferiscono su plastica e altri materiali inquinanti qualsiasi genere di possibilità pratico-funzionale.
Tra XVII e XX secolo, così, l’idea di consumismo si accetta come virtuosa, lasciandoci in eredità una generale rassegnazione che nell’acquisto dell’oggetto, degli oggetti, riconosce il più sublime degli atti identificanti. Qual è, mi chiedo, il peso specifico dell’etnografia visuale e del contenuto da essa prodotto per la lettura delle realtà locali e degli spazi antropici? Cosa oggetti e immagini rendono possibile percepire rispetto a quanto meramente evidente della storia di un territorio nelle plurime forme della sua cultura? Non si vuole che illustrare un esempio.
In questo modesto contributo è all’oggetto che si fa appello per così illustrare alcune suggestioni che, con un supporto fotografico relativo a contesti e materiali provenienti dal paesaggio patrimoniale di un piccolo comune sardo, ne suppongano, sul piano diacronico dell’evoluzione storica, delle direttrici di definizione culturale che si concretano nella eterogeneità delle collezioni museali e dei caratteri formativi, urbanistici e istituzionali dei luoghi che li ospitano. L’auspicio, nell’ambito analitico ed epistemologico dell’antropologia museale, è quello di assumere ciascun museo e processo di patrimonializzazione emerso quale sintesi della struttura culturale e della concezione identitaria di un dato territorio, per recuperarne pratiche, atteggiamenti, ruoli e saperi che potrebbero non avere esaurito la loro carica di produzione sociale e, perché no, d’impiego professionale.
Ho potuto conoscere meglio Sanluri, paese di poco più di 8.000 abitanti della provincia del Sud Sardegna, nell’ambito di una ricerca sul campo condotta presso alcune realtà museali del Medio Campidano, subregione annoverabile fra le aree cerealicole della Sardegna meridionale, cosiddette a “vocazione” contadina. Sanluri, in realtà, paese non lo è mai stato, e la varietà di servizi (sanitari, terziari, industriali, giudiziari) tutt’ora lo collocano come un centro dalla statura di capoluogo di provincia, anche data la ricchezza storico-istituzionale e patrimoniale che lo caratterizzano.
Simbolo del suo passato, della comunità, dello spazio urbano e della percezione esterna del paese è il castello – unico del genere ancora abitabile in Sardegna – che oggi sorge nel cuore del centro matrice: in quello spazio che, particolarmente dalla seconda metà del Trecento, risulta centrale nelle dinamiche degli ultimi scampoli del medioevo isolano, durante il quale la Sardegna, per lungo tempo, appare divisa in quattro entità politiche autonome note come giudicati. Al giudicato di Arborea, ultimo a cadere sotto i fendenti iberici in quella che si consegnerà alla storia come guerra sardo-catalana, appartenne il maniero, che (ri)costruì – in ragione di contingenti esigenze di difesa – situandolo sul confine tra questo ed il giudicato di Cagliari. La sua fama, appunto, si deve all’avere rappresentato una delle ultime roccaforti della resistenza arborense, definitivamente piegata nei primi decenni del Quattrocento dopo la cruciale battaglia del 30 giugno 1409 conosciuta anche come Sa battalla de Seddori (la battaglia di Sanluri), essendosi consumata proprio nei pressi dell’allora borgo omonimo. Sa battalla rappresenta oggi uno dei luoghi privilegiati della “rinegoziazione” dell’identità sociale, che nella forma della rievocazione storica rinnova, ogni due anni, il rapporto dei sanluresi con questo topos della genetica comunitaria [2].
In questa sede, il castello di Sanluri interessa particolarmente perché rappresenta uno dei compendi museali più importanti del paese. L’edificio è di proprietà della famiglia Villasanta, che lo acquistò agli inizi del secolo scorso nella persona del generale Nino Villasanta, il quale si preoccupò della sua ristrutturazione e alla cui volontà va attribuita la trasformazione del maestoso edificio in istituto museale, diviso in ben tre ricche collezioni che testimoniano altrettanti periodi cruciali della storia nazionale e, direttamente, di quella specificamente sarda.
Il primo e principale nucleo del museo, infatti, consiste nell’ingente donazione di cimeli sul periodo risorgimentale e la Grande Guerra fatta al generale e suo segretario dal duca d’Aosta Emanuele Filiberto di Savoia, cui lo legava una fraterna amicizia. Dopo importanti ristrutturazioni, si scelse di allestire il Museo risorgimentale “Duca d’Aosta” proprio nei locali del castello di Sanluri, già di proprietà del Villasanta e ora pronto per accogliere parte della storia del paese.
È Manuel Villasanta, nipote del gen. Nino e referente della famiglia per gli affari del castello, che mi riceve cordialmente e mi introduce al percorso, snodantesi tra le numerose sale della struttura che riuniscono, come detto, collezioni ascrivibili alla fase risorgimentale, al triennio bellico 1915-1918, al Ventennio fascista e alle vicende coloniali che legano la storia nazionale alla bruttura della prevaricazione coloniale.
Il castellano mi accoglie con grande cortesia ed entusiasmo, come si conviene a chi illustra gli sforzi di una vita e i segreti di una creatura propria. Da lui, apprendo dell’originario auspicio di suo nonno, connesso alla volontà di commemorare le gesta dei giovanissimi soldati sanluresi e sardi morti per il compimento dell’unità d’Italia e durante la Grande Guerra. Storie perdute che rivivono nella truce materialità delle armi, nella distaccata spigolosità delle suppellettili da campo e nel solenne spartito del tessuto delle uniformi, che non sanno di gloria. La guerra, amica dell’uomo nella sua evoluzione antropologica e societaria, ritorna in questo nostro tempo inquieto, e ciò che osservo ci rammenta che essa non conosce limiti geografici o sentimentali, ma nasce per ingenerare nella specie proprio la possibilità di superarli [3].
Mi dirigo al piano superiore, spazio estremamente interessante. Esso ospita, nella sala comune del castello, il nucleo della collezione sulla Seconda guerra mondiale, in cui larga parte, nella scrittura museografica, ricoprono gli oggetti relativi alla storia coloniale italiana, con particolare riferimento all’arte ed alla missione etiope. Tanti di questi oggetti rispondono ad una esigenza di accrescimento e miglioramento delle collezioni che lo stesso Manuel persegue grazie all’acquisto regolare di nuovi cimeli che vanno ad arricchire un tracciato storico e materiale già estremamente denso. La dedizione personalistica verso la collezione va nella direzione della creazione di un vero e proprio museo del colonialismo italiano, secondo un percorso etnografico di indiscussa rilevanza che alle storie testimoniate dagli oggetti vissuti aggiunge il racconto dell’esperienza di chi li ha procurati.
Non mancano gli oggetti di grande pregio e rilevanza etnologica. Per uno di questi, secondo quanto dettomi e per cui mi rimetto al giudizio degli esperti in materia di storia religiosa africana, una credenza di matrice animistica vorrebbe che, impugnando, quale manico della sciabola, l’osso di una persona che fu abile nelle armi, si otterrebbe un flusso osmotico delle capacità dell’individuo cui l’osso appartenne.
Le vicende coloniali, così apparentemente avulse, assieme alla loro cifra materiale, da quella di una modesta e lontana comunità contadina come Sanluri – conchiusa, come l’intera isola, in un tempo apparentemente ininterrotto fino alla metà dello scorso secolo – risulta invece connettere quest’ultima alla grande storia di Otto e Novecento, raccontando di destini comuni nello sconforto e nella percezione e di ponti culturali che il dramma ridimensiona. All’interno del castello, una ricca sezione testimonia la dimensione preponderante nell’economia dell’invasione: quella dell’appropriazione indebita di simboli, apparati semiotici, addirittura individui e della sostituzione culturale, non banalmente distruttiva ma che anzi riafferma la cultura oppressa nella violenta preponderanza bellica proprio attraverso la ricontestualizzazione di tali oggetti all’interno dei salotti occidentali [4].
Della missione della musealizzazione, che spesso risulta ammantata, ancora fino a qualche decennio fa, di un intrinseco bisogno di celebrazione, devono farsi carico, senza patemi, gli antropologi, che allo sforzo etnologico di comparazione e interpretazione sono chiamati, oggi più che mai, a pesare la nostra azione cosciente sul mondo.
La sede del ricordo è anche quella della commozione, e i musei sono rappresentativi di questa dualità. Uno degli oggetti più pregni di senso e inquietudine è il copricapo di un deportato italiano, membro della famiglia Villasanta, catturato dai nazisti in Albania. Il tessuto, ricavato da un sacco, reca, cuciti, una croce e dei gradi da ufficiale: ero un capitano ed ero anche cristiano, avrebbe spiegato. La dimensione agghiacciante del lager, infatti, era tale prima di tutto nei suoi intenti di spersonalizzazione ed alienazione dell’individuo, che al suo interno vedeva lacerarsi ogni sua connessione con l’esterno e la sua precedente posizione sociale. Così, quest’uomo delegò ad un copricapo consunto il compito di sancire chi fu e ciò che fece, in un disperato tentativo di riappropriazione identitaria e, aggiungerei, cosciente e coraggiosa auto-ricollocazione temporale pure nella tragedia della deportazione e della guerra, di cui si riafferma attore cruciale.
La seconda tappa del polo museale sanlurese mi riporta indietro nel tempo, quando la cultura contadina era ispessita dagli stilemi di un sostrato religioso di matrice ecclesiastica, capillarmente aggrappato al territorio nelle sue forme di radicamento cenobitico. La presenza dell’Ordine dei cappuccini ha così segnato indelebilmente e felicemente la storia della comunità sanlurese, il cui tessuto laico manifesta ancora un forte legame affettivo con i frati minori, che non cessano di rappresentare un riferimento per la comunità.
Mentre percorro la suggestiva azziada de cunventu (salita del convento, in sardo), la guida che mi illustra il contesto urbanistico precisa come l’area erbosa e floreale, ricca di aiuole, che circonda la chiesa di San Rocco, sulla destra della salita, e affianca quest’ultima, sia curata, a titolo gratuito, da un sanlurese molto affezionato ai cappuccini. Il museo storico-etnografico dei Padri Cappuccini, ad esempio, è ospitato in un settore del convento dell’ordine, in cima a un colle e la cui edificazione si fa cominciare nel 1608.
Si tratta dell’ultima realtà espositiva, in ordine di tempo, a venire formalizzata per fare parte del polo museale cittadino, sebbene la sua storia cominci intorno agli anni Settanta. Allora, la premura di frate Eliseo per la salvaguardia concreta della storia conventuale del territorio cominciò a tradursi nella pratica della raccolta – da intendersi come salvataggio – di oggetti d’uso religioso e non solo, provenienti dai diversi poli conventuali della Sardegna e dalle innumerevoli donazioni che ancora si registrano.
Alla raccolta e conseguente sistemazione museale, infatti, partecipano tantissimi sanluresi, che nel donare i loro oggetti alla causa della collezione (doppiamente) comunitaria – cittadina e cappuccina – sembrano scorgere nel nascente spazio espositivo non poche opportunità di esserci come individui e gruppi familiari e quindi di costruzione e inserimento nella storia del paese, adesso materialmente indelebile.
Alla sezione degli arredi liturgici e delle innumerevoli tipologie di manufatti d’uso sacrale presenti nel museo si affianca quella, altrettanto importante, di taglio prettamente etnografico. Nella volontà di frate Eliseo, deus ex machina del progetto organizzativo, e dei suoi collaboratori, infatti, si fa spazio l’auspicio di ricostruire e raccontare, a partire dagli oggetti, la grande diversificazione dei mestieri che scandivano la vita conventuale, dove ogni individuo era chiamato a ricoprire un ruolo preciso, con mansioni altrettanto definite. Il frate portinaio, ad esempio, che apprendo essere una delle figure imprescindibili nel convento, mi pare bene traduca il notevole razionalismo professionale che dirigeva la divisione sostenibile delle responsabilità comunitarie così come le abbiamo conosciute attraverso, appunto, la lente filosofica francescana.
La museografia del percorso espositivo non manca di sorprese. L’entusiasmo dei frati nella raccolta e dei sanluresi nel donare oggetti di proprietà che, in certo modo, potessero contribuire alla causa di un “nuovo” museo della storia del paese e oltre, infatti, bene si esemplifica, oltre che nella qualità degli oggetti d’uso, prima relegati in scantinati e cantine, nelle firme e nei testi apposti nelle loro superfici per testimoniare la presenza, nelle sale del museo dei cappuccini, del donatore, spesso indicato col cognome.
La prodigalità dei cittadini verso i frati, assieme agli intenti antiquari e narrativi di questi si sostanzia nella costruzione di veri e propri micro-circuiti materiali che, affrancando il museo dalla volontà di raccontare una spazialmente circoscritta vicenda culturale comunitaria, si fanno invece portatori dei significati storici dell’oggetto, presentato nella sua evoluzione funzionale e tecnica.
Alla collezione etnografica in senso stretto, i frati affiancano altri e nuovi oggetti che, più che offrire uno spaccato delle vicissitudini produttive quotidiane dei frati, sembrano appunto tracciare una parabola evolutiva dell’uso degli strumenti più noti e diffusi; fra cui si distinguono delle certo più modeste e religiosamente appropriate candele d’uso liturgico, assieme ai loro candelieri, accanto a lampade al led o abat-jour che raccontano, ad esempio, del nuovo uso della luce.
Una notevole collezione di strumenti radiofonici, invece, si organizza in una stanzetta angusta, che comprime gli oggetti enfatizzandone la presenza forzata in un contesto dal respiro non propriamente nazionalpopolare. Simile scelta sembra voler rispondere alle esigenze di una patrimonializzazione tanto virtuosa quanto caotica, sebbene assolutamente razionale nella sua edificante pretesa di strappare all’oblio oggetti che del cambiamento rispetto al quale cerchiamo di collocarci sono fedeli indicatori. D’altra parte, la stessa espressione utilizzata per definire questa realtà museale, che si vorrebbe “storico-etnografica”, tradisce in larga misura una pretesa onnicomprensiva di raccolta e selezione di oggetti la cui memoria, dichiaratamente, si intende preservare dalla cancellazione.
Tanti oggetti colpiscono per la loro portata e trasversalità emotiva, prove inconfutabili del bisogno di documentare, nell’impalcatura morale della restituzione etnografica dei modi di vita francescani e del cambiamento della seconda metà del Novecento, gli stessi orrori e patimenti di quel secolo. Sia d’esempio quanto segue. Quante volte abbiamo sentito e ci è stata rivolta, con non poco tono paternalistico, l’espressione “fare la gavetta”? Ebbene, la gavetta designa, appunto, un contenitore di latta o lamiera zincata o alluminio nel quale i soldati consumavano il rancio. Si riferisce, dunque, soprattutto ai soldati concretamente impegnati in guerra o nelle esercitazioni, e ha finito per identificare, metaforicamente, i gradi più umili di una carriera da percorrere per poter giungere a quelli più alti. “Fare la gavetta”, allora, assume il significato di “iniziare dal basso” e da situazioni faticose e impervie, così compiendo un periodo di, potremmo dire, “apprendistato” in attesa del perfezionamento professionale.
L’ultima delle tappe che mi sembra interessante percorrere in queste righe è il Museo del Pane, che ospita una ricca collezione etnografica di strumenti legati all’“arte plastica effimera” (Cirese) della panificazione e alla manifattura di ambito cerealicolo, magistralmente raccontata da Giulio Angioni in Sa Laurera. Il lavoro contadino in Sardegna (1976).
Al pane tipico sanlurese, una grossa focaccia che si chiama civraxiu, dall’incerta etimologia, è in parte dedicata una festa popolare nota come Festa del borgo, esistente dal 1985 e finalizzata alla “(ri)animazione” del “borgo” di Sanluri (il suo centro matrice) con attività di vario genere e, appunto dal 2017, laboratori di panificazione e momenti di degustazione del pregiato alimento [5].
Il Museo del Pane nasce anche con l’intento di fissare le fasi della lavorazione di questo alimento e della diversificazione tecno-fabbrile della produzione domestica. Qui, mi ricorda Antonella, la guida, non è raro che i visitatori si commuovano. Eppure il pane, certo, è oggi normalità, scontatezza. Invece, a vedere quanto si è perso di quei paesaggi ergologici di cui l’ambiente domestico catalizzava i gesti e di quel saper fare che a fare, appunto, obbligava, è difficile trattenere o circoscrivere i ricordi, che invece valicano portali e strade, incontrano antichi parenti e dimore, indugiando nelle fontane che ci sembrano oggi un vezzo primitivo e che, per le comunità contadine, erano salvezza.
Ospitato in una dimora storica di proprietà della famiglia Villasanta, questo museo è un’interessante realtà espositiva del polo sanlurese che ripercorre le tappe salienti della parabola della panificazione a partire dall’età protostorica e fino alla metà del secolo scorso. Spiccano oggetti di grande pregio archeologico come macine nuragiche e riproduzioni di pintaderas, particolari stampi-matrici utilizzate, fino almeno dall’eneolitico, per la decorazione del pane o dei tessuti (quando non del corpo).
Allestita in un vecchio frantoio, la collezione si presenta con una scrittura museografica essenziale ma non certo scarna, dove un impianto di murales ricorda, ad esempio, le fasi salienti della storia del territorio, che nel medioevo ha fissato le sue intenzioni identitarie.
Di nuovo, mi ritrovo all’interno di un museo dei sanluresi, da questi concretamente costruito nel bisogno di riscoprirsi o semplicemente di ricordarsi. E guai, allora, a fare restaurare il carro donato dal sig. Fiorentino cancellandone il colore azzurro; ché quello – si indigna – è il colore dei carri dei contadini sanluresi, che alle fiere e alle sagre si sarebbero così riconosciuti e di certo reciprocamente sostenuti. Magari davanti a un tozzo di pane o un bicchiere di vino.
Quanto finora illustrato intende gettare luce, certo in minima parte, sulle possibilità comunicative inespresse dei nostri musei, cari al senso comune e all’immaginario moderno ma spesso inafferrabili nella sostanza di ciò che conservano o che vogliono raccontare. Nei musei, soprattutto, scopriamo spesso di comunità che seppero costruire, mattone dopo mattone, il proprio senso nel mondo e su questo pensarsi coese. Meccaniche alle quali, a ben vedere, non sembra mai banale richiamarsi e chiedere chiarimenti.
Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023
Note
[1] F. Trentmann, L’impero delle cose. Come siamo diventati consumatori. Dal XV al XXI secolo, Einaudi, Torino, 2017
[2] https://www.prolocosanluri.eu/
[3] Si consiglia, a proposito del rapporto tra guerra e cultura, la lettura di M. Harris, Cannibali e re. Le origini delle culture, Feltrinelli Milano, 1977, che illustra una teoria solo recentemente tornata in auge nel dibattito antropologico mondiale.
[4] Cfr. G. Dore, Antropologia e colonialismo italiano. Rassegna di studi di questo dopoguerra in La cultura popolare. Questioni teoriche, in “La Ricerca Folklorica”, 1980, n. 1: 129-132.
[5] http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=158345
_____________________________________________________________
Nicolò Atzori, consegue una laurea triennale in Beni Culturali (indirizzo storico-artistico) con una tesi in Geografia e Cartografia IGM e una magistrale in Storia e Società (ind. medievistico) con una tesi in Antropologia culturale, presso l’Università di Cagliari, ottenendo in entrambe il massimo dei voti. Altresì, è diplomato presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Cagliari. Dal 2017 lavora, per conto di CoopCulture, come operatore museale e guida turistica presso il Museo Villa Abbas e il sito archeologico di Santa Anastasia di Sardara (SU), luoghi dei quali, fra le altre cose, cura la comunicazione e, nel primo caso, gli aspetti museografici. Sta frequentando il master di Antropologia Museale e dell’Arte della Bicocca.
______________________________________________________________