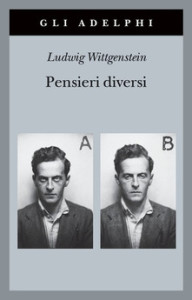Di fronte a una emergenza sanitaria come quella del coronavirus, qual è il comportamento più razionale e prudente da assumere? In base a quali criteri di giudizio il decisore politico dovrebbe prendere le proprie risoluzioni? Quali sono gli strumenti di conoscenza di cui dispone? Sono qui in gioco due principi: la scienza e la prudenza. Il primo – la scienza – ci dovrebbe indicare le soluzioni che – in base alle conoscenze scientifiche allo stato disponibili (e quindi quelle della “scienza normale”, per intenderci) – sono le più adeguate a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Il secondo – la prudenza – dovrebbe essere la virtù del decisore politico che si trova di fronte a un duplice e più complessivo compito: innanzi tutto, preferire le opzioni meno rischiose dal punto di vista sanitario, in modo da assicurare quanto più possibile la vita e la salute dei cittadini; in secondo luogo, tenere conto di tutte le altre circostanze che si legano a tali decisioni, come ad esempio le ripercussioni economiche e civili che ne possono scaturire (e tra queste soprattutto quelle che concernono la sfera delle libertà personali, garantite costituzionalmente al pari della salute), nonché le diverse sensibilità che nella popolazione si possono avere nei confronti della qualità di vita e dei sacrifici che si è disposti a sopportare in suo nome.
Per quanto riguarda il primo versante del suo intervento, il politico si trova in fondo nella stessa posizione dell’epistemologo quando deve decidere se una certa teoria o proposizione risponde ai criteri di solito richiesti affinché si abbia “conoscenza”, cioè quello di essere una “credenza vera giustificata” (secondo la definizione standard che dell’epistemologia viene fornita nei manuali). Egli si pone il compito di discriminare tra le diverse posizioni teoriche sul coronavirus (sulla sua natura e possibili terapie) e cioè di prendere posizione sulle diverse credenze in merito, cercando quale tra esse possa essere più o meno vera (almeno in senso probabilistico) e di conseguenza a giustificare (di fronte alla pubblica opinione) il proprio comportamento, ovvero le scelte che assumerà. Diversamente stanno le cose per il secondo aspetto delle sue decisioni: qui entrano in gioco fattori che concernono la scala di valori che si decide di adottare per assumere le diverse deliberazioni, valori che non sono suscettibili di una discriminazione di tipo scientifico, ma rispondono a complessive visioni del mondo (come ad es. il peso da assegnare alla libertà rispetto a quello della salute o il concetto di vita degna).
In quanto segue saranno fatte prima delle precisioni epistemologiche su che tipo di scienza abbiamo di fronte quando trattiamo del coronavirus e quindi si passerà a trattare le due descritte dimensioni della prudenza a cui è tenuto il politico: quella concernente la valutazione e utilizzazione delle acquisizioni della scienza e quella che invece amplia il proprio interesse a fattori e settori che vanno al di là della conoscenza disponibile in ambito medico e concernono più in generale il vivere civile e sociale.
Mai come in questa emergenza si è accesa la luce dei riflettori sul mondo della scienza (anche se in un suo ambito assai delimitato e peculiare, come quello medico-farmaceutico), portando alla ribalta mediatica gli “esperti”: li si è spesso invocati aspettandosi da essi l’indicazione di “parametri scientifici, oggettivi” che permettano, ad es., di riaprire le attività produttive e la fine del lockdown. Ciò spesso da parte di politici che hanno a suo tempo nutrito una certa sufficienza nei confronti dell’allarme dato dagli esperti all’inizio dell’epidemia, magari servendosi dei pareri discordanti che in seno alla comunità scientifica si sono avuti, e ancora si hanno, sulla valutazione dell’andamento pandemico, delle terapie, dei sistemi di prevenzione e di trattamento. Questo atteggiamento mette in luce un accentuato difetto di consapevolezza in merito alla natura e ai poteri della conoscenza scientifica, che viene ulteriormente aggravato dal tentativo di sovrapporle calcoli di convenienza politica, sfruttandone i margini di incertezza.
Ecco perché, prima di vedere in cosa consista la “prudenza” del politico, è necessario superare una visione ingenua e dogmatica della scienza, come anche un atteggiamento pregiudiziale di sua delegittimazione, entrambi moneta corrente in molti politici incolti. Il primo caso è tipico di chi coltiva l’idea puerile che sia possibile richiedere alla scienza soluzioni “certe” e “univoche”, quasi si trattasse di trovare la soluzione di un’equazione di secondo grado. Questo modello matematico di conoscenza scientifica è stato inculcato nella maggior parte delle persone sin dalla scuola primaria, in ossequio all’adagio antico, sempre ripetuto, che con la matematica non si scherza, che essa non fa “filosofia”: basta calcolare. È in fondo una illusione antica, tipica dei tempi “eroici” della scienza, nutrita da molti filosofi, specie dopo la rivoluzione scientifica: lo pensava, ad es., Leibniz, che voleva ridurre il sapere, e soprattutto la filosofia, a un “calculemus”; e con lui una miriade di filosofi e scienziati che hanno fatto la storia del pensiero sino all’epoca odierna e che hanno coltivato il mito di una “filosofia scientifica” [1].
Che le cose non stiano propriamente così, che la matematica non possa essere il modello di ogni conoscenza, che ad essa si dovrebbe conformare cercandone la medesima obiettività e certezza, lo sanno più che i profani, i grandi matematici come, per fare un nome, Gian Carlo Rota, che in un suo celebre articolo ha messo in luce tutti i malintesi e le illusioni di quei filosofi che ad essa si sono ispirati nel tentativo di dare “rigore” alla filosofia [2]. Ma lo si può anche constatare – per portare un altro esempio – in un recente articolo di K. Houston-Edwards, in cui si spiega come anche la matematica non sia quella scienza esatta che ci si immagina, ma un luogo pieno di incertezze, nel quale «se chiediamo a 100 matematici da dove deriva la verità di un’affermazione matematica, otterremo 100 risposte diverse» [3]. Come ha affermato icasticamente Wittgenstein, «Nessuna confessione religiosa ha tanto peccato per abuso di espressioni metafisiche quanto la matematica» [4]. Ed infatti una cosa è fornire risposte e soluzioni a questioni ben delimitate, ormai facenti parte di un sistema di conoscenze consolidato, come può essere appunto la soluzione di un’equazione o il calcolo di un limite; tutt’altra cosa è invece affrontare problemi che sono ai confini della conoscenza o che ne stanno a fondamento (come il concetto di numero o quello di “verità matematica”).
Ancora più difficile diventa il compito quando la scienza scende dalle sue astratte costruzioni e dai modelli formali (proprî di logica e matematica) per essere applicata alla concretezza dell’esperienza e confrontarsi con una realtà nella quale sono presenti moltissimi parametri, per cui i suoi modelli teorici astratti, validi in condizioni idealtipiche, devono essere interpretati e applicati con approssimazioni che cambiano a seconda di quali fattori e circostanze si ritengono più importanti. Come sanno tutti coloro che praticano la fisica e le cosiddette scienze empiriche, anche in questo caso le soluzioni “facili, oggettive, inequivoche” sono possibili solo in sistemi ideali nei quali abbiamo a che fare con pochi parametri. Aumentando gli stessi entriamo sempre più nel mondo della complessità, quel mondo che negli ultimi decenni è stato via via scoperto dagli scienziati, a partire dai fenomeni atmosferici per arrivare a quelli ancor più articolati delle interrelazioni umane. Il classico “effetto farfalla”, sempre citato, serve a darci un’idea della questione. Senza poi contare la ripercussione sociale del contagio: calcolarne diffusione, impatto, nonché prevedere le politiche da seguire con la popolazione, fa entrare in gioco una molteplicità di fattori derivanti dal comportamento di soggetti reali che agiscono in molteplici e differenti situazioni concrete, non di individui in una situazione controllata di laboratorio.
A ciò si aggiunga che in molti casi ci si trova a esplorare territori di confine per i quali non si sa sino a che punto conoscenze già consolidate e disponibili possano ancora dimostrarsi utili: noi azzardiamo, ovvero pensiamo che quanto è risultato valido in passato possa risultare altrettanto valido anche in futuro e per un fenomeno che ha analogie con quelli sinora trattati. È proprio questo il caso dell’epidemia da coronavirus: terapie e metodologie di cura che in passato sono state utilizzate con efficacia, vengono esportate e applicate a nuove varietà virali, nella speranza che anche in questi casi esse risultino efficaci. Ma, come sa ogni serio scienziato, si tratta di un azzardo che si spera possa riuscire. Non è affatto l’indicazione oggettiva e inequivoca di una soluzione: è una speranza ragionata, ma nulla esclude che le cose possano andar male, come abbiamo in effetti visto che è accaduto nella fase iniziale del coronavirus, quando le terapie messe in atto si sono dimostrate insufficienti se non errate. Per cui attendersi in tali situazioni indicazioni esatte vuol dire caricare gli esperti di un compito eccedente le loro possibilità e conoscenze e forzarli a dare soluzioni pseudo-oggettive che possono indurre in errore e in successive recriminazioni. Tale attesa di soluzioni irrealistiche è un atteggiamento puerile non solo di molti politici, ma anche di persone dotate di media cultura, che hanno avuto una formazione scientifica di tipo dogmatico e astorico e che quindi non riescono a rendersi conto della complessità del sapere scientifico.
Ma abbiamo potuto constatare in tale occasione (ma anche in passato con i no-vax e altri fenomeni del genere) anche il caso esattamente opposto: traendo argomenti sulla connaturata incertezza di ogni conoscenza scientifica, si è passati a una delegittimazione tout-court della scienza in quanto tale (in ciò “aiutati” dalla boria di qualche divulgatore scientifico e dalla sicumera di qualche esperto). Anche in questo caso si potrebbe semplicemente parlare, come di solito si fa, di ignoranza, incultura, mancanza di preparazione scientifica ecc. Sarebbe però una spiegazione parziale, perché qui entrano in gioco molti altri fattori che non possono essere sottovalutati: la diffidenza per una scienza sempre più dominata dal grande capitale e dall’interesse privato (specie in campo medico e farmaceutico – il “big pharma”), spesso rinchiusa in brevetti inaccessibili e così via. Sono tutti motivi validi per un sano scetticismo verso ciò che a volte viene diffuso come panacea (o che si impedisce di diffondere e ricercare) e che in passato si è mostrato gravemente influenzato da interessi economici; ma in una situazione come quella discussa – lo scoppio di una pandemia – che richiede rapide decisioni (e non l’avvio di una linea di ricerca scientifica), bisogna pur basarsi su qualcosa, ovvero assumere (o scommettere su) una certa conoscenza grazie alla quale agire. È prudente seguire quanto ci viene suggerito da qualche strano personaggio, o da una setta o da un medico o scienziato “fuori del coro”, da un gruppo di ricerca non accreditato o da qualche sperimentazione fatta in un paese esotico su cui non si hanno ancora esatte valutazioni e controlli? Certo, di tutto ciò è giusto tener conto, ma a bocce ferme, quando si tratta di effettuare una ricerca scientifica ed è quindi utile prendere in considerazione anche le idee a prima vista più strane. Non si può però rischiare e scommettere su di esse in casi di emergenza, quando è in ballo la vita delle persone. O almeno nessun decisore politico che segua il dettame della prudenza lo farà mai. E a ragione.
 Prudenza e politica: quale scienza e quali scienziati?
Prudenza e politica: quale scienza e quali scienziati?
Sgombrato il campo da questi due opposti atteggiamenti, entrambi errati, e riconosciuta la intrinseca incertezza della conoscenza scientifica, per cui la “credenza” lungi dall’essere senz’altro “vera”, è piuttosto incerta, “congetturale”, mai stabilita in modo definitivo e in tutti i possibili ambiti di applicazione, così come abbiamo detto è tipico delle scienze “complesse”, ci poniamo ora dal punto di vista del politico che si trova davanti una situazione nella quale si trovano spesso a confrontarsi tra gli esperti diverse opinioni. Sarebbe errato però pensare che ciò giustifichi l’idea che sia possibile una decisione meramente politica, magari andando a scegliere quell’esperto o scienziato che possa sostenere con la propria autorevolezza i pregiudizi o le convinzioni autonomamente nutriti dai politici in base alle proprie opzioni ideologiche di fondo. Non è un’ipotesi peregrina: è quanto è accaduto – e tuttora accade – con il problema del riscaldamento globale: a fronte delle migliaia di scienziati che redigono il rapporto dello Intergovernmental Panel on Climate Change, vi sono poche decine di esperti di diverso avviso, che vengono nominati consulenti da chi, per motivi economici e/o politici, non ha alcun interesse a introdurre e seguire le indicazioni dell’Ipcc. Del resto, come è ampiamente dimostrato dalla storia della scienza, vi sono sempre degli scienziati che non sono d’accordo con la visione dominante della scienza in un certo periodo.
Se le cose stanno in questi termini, allora quali opzioni ha a disposizione il “decisore politico” prudente, in modo che le sue scelte siano non frutto di arbitrio, ma adeguatamente “giustificate”? E inoltre, possono i decisori, che devono implementare delle politiche nel breve tempo, aspettare la risoluzione dei dubbi e delle divergenze tra gli scienziati e che si sia quindi pervenuti a un assetto stabile nelle conoscenze su un certo ambito? I tempi della decisione politica non sono gli stessi della ricerca scientifica, per cui il decisore politico sarà costretto o ad effettuare una scelta andandosi a cercare in modo del tutto discrezionale gli esperti da lui ritenuti più bravi (l’amico scienziato, il proprio medico di base, chi gli consiglia l’amico della stanza accanto, il collega di partito che ha una laurea in medicina, il pizzaiolo sotto casa che ha saputo da un conoscente che vive in Bangladesh…); oppure dovrà cercare di vedere chi sono le persone che nel campo interessato abbiano dimostrato e in qualche modo “certificato” di avere la maggiore competenza. In quest’ultimo caso – l’unico che merita di essere preso in considerazione – di certo il politico non potrà bandire un concorso nazionale per trovare i “migliori”: non c’è il tempo (siamo in fase di emergenza) e il problema si riproporrebbe: chi sceglie i commissari che dovrebbero scegliere gli “eccellenti”?
L’unica soluzione ragionevole è allora vedere chi siano le persone che già occupano posti di responsabilità in primari enti di ricerca o di terapia che trattano simili problematiche e che siano possibilmente di natura pubblica, per evitare conflitti di interessi. E il decisore prudente agirà in conformità a ciò, tenendo conto ovviamente anche della tara derivante dalla circostanza, non improbabile, che qualcuno occupi quel posto per motivi estranei alla sua qualificazione (ad es., per essere di una certa parte politica): si affida, in sostanza, ai meccanismi selettivi “meritocratici” che hanno portato certe persone ad occupare certi posti, specie nelle istituzioni scientifiche ed accademiche. Inoltre, consapevole del fatto che non sempre gli esperti hanno la stessa opinione, per la complessità della situazione prima richiamata, cercherà almeno di avere un numero adeguato di esperti per evitare e/o limitare il caso del singolo incompetente “esperto per caso” e così seguire l’opinione della maggioranza di loro, nella speranza che laddove c’è un parere maggiormente condiviso ci sia una più elevata probabilità che si sia nel giusto, così come di solito si fa con i consulti medici.
Ovviamente nulla garantisce che la maggioranza abbia ragione, ma di fronte alla necessità di una scelta che può comportare gravi conseguenze, il politico prudente cosa dovrebbe fare? Sarebbe imprudente e politicamente ingiustificabile se seguisse l’idea di singoli ricercatori o di una loro sparuta minoranza: non siamo qui nella fase della ricerca scientifica, quando è giusto assicurare anche alle idee divergenti la possibilità di portare avanti le proprie concezioni, perché potrebbero alla lunga dimostrarsi giuste. Qui non c’è questo “alla lunga”: come diceva Keynes, «in the long run we are all dead». Onde il politico prudente cercherà di creare – operando una mediazione tra numerosità, efficacia e rapidità – i tanto disprezzati e famosi “comitati”, come l’attuale CTS (Comitato Tecnico Scientifico) che gli possano suggerire le linee fondamentali di azione e siano in grado di prospettare diversi modelli previsionali. Questi modelli e i suggerimenti che ne derivano sono – lo sappiamo – sempre fallibili, ma ogni altra decisione in difformità sarebbe gravata da pesanti responsabilità: o quella di decidere in base a una propria valutazione, da inesperto, “a fiuto”; oppure di fidarsi di qualche altro esperto o specialista, con ciò venendosi a riproporre la questione di sopra: come lo si sceglie?
Questa già di per sé ingarbugliata situazione è ulteriormente complicata dalla circostanza che v’è chi, motivato da una sua precisa opzione ideologica, decide pregiudizialmente di non seguire quanto gli viene indicato da chi ha una posizione politica contraria alla sua e quindi pensa di fare a modo proprio e in ogni caso in modo difforme: magari, per giustificare tale dissidenza, si sceglie qualche esperto o comitato che gli propone delle modalità di azione diverse da quelle suggerite dal CTS, così come hanno fatto certi presidenti americani che, per contrastare le opinioni della maggior parte della comunità scientifica (ad es. in materia di clima), si sceglievano gli esperti tratti da qualche fondazione privata che faceva ricerche nel settore, con i finanziamenti delle corporation che avevano consistenti interessi da difendere.
Anche in questo caso le scelte sono fallibili, ma può capitare che a volte si colga il bersaglio più di altri – ad es. che la regione Veneto azzecchi più che la Lombardia. Ciò vale a dire che la procedura suggerita dal CTS debba essere abbandonata o sia stata sbagliata? O che gli esperti lombardi (escludendo, per il principio di carità, l’incompetenza e l’approssimazione degli amministratori) siano degli asini calzati? No, significa che – data la complessità della situazione – ci sono sempre margini di differenziazione e inoltre che possono essere fatte previsioni e analisi diverse nella misura in cui si tiene conto di specifiche circostanze locali. È infatti possibile che la soluzione rivelatesi efficace per una certa regione – che è dotata di certe infrastrutture sanitarie – sia invece impraticabile o deleteria in altre situazioni. E può anche darsi che una valutazione complessiva – di tipo macro-regionale – imponga delle decisioni che a livello regionale possono essere inadatte, in quanto si tiene conto di quelle interazioni tra i diversi territori che a livello locale non sono prese in considerazione. In altri termini, se ciascuna regione fosse una monade – senza alcun rapporto col resto del Paese (e del mondo) – allora potrebbe seguire la strategia ad essa più adatta e si potrebbero avere tante procedure profilattiche e terapeutiche quanto sono le regioni d’Italia. Ma così non è: i flussi di merci e persone tra le regioni non sono mai contenibili del tutto, per cui la politica più saggia è quella di una strategia complessiva e unitaria, solo all’interno della quale è concepibile e attuabile una possibile differenziazione regionale, se ritenuta vantaggiosa o quanto meno non pericolosa.
 Se quanto detto ha piena validità quando si tratti di assumere decisioni rapide in una situazione di crisi, sarebbe però un errore esiziale pensare che possa valere anche per la ricerca scientifica nel suo farsi, il cui procedere è di solito, o dovrebbe almeno esserlo, non pressato dall’esigenza di soluzioni immediate o direttamente fruibili sul piano applicativo. In questo caso, l’esistenza di ipotesi diverse, di linee di ricerca promosse da scienziati che non lavorano nel mainstream della conoscenza condivisa, che coltivino stili di pensiero diversi e anticonformistici, può tradursi in un arricchimento del dibattito e nella possibilità di pervenire a innovazioni creative. Non solo, ma la creatività è anche stimolata dal reciproco fecondarsi di linee di ricerca e persino di interessi tra loro diversi, provenienti anche dal di fuori del piano strettamente specialistico; e forse l’eccessivo affidarsi a quest’ultimo può rendere ciechi verso nuove prospettive che, come testimonia la storia della scienza, vengono a volte da riflessioni di carattere filosofico o da ispirazioni letterarie, perché in questo caso è importante avere una mente aperta, recettiva, capace di immaginare nuove prospettive e nuove possibilità e non una mentalità ristretta e solo concentrata su problemi specialistici dai confini cognitivi esattamente delimitati.
Se quanto detto ha piena validità quando si tratti di assumere decisioni rapide in una situazione di crisi, sarebbe però un errore esiziale pensare che possa valere anche per la ricerca scientifica nel suo farsi, il cui procedere è di solito, o dovrebbe almeno esserlo, non pressato dall’esigenza di soluzioni immediate o direttamente fruibili sul piano applicativo. In questo caso, l’esistenza di ipotesi diverse, di linee di ricerca promosse da scienziati che non lavorano nel mainstream della conoscenza condivisa, che coltivino stili di pensiero diversi e anticonformistici, può tradursi in un arricchimento del dibattito e nella possibilità di pervenire a innovazioni creative. Non solo, ma la creatività è anche stimolata dal reciproco fecondarsi di linee di ricerca e persino di interessi tra loro diversi, provenienti anche dal di fuori del piano strettamente specialistico; e forse l’eccessivo affidarsi a quest’ultimo può rendere ciechi verso nuove prospettive che, come testimonia la storia della scienza, vengono a volte da riflessioni di carattere filosofico o da ispirazioni letterarie, perché in questo caso è importante avere una mente aperta, recettiva, capace di immaginare nuove prospettive e nuove possibilità e non una mentalità ristretta e solo concentrata su problemi specialistici dai confini cognitivi esattamente delimitati.
Sarebbe pertanto un errore nella politica di ricerca di uno Stato finanziare solo le linee di indagine promosse all’interno di stabilizzati gruppi, guidati da scienziati già affermati, che di solito sviluppano un approccio già consolidato, che potrà sì fornire sempre nuovi risultati, ma che potrebbe essere cieco verso prospettive inedite e creative, di grande vantaggio nel risolvere problemi sinora rimasti al di fuori del campo delle conoscenze disponibili. Questo vale soprattutto quando si abbia a che fare con quelle ricerche o proposte alternative alla scienza ufficiale: sarebbe un errore capitale basarsi su di esse per assumere decisioni pubbliche, mettendo da parte la conoscenza già disponibile; ma sarebbe anche uno sbaglio non vedere in queste delle possibilità di sviluppo di linee di ricerca alternative che potrebbero portare, anche in modo imprevisto rispetto alle aspettative, a nuove utili scoperte.
Ma una precondizione di tutto questo – sia che ci si voglia affidare alla conoscenza scientifica già consolidata, sia che si voglia in parte e con misura finanziare la ricerca anticonformista – è che la politica non scopra il valore della conoscenza quando si trova già con l’acqua alla gola, in condizioni di emergenza, dopo che per decenni sono stati progressivamente ridotti i finanziamenti per la ricerca, magari affidandosi anche in questo campo al privato. Perché se il privato ha in certi settori interesse a far ricerca (si pensi all’industria farmaceutica o quella legata alla bio-ingegneria), nel contempo presenta un duplice svantaggio: i suoi investimenti sono sempre indirizzati a ciò che si pensa più redditizio in valore assoluto e nel breve termine; ed è inoltre possibile che certi prodotti vengono presentati e immessi sul mercato a seguito di controlli non adeguati, come già in passato è avvenuto.
Anche in questo l’emergenza del coronavirus è stata istruttiva per chi vuole coglierne l’insegnamento: ha dimostrato che la sanità privata – anche nelle regioni che si sono sempre portate ad esempio di “eccellenza” – ha finito per coltivare i settori terapeutici più redditizi, ovvero quelli che danno un maggior ritorno in tempi brevi (del resto perché un imprenditore dovrebbe attrezzare un ospedale o una casa di cura se non per guadagnarci?). I reparti di malattie infettive, che non rientravano nei parametri di redditività adeguata, sono stati mantenuti per lo più nelle strutture pubbliche, che hanno così subìto il maggiore onere nel fronteggiare il virus. Tutto ciò depone a favore dell’esistenza di un robusto impegno pubblico nel finanziamento della ricerca e nel mantenimento di un forte Servizio Sanitario Nazionale, in modo da garantire sia che la ricerca non sia svolta al solo fine di realizzare l’interesse delle grandi aziende multinazionali, sia che la sanità non sia rivolta ai settori che più interessano ai fini di un facile profitto.
 Prudenza e politica: quali valori garantire?
Prudenza e politica: quali valori garantire?
Ma a quanto è suggerito in ambito sanitario da scienza e prudenza e da una valutazione epistemologica delle conoscenze, di cui il decisore politico può ed è vincolato a tener conto, si aggiunge e sovrappone quel più vasto ambito di cui abbiamo parlato in esordio e che modifica e incide sulla prudenza che esso è tenuto ad esercitare, modificandone le decisioni in base alle diverse scale di valori che vengono assunte, alle diverse visioni del mondo e persino alle sensibilità politiche che ne stanno alla base. Non a caso l’attuale Presidente del Consiglio Draghi ha parlato, in occasione della decisione di procedere a delle limitate aperture, di “rischio calcolato”.
Questa espressione è stata fraintesa, ma alla luce di quanto detto essa deve essere interpretata intendendo il “rischio” come ciò che pertiene alla dimensione scientifica della valutazione e prende atto che essa ha tipicamente sempre un elemento di imprecisione e quindi di azzardo, per le motivazioni dette in precedenza; il “calcolato” (o valutato) fa invece riferimento alla dimensione politica, nelle cui decisioni entrano a far parte valori ed esigenze che fanno riferimento al complesso della vita civile del Paese e che possono essere ritenute bastevoli o meno a fare correre il rischio. Quindi non che si “calcoli” il rischio (cioè se ne dia una valutazione certa e quantificabile), ma che si è consapevoli del rischio e dell’azzardo e si decide di correrlo al fine di garantire/assicurare altri beni la cui realizzazione si ritiene – con una valutazione che non è possibile tradurre in algoritmi o di fondare in modo “scientifico”, seppure in modo approssimativo – di fondamentale importanza. Insomma, “il gioco vale la candela”.
Tuttavia si è portati spesso ad essere maggiormente sensibili alle esigenze poste in campo dalla competizione tra le diverse formazioni politiche, per cui si finisce per scegliere una certa strategia solo perché con essa si contesta quella del partito avverso o del governo politicamente non gradito. E quando a contrapporsi sono soluzioni nettamente definite sulla base delle diverse coloriture politiche – per cui tutti quelli che stanno da una parte la pensano in un modo e quelli che stanno dalla parte contraria la pensano in altro modo –, allora è chiaro che non v’è qui né scienza né prudenza, ma solo posizione di parte, faziosità pregiudiziale, ricerca di visibilità e tornaconto politico. Se infatti così non fosse, di fronte a una situazione complessa che pone diverse opzioni di scelta, queste ultime dovrebbero distribuirsi statisticamente, seguendo le diverse preferenze personali e criteri di giudizio, non addensarsi tutte intorno alle diverse posizioni politiche che esistono sul campo, seguendo fedelmente le appartenenze politiche da ciascuno professate [5].
Tali considerazioni generali, che hanno validità in ogni processo di decisione politica in cui si trovano ad essere contrapposti due punti di vista divergenti (di solito quelli di maggioranza ed opposizione), non fanno però venir meno l’opportunità di una più specifica disamina in merito ai problemi che sono stati sollevati sia per quanto riguarda la legittimità costituzionale e giuridica del comportamento messo in atto dai governi che hanno gestito la pandemia (in sostanza il Conte 2 e l’attuale governo Draghi) sia in ordine ai valori implicati nelle decisioni via via presi.
Per quanto riguarda il primo aspetto molto si è scritto, in particolare sulla base di legittimità che può essere attribuita ai Dpcm (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), da alcuni ritenuta insufficiente e invece da altri considerata fondata non solo nella Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale del 31 gennaio 2020 e nelle relative norme del Codice di protezione civile (Dlgs n. 1/2018), ma anche in una serie di decreti-legge che si sono succeduti nel periodo dell’emergenza (dal febbraio 2020 al dicembre 2020) [6]. Non voglio qui entrare nel merito di una tale controversia, che concerne a mio avviso solo il modo giuridicamente più idoneo e meno stridente con il principio di legalità al fine di garantire i valori costituzionali enunciati chiaramente dal Testo costituzionale. Faccio qui riferimento all’art. 2, con il suo richiamo alla necessità che la Repubblica garantisca «l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; e poi all’art. 16 che dà fondamento costituzionale alla limitazione – da molti lamentata – della libertà di circolazione prescritta durante il periodo pandemico: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche».
 Sicché, a mio avviso, qui non si tratta di stigmatizzare la supposta contraddizione tra quanto previsto nella Costituzione e le limitazioni alle libertà individuali messe in atto nel periodo pandemico, ma piuttosto di valutare l’idoneità della via normativa scelta dal governo per garantire princìpi parimenti riconosciuti dal testo costituzionale. È dunque questo un ambito che si presenta come attinente ad una valutazione di tipico tecnico-giuridico, sul quale non voglio e non posso entrare, anche se non si può non rilevare come le opinioni in merito si siano allineate secondo il criterio prima enunciato, ovvero secondo l’essere o meno favorevoli/appartenenti idealmente (se non di fatto) alla maggioranza di governo o all’opposizione (sicché si assiste alla singolare circostanza per cui i critici dei Dpcm emanati dal precedente governo Conte, sono ora silenti o hanno cambiato decisamente tono nei confronti di quelli emanati dal premier Draghi) [7].
Sicché, a mio avviso, qui non si tratta di stigmatizzare la supposta contraddizione tra quanto previsto nella Costituzione e le limitazioni alle libertà individuali messe in atto nel periodo pandemico, ma piuttosto di valutare l’idoneità della via normativa scelta dal governo per garantire princìpi parimenti riconosciuti dal testo costituzionale. È dunque questo un ambito che si presenta come attinente ad una valutazione di tipico tecnico-giuridico, sul quale non voglio e non posso entrare, anche se non si può non rilevare come le opinioni in merito si siano allineate secondo il criterio prima enunciato, ovvero secondo l’essere o meno favorevoli/appartenenti idealmente (se non di fatto) alla maggioranza di governo o all’opposizione (sicché si assiste alla singolare circostanza per cui i critici dei Dpcm emanati dal precedente governo Conte, sono ora silenti o hanno cambiato decisamente tono nei confronti di quelli emanati dal premier Draghi) [7].
Da un punto di vista più generale e in merito alla garanzia delle libertà individuali si deve osservare che esse non sono avulse da vincoli e «noncuranti di una concezione solidaristica della vita comunitaria. Portare la mascherina, limitare gli spostamenti, rinunciare alla movida e alle festività natalizie vengono visti alla stregua di attentati alla sfera inalienabile di ciascun singolo e non piuttosto come vincoli ragionevoli all’esercizio di un diritto o di una libertà per preservare il diritto altrettanto inalienabile alla salute e alla vita». Per cui è opportuno il richiamo al fatto che la libertà «si connota per i limiti entro cui le libertà, per essere davvero tali, vanno contenute» e di conseguenza che essa «non significa essere liberi di far ammalare gli altri» [8]. Ciò non toglie però il fatto che «in un contesto emergenziale di estrema gravità come quello che stiamo vivendo, la tutela della salute deve, comunque, avvenire nel rispetto dei princìpi costituzionali. Ciò allo scopo di evitare che la disciplina di contrasto alla crisi pandemica possa comportare uno svuotamento progressivo delle libertà costituzionali “a colpi” di Dpcm e assumere il volto di un dominio sanitario» [9].
Sia stato ciò assicurato o meno dai governi che hanno gestito l’emergenza pandemica è il frutto di diverse valutazione al limite delle technicalities giuridiche a cui si sono appassionati giuristi e politici (ma questi per motivi di opportunismo), ma che mi pare siano molto lontane dal comune modo di sentire della gente, assai più sensibile non tanto alla correttezza con cui sono prese le misure limitative, ma alle misure stesse, anche se fossero ineccepibili dal punto di vista giuridico e della legalità.
Il che ci porta sull’altro versante, che non ha più nulla a che fare con la conformità delle decisioni assunte rispetto al dettato costituzionale e al principio di legalità, ma invece concerne i valori messi in gioco – minacciati o garantiti – dalle decisioni politiche (siano esse del tutto legittime o meno). Con ciò si fa riferimento alle prese di posizione di tanti intellettuali (e tra costoro non può non ricordarsi uno così significativo come Giorgio Agamben) che hanno denunziato la c.d. “dittatura sanitaria”, il dominio di una visione impoverita e meccanicistica della vita, la riduzione e la liquidazione della dimensione affettiva insita nei rapporti sociali, l’annichilimento della ricchezza dei rapporti personali e le conseguenze psicologiche che derivano dalla necessità di adottare sistemi di comunicazione e interazione artificiosi, come avviene con la didattica a distanza in scuole e università.
Metto qui da parte l’aspetto un po’ complottistico, presente in molte delle posizioni di questo tipo, che vede l’emergenza sanitaria come una specie di grande esperimento sociale artatamente ordito da oscuri e mai ben definiti “poteri dominanti” allo scopo di schiavizzare il mondo mediante una sorta di strategia di diffusione del “terrore sanitario”, sì da giungere a una società assolutamente regolamentata; la pandemia sarebbe equiparata (con un insopportabile e continuo ricorrere a tale terminologia schmittiana) allo “stato di eccezione” per sospendere le garanzie costituzionali, in una insistita analogia con quanto fatto nel 1933 da Hitler [10]. Come anche evito di entrare nel merito – per le ragioni esposte nella prima parte di questo scritto – delle posizioni ascientifiche che parlano di “supposta epidemia”, di “cosiddetta epidemia”, di sua “invenzione”, di sua equiparazione a una più modesta e “normale influenza” [11], per invece cercare di valutare quello che mi pare il versante più serio delle critiche portate avanti da molti intellettuali. E dico subito che sono tutte critiche giuste, posizioni comprensibili e accettabili da chi pensa che i rapporti umani si nutrono di contatti personali, di interazioni anche gestuali e corporei, di abbracci, baci, strette di mano, che non sono mere circostanze esterne accidentali, ma la sostanza della relazione tra individui che non vogliono essere solo immagini su uno schermo.
Mi sembra in particolare rilevante ai nostri fini la tesi che vede nell’attuale gestione della pandemia un attacco alle libertà individuali e una riduzione della dimensione complessiva umana alla “nuda vita”. È sempre Agamben a fare da battistrada in ciò, quando in una sua importante intervista afferma che «la gente ha accettato non soltanto di rinunciare alle proprie libertà costituzionali, alle relazioni sociali e alle proprie convinzioni politiche e religiose» ma ha accettato di ridurre l’esistenza umana «a un dato biologico, a una ‘nuda vita’ che occorre salvare a qualsiasi costo […]. Quel che è avvenuto è che, attraverso un processo di medicalizzazione crescente della vita, l’unità dell’esperienza vitale di ogni individuo, che è sempre inseparabilmente insieme corporea e spirituale, si è scissa in un’entità puramente biologica da una parte e in un’esistenza sociale, culturale e affettiva dall’altra» [12].
 Potrebbe essere sufficiente quanto detto, avvertendo però che vi sono molti altri in sintonia con quanto espresso da Agamben e che – assumendo una prospettiva “universalista e olistica” – denunziano l’avvenuta pratica negazione della «complessità dell’esistenza umana»; onde «L’esistenza viene per lo più ricondotta e ridotta alla sua dimensione soltanto individuale, alla salute illusoria del singolo corpo, che non tiene conto del fatto che l’essere umano vive di una intrinseca socialità, fatta di incontri, comunicazione, trasmissione, insegnamento, apprendimento attuati dal corpotempo che vive, agisce, comunica nello spaziotempo condiviso e reale» [13].
Potrebbe essere sufficiente quanto detto, avvertendo però che vi sono molti altri in sintonia con quanto espresso da Agamben e che – assumendo una prospettiva “universalista e olistica” – denunziano l’avvenuta pratica negazione della «complessità dell’esistenza umana»; onde «L’esistenza viene per lo più ricondotta e ridotta alla sua dimensione soltanto individuale, alla salute illusoria del singolo corpo, che non tiene conto del fatto che l’essere umano vive di una intrinseca socialità, fatta di incontri, comunicazione, trasmissione, insegnamento, apprendimento attuati dal corpotempo che vive, agisce, comunica nello spaziotempo condiviso e reale» [13].
È questa una prospettiva sulla vita e sull’uomo che ha uno spessore e una dignità filosofica che non si possono di certo sottovalutare e sulla quale è difficile trovarsi in disaccordo da parte di chi – come me – ritiene tale dimensione dell’uomo e di quella che si può definire la sua “spiritualità” l’aspetto più significativo, quello che rende l’esistenza degna di essere vissuta. Ma il punto – a mio avviso – non sta tanto nel condividere o meno tale impostazione e di assumerla a propria prospettiva esistenziale; non si tratta di operare, insomma, una opzione filosofica per una certa visione del mondo e di comportarsi in coerenza con essa, seguendo magari – se si vuole – un certo itinerario di perfezionamento spirituale.
Qui abbiamo soprattutto a che fare con una dimensione pubblica e non con la scelta individuale di un singolo o di pochi il cui comportamento non incide sulla vita altrui e che pertanto sono liberi di praticare le forme di ascetismo o lo stile di vita che preferiscono. E, ancor più, siamo in presenza della necessità che il decisore politico assuma una linea di azione che non può essere motivata dalle visioni filosofico-antropologiche di alcuni intellettuali, ma deve contemperare le esigenze, i timori, le aspettative di una popolazione variegata e con visioni della vita contrastanti e spesso inconciliabili. Esso non può certo ignorare che la gran parte della popolazione è attaccata alla “nuda vita”, vuole soprattutto e in modo ossessivo salvare la propria incolumità e quella dei propri cari; ad essa non può certo dirsi che così facendo “riducono” la vita a pura materialità biologica e che per salvaguardare quella dimensione olistica che giustamente si rivendica all’esistenza umana è meglio non prendere alcuna cautela di carattere sanitario, lasciando che ciascuno faccia secondo quanto gli detta la coscienza.
Ma purtroppo questo non è possibile e ci sono moltissime persone – direi la maggior parte delle persone – che tengono innanzi tutto al proprio benessere inteso in modo “riduzionistico”, come un semplice “mantenersi in vita”. E queste persone hanno tutto il diritto a non sentirsi minacciate in questo loro sentimento, in questa loro preoccupazione puramente sanitaria, da chi invece di essa non si cura perché intende la vita in modo più completo e olistico. Questo diritto deve essere rispettato e garantito al pari di quello di chi vorrebbe vivere a modo suo, perché – come ben sa ogni buon liberale – la libertà di ciascuno trova il proprio limite nella libertà altrui; e del resto tale principio non viene posto in atto in tanti micro-settori della nostra vita quotidiana, in cui – ad es. – la nostra libertà di sentire musica ad alto volume è limitata (anche per legge o per regolamento) dalla libertà altrui di riposare in pace? Chi ha funzioni amministrative o legislative deve contemperare queste due diverse esigenze: l’elevazione spirituale che può derivare dall’ascoltare musica e l’esigenza terra terra di chi vuole solo stare in pace e dormire. Non può essere sensibile solo a una delle due: non “terrorismo o dittatura sanitaria”, dunque, ma rispetto per le sensibilità diverse sia da parte del legislatore sia da parte del singolo cittadino.
E qui entra in campo la minaccia alle cosiddette libertà fondamentali, costituzionalmente garantite. Si è visto già prima che tale libertà non può essere assoluta, che non può essere licenza di infettare gli altri; che insomma il mio comportamento deve essere tale da rispettare la sensibilità altrui e, nel caso specifico, l’esigenza fortemente sentita di non essere messo in pericolo dai comportamenti irresponsabili assunti dagli altri. Un esempio può essere fornito da quanto avviene nel corso delle lezioni nelle scuole e nelle università: come non accettare le critiche alle lezioni telematiche?
Anche io, nel corso del mio ultimo anno di insegnamento, ho fatto questa frustrante esperienza e mi sono pensionato con l’amaro in bocca di non poter vedere in carne ed ossa i miei ultimi studenti, salutandoli freddamente da un monitor. V’è però un elemento che deve essere preso in considerazione: esso sta negli “altri” che non sono presenti nella interlocuzione tra il docente e lo studente. Se potessimo isolare i protagonisti delle interazioni che hanno luogo nel corso delle lezioni in presenza e impedire loro di avere rapporti col resto del mondo, allora si potrebbe ben accettare che essi siano liberi di prendersi i rischi che vogliono, se convinti che «senza relazione tra corpi, tra sguardi, tra battute, tra sorrisi, tra esseri umani, e non tra piattaforme digitali, senza le persone vive nello spaziotempo condiviso, non esiste insegnamento, non esiste apprendimento, non esiste università» [14]. Se io avessi fatto lezione in presenza e avessi avuto più rischi di contagiarmi, avrei nutrito molti scrupoli nell’incontrarmi con mia moglie e i miei figli, col rischio di trasmettere inconsapevolmente il virus anche ad essi, con conseguenze inimmaginabili. Per cui la mia libertà a vivere più pienamente nel fare lezione si sarebbe tradotta automaticamente in un vivere meno pienamente i rapporti con i miei cari e anche con chi – conoscendo i rischi che stavo correndo – avrebbe fatto di tutto per evitarmi, a cominciare dai miei amici.
È in tali strettoie che si deve muovere il potere politico, cercando di garantire quella condizione minimale – la garanzia della “nuda vita” – che può mettere d’accordo la maggior parte delle persone. Non è possibile da parte sua far proprio quell’approccio ai problemi del coronavirus espresso da molti intellettuali, che rischia di apparire narcisistico ed egocentrico nella misura in cui si ritiene la propria concezione di qualità della vita prevalente e centrale, nonché più nobile, rispetto a quella posseduta da altri e quindi ritenuta meritevole di essere tutelata in via privilegiata da parte del potere politico. In tale caso quest’ultimo sarebbe chiamato a fare una scelta valoriale – da Stato etico: decide di privilegiare un certo ideale di “vita degna” e di garantirla, trascurando le altre opzioni e le altre visioni di vita. Si verrebbe a configurare – per sfuggire alla “dittatura sanitaria” – una vera e propria “dittatura morale”, con una legislazione che promana da una visione etica e valoriale della vita, intesa in modo olistico, indifferente a coloro che vorrebbero innanzi tutto essere rassicurati e protetti nella loro vita intesa riduzionisticamente in modo biologico.
Con ciò non si vuole negare il diritto e anche l’opportunità di un dibattito pubblico su certi aspetti della vita associata e sul valore della vita, ma solo mettere in guardia dal giudicare su tale base le politiche concrete assunte dal decisore politico o – peggio ancora – voler fare di certe opzioni etiche o religiose il fondamento della legislazione in una società pluralista e articolata. Come la storia ci testimonia, è questa la base che in passato ha segnato secoli oscuri per intolleranza, persecuzioni e guerre religiose. Sta in ciò la difficile arte della convivenza sociale, che non ci permette di essere arbitri della nostra vita come se fossimo su un’isola deserta, senza interazioni col resto dell’umanità, ma ci rende intessuti in un fitto intreccio di relazioni sociali e pertanto ci impone di rispettare le esigenze e le sensibilità altrui, senza sovrapporre ad esse le nostre opzioni filosofiche di fondo.
Dialoghi Mediterranei, n. 50, luglio 2021
Note
[1] Non posso dilungarmi su tale argomento e mi sia concesso rinviare ai molti lavori da me dedicati a tale tema, ad es. “Russell e la nascita dell’idea di filosofia scientifica”, in Filosofia, scienze, cultura, a cura di G. Bentivegna, S. Burgio e G. Magnano San Lio, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2002: 181-218; “Per la storia della filosofia scientifica. Il Circolo di Vienna e la Scuola di Leopoli-Varsavia”, in Aa.Vv., Filosofia e scienze. Studi in onore di Girolamo Cotroneo, a cura di G. Gembillo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005: 109-141; “Il pensiero infermo. Origine e destino della filosofia scientifica”, in Sulla filosofia italiana del Novecento, a cura di B. Bonghi e F. Minazzi, Franco Angeli, Milano 2008: 151-174; ecc.
[2] Cfr. G.C. Rota, Pensieri discreti, Garzanti, Milano 1993: 29-43 e passim.
[3] K. Houston-Edwards, “Il gioco dei numeri”, in Le Scienze, novembre 2019: 37.
[4] L. Wittgenstein, Pensieri diversi, Adelphi, Milano 1980: 16.
[5] Una conferma indiretta di tale comportamento è data dal gentlement agreement raggiunto tra i gruppi parlamentari l’11 marzo 2020, in occasione del voto per autorizzare lo scostamento di bilancio di venticinque miliardi di euro. «Con un accordo raggiunto all’unanimità si è deciso di garantire il conseguimento della maggioranza richiesta per tale decisione, diminuendo proporzionalmente la consistenza dei gruppi parlamentari in modo di assicurare, comunque, la presenza di 350 deputati. In tal modo, il numero ridotto di presenze in aula ha consentito di rispettare la regola del distanziamento sociale e rassicurare i parlamentari sul versante del pericolo dei contagi» (I. Nicotra, Pandemia costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli 2021: 76-77). Tale accordo ha un senso, ovviamente, se ciascun deputato non decide autonomamente, in libertà e coscienza, ma fedelmente in accordo del gruppo o partito cui appartiene. Altrimenti si potrebbero avere delle brutte sorprese.
[6] Cfr. I. Nicotra, op. cit.: 62.
[7] Si veda ad es. S. Cassese nella intervista a Omnibus del 17.05.21 – https://www.ilsussidiario.net/news/cassese-draghi-un-dpcm-e-troppi-decreti-ma-ce-dialogo-con-parlamento-fa-fatti/2172026/ – o le persistenti critiche di Giorgia Meloni (all’opposizione) (https://www.fanpage.it/politica/meloni-contro-dpcm-draghi-si-poteva-fare-decreto-legge-grave-limitare-cosi-liberta-persone/) che fanno singolare contrasto con il mutismo di Matteo Salvini (ora in maggioranza).
[8] Cfr. Nicotra, op. cit.: 12.
[9] Ivi: 70.
[10] Cfr. G. Agamben, A che punto siamo? L’epidemia come politica, Quodlibet, Macerata 2020 (ePub): 10, 14, 15, 22, ecc.
[11] Tutte queste espressioni sono rinvenibili in Agamben, op. cit.: 13, 14, 16, 18 ecc.
[12] A. Pensotti, “Where is Science Going? An Interview with Professor Giorgio Agamben”, in Organisms: Journal of Biological Sciences, vol. 4, no. 2: 106.
[13] A.G. Biuso, “Contro i negazionismi”, in Dialoghi Mediterranei, n. 47 gennaio-febbraio 2021: 519-20.
[14] A.G. Biuso, “Epidemie barbariche”, in Koiné, a. XXVII, nn. 1-4: 87.
________________________________________________________
Francesco Coniglione, già professore ordinario di Storia della filosofia all’Università di Catania, Presidente della Società Filosofica Italiana (2017-2019) e Coordinatore del Dottorato del suo Dipartimento. Si è interessato della storia della filosofia scientifica, con speciale riguardo per la scuola polacca, e ha anche condotto una ricerca sulla società della conoscenza all’interno del 7° Programma Quadro dell’EU (Through The Mirrors of Science, New Challenges for Knowledge-Based Societies, Ontos Verlag, Heusenstamm 2010). Ha pubblicato volumi e articoli sulla storia filosofia scientifica italiana, europea e polacca e sta attualmente conducendo un’ampia ricerca sull’intersezione tra razionalità scientifica e forme alternative di conoscenza, con particolare interesse per quanto è stato classificato nel campo della “irrazionalità” (misticismo, esoterismo e “rejected knowledge”). Ciò lo ha portato recentemente a confrontarsi col pensiero antico e con autori “eterodossi” rispetto alla tradizione filosofica occidentale. Tra le sue più recenti pubblicazioni v’è l’edizione italiana dei saggi dell’epistemologo polacco Ludwik Fleck: Stili di pensiero. La conoscenza scientifica come creazione sociale, Mimesis, Milano-Udine 2019.
_______________________________________________________________