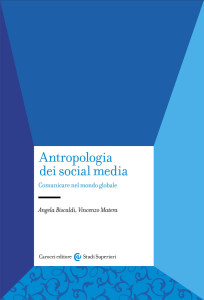Nell’ansia esasperata di parcellizzazione specialistica dei saperi e delle discipline l’antropologia culturale sembra oggi frantumarsi in mille schegge, oggetto di un’operazione di implosione e scomposizione in corrispondenza della segmentazione epistemologica delle scienze e delle plurime e frastagliate articolazioni dell’universo investigato. Dall’attenzione ai mondi remoti e in estinzione allo studio delle società globali e delle complesse realtà contemporanee, dal “giro lungo” al “ritorno a casa”, l’antropologia ha conosciuto un indubbio ampliamento dell’orizzonte di ricerca, uno sconfinamento delle frontiere, dei paesaggi e delle prospettive disciplinari, una revisione e ristrutturazione della cassetta dei suoi attrezzi. Alla pluralità delle culture a contatto e alla proliferazione delle diversità si accompagna la nascita di più antropologie, ognuna con un quadro teorico e un apparato metodologico più o meno autonomo.
Se l’architettura olistica che era a fondamento degli studi dei diversi aspetti delle culture sembra essere entrata in crisi, gli approcci degli ultimi anni si sono divaricati e moltiplicati, anche rispetto alle partizioni tradizionali e alle categorie tematiche attorno a cui era convenzionalmente organizzata la materia nella prassi e nella rappresentazione come nei modelli di scrittura e nei manuali. Parentela, linguaggio, economia, religioni e arte sono parole chiave che non sono più adeguate e sufficienti a perimetrare gli ambiti della ricerca antropologica. Non è senza significato che oggi i testi destinati agli studenti siano progettati ed elaborati secondo criteri di ordinamento eminentemente duttili e più flessibili, schemi concettuali trasversali, specificità di contenuti sempre più contigui ad altre discipline, microanalisi settoriali e inediti campi di osservazione. Dall’antropologia delle migrazioni a quella della salute, a quella museale o a quella dei processi educativi, del turismo o dello sport, dei conflitti o dei diritti, per citare solo alcune delle nuove classificazioni, la disseminazione è l’esito non soltanto di una intrinseca e oggettiva debolezza statutaria riconducibile alle origini occidentali e coloniali della disciplina, ma anche e soprattutto dell’inquieta tensione costitutiva di una scienza forse non abbastanza scienza vocata a studiare l’uomo nella diversità delle sue culture e nell’universalismo della sua natura.
La svolta “riflessiva” ha contribuito alla dissoluzione o ridimensionamento di quei paradigmi “forti” su cui si reggeva la fiducia – a volte perfino la fede – nell’oggettività dei dati conoscitivi e nella dimensione totalizzante dello sguardo sulla realtà osservata. Da qui l’imporsi di nuove denominazioni e di nuove prospettive metodologiche, a fronte della polverizzazione degli oggetti di studio e della globalizzazione dei processi culturali della vita contemporanea. Da qui il percorso di dissezione e frammentazione del concetto di cultura che altre discipline – sorelle e cugine, comunque accademicamente vicine – hanno via via mutuato, in alcuni casi rinnovandone, in altri abusandone, in altri ancora distorcendone o impoverendone il senso. Di conseguenza, quanto più divulgato e popolare è diventato questo patrimonio lessicale all’interno del discorso pubblico e del senso comune, tanto più sembra essere reificato ed essenzializzato come in una sorta di passe-partout in vario modo declinato per un uso strumentalmente politico.
 Appannate le certezze metodologiche, incrinate le verità filosofiche, tramontate le teorie novecentesche, forse nessun’altra scienza si è interrogata sulla propria identità come l’antropologia, impegnata a ripensare sé stessa, sottoposta ad un processo di “riflessione” nel duplice significato ottico e mentale, immersa in una permanente problematicità autocritica a partire dalle forme di rappresentazione etnografica fino a fare campo e oggetto di studio la stessa antropologia che spinta alla decostruzione degli a priori e degli stereotipi ideologici della contemporaneità tende a decostruire sé stessa, decentrando le pratiche etnografiche, rovesciando le vecchie dicotomie, aggredendo l’antropocentrismo e, nello stesso tempo, rimettendo al centro la natura umana, privilegiando la soggettività, l’introspezione autobiografica, le connessioni tra saperi, l’attenzione alle esperienze esistenziali più intime, ai temi del corpo, dei sensi, delle emozioni e dell’immaginazione.
Appannate le certezze metodologiche, incrinate le verità filosofiche, tramontate le teorie novecentesche, forse nessun’altra scienza si è interrogata sulla propria identità come l’antropologia, impegnata a ripensare sé stessa, sottoposta ad un processo di “riflessione” nel duplice significato ottico e mentale, immersa in una permanente problematicità autocritica a partire dalle forme di rappresentazione etnografica fino a fare campo e oggetto di studio la stessa antropologia che spinta alla decostruzione degli a priori e degli stereotipi ideologici della contemporaneità tende a decostruire sé stessa, decentrando le pratiche etnografiche, rovesciando le vecchie dicotomie, aggredendo l’antropocentrismo e, nello stesso tempo, rimettendo al centro la natura umana, privilegiando la soggettività, l’introspezione autobiografica, le connessioni tra saperi, l’attenzione alle esperienze esistenziali più intime, ai temi del corpo, dei sensi, delle emozioni e dell’immaginazione.
Quelle che un tempo si chiamavano subculture nell’orizzonte dell’antropologia applicata diventano e si chiamano culture tout court, con riconoscibili profili identitari che hanno il loro centro di gravità in spazi e traiettorie transdisciplinari Sono entrati così nell’antropologia dell’antropologia mondi storicamente espunti, rimossi, emarginati dalla letteratura degli studi, sensibilità che si ritenevano naturali o afferenti esclusivamente alla biologia, fenomeni di creativa ibridazione simbolica, questioni di bioetica e di cruciale attualità nel dibattito pubblico, inedite prospettive ermeneutiche che nel riaffermare il ruolo fondamentale della cultura dispiegano nuovi orizzonti conoscitivi tra il locale e il globale, tra identità e alterità, tra umano e postumano, tra artificio tecnologico e dato naturale, tra reale e virtuale ovvero tra offline e online. Dalle cronache quotidiane salgono le voci di un presente incerto ma già gravido del futuro che attende di essere capito prima di essere gestito. Non v’è dubbio, per esempio, che l’uso e il destino delle tecnologie mediatiche e digitali nella vita di individui e comunità, incarnate nelle parole e nei gesti degli uomini e delle donne del nostro tempo, sono diventati materia di grande rilevanza antropologica. Tanto più che la comunicazione nei suoi diversi linguaggi – risorse, canali, codici, segni – è fatto connaturale e consustanziale della cultura, di tutte le culture in quanto parte costitutiva e distintiva dell’uomo e del suo modo peculiare e universale di esistere e di essere nel mondo.
Dal principio ampiamente acclarato che enuncia in tutta evidenza che «la comunicazione è cultura» e che «non c’è cultura senza comunicazione» discende la consapevolezza del carattere sistemico della comunicazione, che non è mai «completamente naturale» né mai neutra. Da qui muove il percorso di riflessione che Angela Biscaldi e Vincenzo Matera propongono nel libro Antropologia dei social media. Comunicare nel mondo globale (Carocci 2019). Uno studio che introduce nell’esplorazione di quella particolare forma di comunicazione che fa uso dei media digitali diffusi e penetrati fin nelle più intime profondità degli spazi e dei tempi della nostra vita quotidiana. Una ricerca etnografica che tende a verificare le dinamiche sociali e gli effetti nei processi cognitivi e nelle relazioni di potere indotti dai cosiddetti new media.
 Quando il buon Marx scriveva che «la produzione produce non soltanto un oggetto per il soggetto, ma anche un soggetto per l’oggetto», non pensava certo al mercato della comunicazione così come oggi si presenta, con i media che per la loro incontrollata pervasività sembrano essersi trasformati nella famosa e paradossale mappa realizzata dai cartografi di Borges, tanto grande da coprire l’intero impero quanto impossibile da dispiegare e perciò inutilizzabile e inintelligibile. La potenza delle nuove tecnologie ha creato una tale massa di immagini, visive e sonore, da costruire infinite e nuove realtà fino al punto da sovrapporsi alla realtà esistente, fino al punto da sostituirla. Se il mondo si frantuma in uno straordinario caleidoscopio di immagini e le immagini diventano mondo, al progressivo assottigliarsi della materialità della realtà si accompagna una deprivazione dei sensi e del sentire, una rarefazione delle percezioni fisiche ed esperienziali, «il progressivo affievolirsi – fino a scomparire – del confine che separa la vita online da quella offline». Così che, nell’orizzonte di questa cultura mediatica, si rende sempre più indistinguibile la vita vera dalla sua simulazione, la verità dalla sua manipolazione artificiale. La rappresentazione offerta oggi dai social media tenderebbe a plasmare i suoi fruitori sul modello degli alfabeti ovvero delle forme, delle tecniche e delle icone che produce e mette sul mercato.
Quando il buon Marx scriveva che «la produzione produce non soltanto un oggetto per il soggetto, ma anche un soggetto per l’oggetto», non pensava certo al mercato della comunicazione così come oggi si presenta, con i media che per la loro incontrollata pervasività sembrano essersi trasformati nella famosa e paradossale mappa realizzata dai cartografi di Borges, tanto grande da coprire l’intero impero quanto impossibile da dispiegare e perciò inutilizzabile e inintelligibile. La potenza delle nuove tecnologie ha creato una tale massa di immagini, visive e sonore, da costruire infinite e nuove realtà fino al punto da sovrapporsi alla realtà esistente, fino al punto da sostituirla. Se il mondo si frantuma in uno straordinario caleidoscopio di immagini e le immagini diventano mondo, al progressivo assottigliarsi della materialità della realtà si accompagna una deprivazione dei sensi e del sentire, una rarefazione delle percezioni fisiche ed esperienziali, «il progressivo affievolirsi – fino a scomparire – del confine che separa la vita online da quella offline». Così che, nell’orizzonte di questa cultura mediatica, si rende sempre più indistinguibile la vita vera dalla sua simulazione, la verità dalla sua manipolazione artificiale. La rappresentazione offerta oggi dai social media tenderebbe a plasmare i suoi fruitori sul modello degli alfabeti ovvero delle forme, delle tecniche e delle icone che produce e mette sul mercato.
I media, però, non sono mostri tecnologici e gli utenti non sono passivi recettori e meccanici esecutori dei loro messaggi. Troppo semplicistica e “unidimensionale” è la classica tesi della scuola di Francoforte che considerava i consumatori inermi e disarmati nella loro oggettiva dipendenza dai “persuasori occulti” della comunicazione. E non meno riduttiva e manichea è la radicale dicotomia apocalittici/integrati che sull’interpretazione di Umberto Eco ancora oggi divide i catastrofisti delle nuove tecnologie da un lato e gli entusiasti che ne celebrano i fasti dall’altro. Nel ripercorrere la storia dei dibattiti via via aperti dall’introduzione di nuovi mezzi di comunicazione – dalla scrittura alla stampa, dagli audiovisivi al web – Biscaldi e Matera ritrovano negli atteggiamenti degli intellettuali come nel senso comune collettivo questa costante divaricazione tra pessimisti e ottimisti, tra la visione aristocratica e allarmistica degli uni e quella fideistica e apologetica degli altri, tra angosciose paure e miti esaltanti, tra distopie e utopie. Comune ad entrambe le opposte posizioni sarebbe una sorta di “determinismo tecnologico” che attribuisce al medium il potere automatico e unidirezionale di generare effetti sugli utenti indipendentemente dalla loro volontà. Gli autori, pur nella consapevolezza della oggettiva forza di sempre maggiore intrusività dei mezzi di comunicazione, non rinunciano tuttavia a sottolineare il ruolo centrale della soggettività, della agentività, la capacità decostruttiva e creativa che agli individui va comunque riconosciuta, così che è giusto chiedersi non soltanto «cosa i media fanno alle persone» ma anche «cosa le persone fanno con i media».
 Un medesimo interrogativo si era posto Matilde Callari Galli quindici anni fa nella sua ricerca etnografica sull’uso della televisione da parte dei bambini e sull’uso dei bambini da parte della televisione (La TV dei bambini, i bambini della TV, Bonomia Universiy Press, Bologna 2004), avendo posto l’attenzione sui meccanismi che presiedono alle interazioni tra il livello dell’emissione e quello della recezione dei messaggi, sui delicati e complessi processi di costruzione e di decodifica dei programmi, analizzati come “testi” che possono essere «letti e interpretati quali prodotti e pratiche culturali create ed elaborate sia dai loro ideatori e produttori sia dai piccoli fruitori cui erano rivolte». Davanti al consumo infantile della TV la studiosa osservava «una precoce, e per certi aspetti sorprendente, alfabetizzazione dei bambini al mezzo», una inedita competenza metatestuale che consentiva loro di disporsi non come spettatori acritici e passivi ma piuttosto come soggetti reattivi, disincantati e smaliziati e, in certi casi, creativi. Sotto lo sguardo dell’antropologa i piccoli interagivano con la realtà rappresentata dallo schermo, la manipolavano, la trasformavano, iscrivendo la propria azione in un rapporto di circolarità tra testo e contesto.
Un medesimo interrogativo si era posto Matilde Callari Galli quindici anni fa nella sua ricerca etnografica sull’uso della televisione da parte dei bambini e sull’uso dei bambini da parte della televisione (La TV dei bambini, i bambini della TV, Bonomia Universiy Press, Bologna 2004), avendo posto l’attenzione sui meccanismi che presiedono alle interazioni tra il livello dell’emissione e quello della recezione dei messaggi, sui delicati e complessi processi di costruzione e di decodifica dei programmi, analizzati come “testi” che possono essere «letti e interpretati quali prodotti e pratiche culturali create ed elaborate sia dai loro ideatori e produttori sia dai piccoli fruitori cui erano rivolte». Davanti al consumo infantile della TV la studiosa osservava «una precoce, e per certi aspetti sorprendente, alfabetizzazione dei bambini al mezzo», una inedita competenza metatestuale che consentiva loro di disporsi non come spettatori acritici e passivi ma piuttosto come soggetti reattivi, disincantati e smaliziati e, in certi casi, creativi. Sotto lo sguardo dell’antropologa i piccoli interagivano con la realtà rappresentata dallo schermo, la manipolavano, la trasformavano, iscrivendo la propria azione in un rapporto di circolarità tra testo e contesto.
Alla medesima prospettiva volta a rimescolare le carte aggiungendo variazioni e sfumature alla complessità dell’analisi del fenomeno mediatico, si riconnette per molti aspetti l’etnografia dell’esperienza dei media digitali condotta da Biscaldi e Matera, che nelle pagine finali del libro raccolgono i risultati di una ricerca su rappresentazioni e pratiche di un gruppo di studenti di un liceo artistico multimediale di Crema in Lombardia. Sottoposti per una settimana alla prova di astensione dai social come «strumento per stimolare la riflessività», i giovani hanno denunciato disagi e difficoltà, scoprendo la dipendenza dal loro uso, la frequentazione della rete come tempo pieno e consustanziale della quotidianità, la connessione continua al grande flusso (always on) come compulsiva ricerca di relazioni e «occupazione di ogni spazio vuoto». A fronte di un contesto attraversato da precarietà, mobilità, instabilità e competitività, in corrispondenza di un mondo e un mercato che chiedono prestazioni efficienti, flessibili, veloci e performanti, le nuove generazioni si dibattono tra individualismo e strategie personalizzate di contatti e legami plurimi attraverso l’appartenenza multipla a diversi network.
In questa sfida lo smartphone è – come è noto – qualcosa di più di uno strumento utile e portatile, essendo incorporato nell’identità e “naturalizzato” nello stile e nei ritmi di vita, investito di molteplici funzioni simboliche, potenzialmente dotato di versatili risorse espressive. Per moltissimi giovani è cosmos e logos, luogo di produzione e irradiazione di reticoli sociali più o meno liquidi e di intense dinamiche culturali, spazio dell’immaginario che include o esclude, veicolo di iniziazione e di appartenenza al gruppo dei pari. Quanto la saturazione tecnologica possa provocare un impatto disfunzionale sulle loro fragili esistenze, quanto la connessione possa surrogare la loro partecipazione esperienziale, il pulviscolo dei contatti e dei segnali rimuovere la trasmissione di reali messaggi e impedire concrete interazioni, è questione ampiamente dibattuta e aperta a soluzioni e interpretazioni diverse.
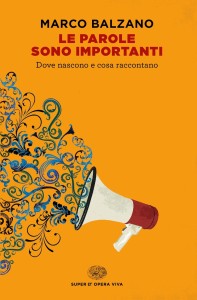 Se nella piazza virtuale l’amicizia non si fa ma si dà, non si costruisce ma si richiede, se – come ha scritto Marco Balzano nel suo recente libro Le parole sono importanti (Einaudi 2019) – «condividere un file, un’immagine, un testo è il contrario di dividere con qualcuno», poiché «la condivisione del web è in realtà una moltiplicazione che fa i conti con nessuna sottrazione», allora sarà bene ripensare criticamente la grammatica dei media, studiarne la semiotica laddove sembra prevalere il segno sul senso, la funzione fàtica su quella referenziale. Da qui i messaggi apparentemente vuoti di contenuti semantici e poveri di pensiero, con il ricorso alle cosiddette emoticons, e con lo scopo primario di assicurare e confermare il contatto, rassicurare, secondare, testimoniare o semplicemente “socializzare”. Da qui anche la dimensione performativa della comunicazione digitale che esercita un potere, inimmaginabile fino a qualche anno fa, sulle nostre azioni e sulle pratiche cognitive e percettive.
Se nella piazza virtuale l’amicizia non si fa ma si dà, non si costruisce ma si richiede, se – come ha scritto Marco Balzano nel suo recente libro Le parole sono importanti (Einaudi 2019) – «condividere un file, un’immagine, un testo è il contrario di dividere con qualcuno», poiché «la condivisione del web è in realtà una moltiplicazione che fa i conti con nessuna sottrazione», allora sarà bene ripensare criticamente la grammatica dei media, studiarne la semiotica laddove sembra prevalere il segno sul senso, la funzione fàtica su quella referenziale. Da qui i messaggi apparentemente vuoti di contenuti semantici e poveri di pensiero, con il ricorso alle cosiddette emoticons, e con lo scopo primario di assicurare e confermare il contatto, rassicurare, secondare, testimoniare o semplicemente “socializzare”. Da qui anche la dimensione performativa della comunicazione digitale che esercita un potere, inimmaginabile fino a qualche anno fa, sulle nostre azioni e sulle pratiche cognitive e percettive.
Sui profondi mutamenti introdotti dalla rete e dall’uso di facebook e tweet si è ormai prodotta un’ampia letteratura per lo più impegnata a mettere in guardia dai rischi impliciti nella cieca e ingenua delega all’assolutismo della tecnologia che può degenerare nel cosiddetto autismo elettronico di cui ha scritto Castells, quando alle solitudini della vita offline si supplisce con l’illusorio riparo nella comunità online, alla frustrante condizione di spaesamento si sopperisce con il morboso gioco del multitasking. La permanente autoesposizione che, nel renderci accessibili giorno e notte, cancellando ogni cesura tra tempo libero e tempo di lavoro, tra pubblico e privato, vale a notificare e certificare nel cyberspazio la nostra stessa esistenza, può trasformare i social network in campi di onnipresente sorveglianza digitale volontaria, in spazi privilegiati di una vera e propria «società della confessione», come l’ha definita Zygmunt Bauman. La reinvenzione di una sorta di «occhio di Dio che tutto vede», per usare le parole del filosofo Maurizio Ferraris.
 Di questa letteratura, per lo più sociologica, le pagine di Biscaldi e Matera offrono una utile e vasta rassegna, riletta e declinata in una prospettiva eminentemente antropologica. A partire dalle parole chiave del lessico etnografico, dai concetti di campo, comunità, appartenenza, identità, memoria. Cancellato il confine che separa l’essere là e l’essere qui, caduta l’interazione faccia a faccia, dissolto il radicamento territoriale nella liquidità della rete, il campo che è da sempre il luogo gravitazionale dell’antropologia non evapora né scompare ma muta le sue caratteristiche, essendo «un costrutto fluido, emergente e non delimitabile entro dimensioni fisse, offline o online». L’ubiquità e la simultaneità con cui sono abitati e partecipati i due universi – la realtà della vita vera e la virtualità della vita digitale – concorrono a formare comunità complementari e interscambiabili, non essendoci alcuna discontinuità, secondo l’ovvio e troppo spesso ignorato principio che i social media sono sociali a tutti gli effetti e la vita essa stessa non è che un campo sotto tutti i punti di vista. «Internet – scrivono gli autori nell’introduzione – è parte di noi, del nostro corpo, dal momento che essere online non è un’esperienza separata ma è un’estensione del modo in cui siamo e agiamo: come una protesi, amplia il nostro pensare, comunicare, agire».
Di questa letteratura, per lo più sociologica, le pagine di Biscaldi e Matera offrono una utile e vasta rassegna, riletta e declinata in una prospettiva eminentemente antropologica. A partire dalle parole chiave del lessico etnografico, dai concetti di campo, comunità, appartenenza, identità, memoria. Cancellato il confine che separa l’essere là e l’essere qui, caduta l’interazione faccia a faccia, dissolto il radicamento territoriale nella liquidità della rete, il campo che è da sempre il luogo gravitazionale dell’antropologia non evapora né scompare ma muta le sue caratteristiche, essendo «un costrutto fluido, emergente e non delimitabile entro dimensioni fisse, offline o online». L’ubiquità e la simultaneità con cui sono abitati e partecipati i due universi – la realtà della vita vera e la virtualità della vita digitale – concorrono a formare comunità complementari e interscambiabili, non essendoci alcuna discontinuità, secondo l’ovvio e troppo spesso ignorato principio che i social media sono sociali a tutti gli effetti e la vita essa stessa non è che un campo sotto tutti i punti di vista. «Internet – scrivono gli autori nell’introduzione – è parte di noi, del nostro corpo, dal momento che essere online non è un’esperienza separata ma è un’estensione del modo in cui siamo e agiamo: come una protesi, amplia il nostro pensare, comunicare, agire».
Nel contesto di una ristrutturazione cognitiva per effetto delle nuove tecnologie digitali le stesse identità finiscono con l’essere liquidamente cangianti e frastagliate, plastiche e commutabili nella libertà illimitata e incontrollata della rete. Non può pertanto essere rimosso dallo sguardo dell’antropologo quanto gli individui fanno e dicono online, digitano o postano, chattano o twittano. Al di là dei contenuti veicolati, assumono rilevanza e significato i codici di condivisione, le forme di relazione e di socialità, i modi di produzione identitaria, il profilo dei sistemi di appartenenza, le connessioni fra media e pratiche della quotidianità. «In generale, l’etnografia della vita online si basa sull’osservazione dei modi in cui nelle comunità virtuali e sulle varie piattaforme disponibili si producono – ed eventualmente si modificano rispetto all’offline, senza però sganciarsi da questo – forme di negoziazione e riproduzione delle identità di classe, di genere, di origine, tra i partecipanti, o forme di socialità».
A guardar bene, al moltiplicarsi delle opportunità offerte dallo sciame delle tecnologie digitali si accompagnano le pressioni ideologiche di un potere mediatico che tende a plasmare non solo idee e abitudini ma anche modi di pensare e di vivere, cognizioni, percezioni e memorie: chi si ricorda più i numeri di telefono che abbiamo totalmente delegato ai dispositivi dello smartphone? E quanto è diffusa la difficoltà a leggere un libro con continuità dall’inizio alla fine, sovraesposti ed imbrigliati come siamo nel labirinto delle stimolazioni visive e sonore che spezzano e frammentano la nostra attenzione? E non sono forse riconducibili ai modelli fortemente individualistici ed egotistici proposti dai media le forme esasperate del narcisismo e dell’esibizionismo che imperversano nei social, il sempre più frequente ricorso al turpiloquio e alla violenza verbale? E ci sarà pure una qualche ragione se gli uomini comunicano sempre di più online ma si comprendano sempre meno offline. Senza dimenticare infine il controllo esercitato dai new media sulle vite private e sulle esperienze quotidiane, sulle scelte e sui consumi, su ogni pratica o azione personale che, spiata e registrata in impalpabili nuvole informatiche, può essere terreno di egemonia e di scontro politico.
 Eppure nelle stesse potenti risorse delle connessioni internet, che ci consentono di navigare e di scoprire nuovi e lontani mondi oltre le barriere fisiche e le frontiere simboliche, ci sono le ragioni fondamentali della sfida e del destino dell’uomo che è soggetto attivo e creativo, capace di obbedire ma anche di trasgredire, di opporsi all’esistente, di contrastare la dipendenza, di immaginare e di inventare usi ibridi e differenti, di produrre nuovi significati, nuove rappresentazioni. Tanto più che «un medium necessariamente prefigura campi del pensabile e di possibile agency». Si ricordi, per esempio, il documentato contributo dei social a “fare comunità” nella diaspora dei migranti o nelle esperienze politiche delle “primavere arabe”. Si pensi al loro impiego da parte dei giovani figli degli immigrati che vi cercano e vi trovano la libertà di esprimere e cumulare identità, simboli e valori riconducibili a diversi contesti culturali. Si consideri infine quale straordinario “campo” etnografico rappresentino questi speciali osservatori del mondo quotidiano delle nuove generazioni, luoghi di comunicazione e di rappresentazione dei desideri e delle frustrazioni, dei bisogni e dei miti dell’immaginario, laboratorio di germinazione iconografica e di sperimentazione di dinamiche sociali e strategie amicali preziose per capire quali modelli culturali maturino negli interstizi che si aprono tra il modo di essere esemplato sui padri e il modo di vivere alla maniera dei coetanei italiani. In tensione o in-between tra ansia d’indipendenza e senso di appartenenza i giovani tessono nei social legami sentimentali e relazionali, più spesso mescolando (et et) che separando (aut aut), sommando e includendo senza sottrarre e senza escludere. Nella doppia dimensione narrativa e fattuale accade che su facebook di adolescenti figli di tunisini possano convivere e dialogare i libri di Pirandello e il Corano, le musiche di De Andrè e le sonorità di Ziad Trabelsi del gruppo Cartage Mosaik, l’elogio del couscus materno e le lodi dell’arancina siciliana. Coabitazioni e commistioni che ci dicono qualcosa non solo degli ibridismi prodotti nella mappa dei riferimenti identitari dallo scenario reticolare e transnazionale della globalizzazione ma anche degli aspetti processuali delle culture e dell’imprescindibile soggettività degli individui.
Eppure nelle stesse potenti risorse delle connessioni internet, che ci consentono di navigare e di scoprire nuovi e lontani mondi oltre le barriere fisiche e le frontiere simboliche, ci sono le ragioni fondamentali della sfida e del destino dell’uomo che è soggetto attivo e creativo, capace di obbedire ma anche di trasgredire, di opporsi all’esistente, di contrastare la dipendenza, di immaginare e di inventare usi ibridi e differenti, di produrre nuovi significati, nuove rappresentazioni. Tanto più che «un medium necessariamente prefigura campi del pensabile e di possibile agency». Si ricordi, per esempio, il documentato contributo dei social a “fare comunità” nella diaspora dei migranti o nelle esperienze politiche delle “primavere arabe”. Si pensi al loro impiego da parte dei giovani figli degli immigrati che vi cercano e vi trovano la libertà di esprimere e cumulare identità, simboli e valori riconducibili a diversi contesti culturali. Si consideri infine quale straordinario “campo” etnografico rappresentino questi speciali osservatori del mondo quotidiano delle nuove generazioni, luoghi di comunicazione e di rappresentazione dei desideri e delle frustrazioni, dei bisogni e dei miti dell’immaginario, laboratorio di germinazione iconografica e di sperimentazione di dinamiche sociali e strategie amicali preziose per capire quali modelli culturali maturino negli interstizi che si aprono tra il modo di essere esemplato sui padri e il modo di vivere alla maniera dei coetanei italiani. In tensione o in-between tra ansia d’indipendenza e senso di appartenenza i giovani tessono nei social legami sentimentali e relazionali, più spesso mescolando (et et) che separando (aut aut), sommando e includendo senza sottrarre e senza escludere. Nella doppia dimensione narrativa e fattuale accade che su facebook di adolescenti figli di tunisini possano convivere e dialogare i libri di Pirandello e il Corano, le musiche di De Andrè e le sonorità di Ziad Trabelsi del gruppo Cartage Mosaik, l’elogio del couscus materno e le lodi dell’arancina siciliana. Coabitazioni e commistioni che ci dicono qualcosa non solo degli ibridismi prodotti nella mappa dei riferimenti identitari dallo scenario reticolare e transnazionale della globalizzazione ma anche degli aspetti processuali delle culture e dell’imprescindibile soggettività degli individui.
All’attenzione critica dell’antropologia si apre dunque un vasto paesaggio culturale da esplorare nelle migrazioni tra offline e online, tra locale e globale, tra il qui e l’altrove, tra le maglie delle reti che attraversano e scavalcano spazi e tempi diversi. Del resto, al dialogo tra mondi, sempre più vicini e sempre più eterogenei, era e resta affidato il senso dell’avventura antropologica, che – come scrive Vincenzo Matera – è «un modo per decentrare se stessi e gli altri, i propri posizionamenti e quelli altrui, al fine di vedere meglio se stessi e gli altri». Studiare oggi i processi di bricolage o di creatività culturale che si attivano attraverso le nuove tecniche digitali di comunicazione e di mediazione simbolica significa in ultima analisi recuperare all’antropologia il progetto di conoscenza dell’uomo e dei suoi saperi, che iscritti nell’orizzonte della rete globale sono pur sempre intelligibili a partire dal modo in cui prendono forma all’interno degli universi locali.
Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019
______________________________________________________________
Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. La sua ultima pubblicazione è la cura di un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (2015).
______________________________________________________________