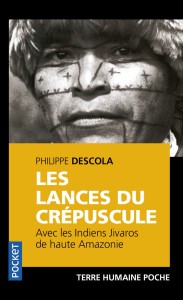di Piergiorgio Solinas
«La guerra era considerata come una parte indiscutibile del loro modo di vita; attaccavano le tribù straniere perché erano nemiche per definizione… …le tribù nemiche erano di per se stesse causa di guerra, per i Mundurucu semplicemente perché esistevano; la parola “nemici” significava semplicemente qualunque gruppo che non fosse Mundurucu»[1].
Il contagio della violenza
Possiamo noi antropologi dire qualcosa di utile, magari di nuovo, sulla guerra? Pensare e dire, intendo, qualcosa che entri con onestà e commossa intelligenza dei fatti nel tormento delle coscienze al ritornare delle bombe, delle stragi, degli omicidi organizzati e promossi come dovere civile, come sacrificio sublime, come onore e piacere della vittoria?
La guerra d’oggi è spettacolo quotidiano, esperienza d’emozioni somministrate in dosi tollerabili per le famiglie, ammonimento ed educazione morale, inferno esorcizzato dalla distanza, e dalla esecrazione comune. La violenza si sublima nell’immagine sfolgorante delle scie luminose dei missili, e nelle macerie disperate rovesciate sulle vittime. Criptata o rimossa. la violenza diventa tecnologia: violenza delle cose, dei sistemi di lancio, dei puntamenti, dei pulsanti che comandano la disintegrazione di obiettivi senza visibile consistenza umana. La violenza si esprime ex post, come “conseguenza” ed effetto. La volontà di uccidere diventa impersonale e non imputabile. Chi comanda? L’agire è frazionato in una quantità di soggetti e porzioni, la responsabilità si dissolve e trascende le parti. Perfino le vittime diventano partecipi, e chi contrattacca e combatte contro, chi fa guerra contro la guerra si trova suo malgrado immerso nel flusso omicida che subisce in prima persona.
Tutto ciò rigenera e ingrandisce la fabbrica del potere, ne diffonde la forza, la fa diventare potenza ineluttabile, invincibile, onnipotente. Lo Stato, ci è stato spiegato, è un’entità superiore che detiene il monopolio della forza, ma resta una parte importante che questa definizione oscura, e cioè il suo inverso: la forza, il dominio e il controllo della forza genera e riproduce lo Stato. È da questo spiraglio, tra gli altri, che intravediamo il paradosso in cui siamo vittime e complici, il fatto cioè che oggi più che mai, mentre si sente e si dice che la guerra è una mostruosità odiosa, nello stesso tempo si assiste all’aumento della potenza distruttiva delle armi, alla potenza di sterminio delle tecniche e degli ordigni di morte. Più si rende conto della forza malefica della propria capacità di violenza, più l’uomo si dà da fare per farla diventare più efficace, più perfetta.
Non sembri retorico questo interrogarsi sulle radici umane della violenza come pratica e tecnica della massima perfezione distruttiva. I fatti di questi giorni, di queste settimane, ci fanno vivere qualcosa che ci illudevamo di aver esorcizzato, di aver schiacciato ed espulso al di fuori della nostra “natura”. La paura della guerra totale presuppone una cosa precisa: la guerra non può essere combattuta che con la guerra; la reciprocità della violenza fra popoli e fra Stati implica una sorta di comunione di pratiche omicide, una specularità di linguaggi e di esaltazioni simboliche in cui la giustizia e la verità sono sbilanciate in ragione del contrasto fra offesa e difesa. Chi attacca ed opprime ha torto, chi si difende ha ragione. Questo semplice, elementare principio di base si mantiene, sicuramente, come fonte di solidarietà e di protesta; solidarietà con chi è colpito, protesta contro chi colpisce. Ma è sufficiente questa presa di responsabilità morale a soddisfare il bisogno di coscienza? È quel che ci vuole per assicurare alla nostra umanità presente, o meglio ancora alla nostra “presenza”, un margine sufficiente di immunità rispetto alla logica della guerra? E fin dove può arrivare questa coscienza di giustizia? Fino alla giusta risposta distruttiva contro chi ci aggredisce?
Io penso di sì, penso che tutto ciò sia inevitabile, che per respingere il male sia inevitabile reagire ma penso anche che la contaminazione alla quale ci esponiamo nel partecipare alla difesa dell’offeso, sia pure indirettamente, attraversi il confine fra il giusto e l’ingiusto, che dovremo immergerci nell’onda malefica e assorbire la sua perversione, certo per ritorcerla contro la sua stessa fonte, ma non per questo salvando la nostra innocenza.
Ora, l’antropologia non ha i mezzi o i saperi adeguati per risolvere o anche solo illuminare i dilemmi della civiltà moderna intorno al dramma comune che oggi opprime le coscienze. Tutto ciò che può fare è percorrere la varietà sterminata dei mondi culturali, studiare le società da un estremo all’altro per vedere se e in che modo queste società trattano o hanno trattato la loro carica di violenza, per cercare di capire da dove traggono il desiderio di combattere, di conquistare, di annientare altre società. Per capire, magari, se la guerra si presenta come una sorta di patologia culturale, oppure se fa parte della normale fisiologia strutturale dei sistemi umani di convivenza [2].
Ebbene, la lunga e vasta esperienza umana della guerra, fin dalle sue apparizioni più antiche e dalle sue lontane etnografie, mostra un dato preminente, un concorso o complesso di valori che ne esaltano il carattere di vertice, se non di centro della stessa identità di specie. Gli uomini non solo hanno sempre cercato, amato, sacralizzato la guerra; ne hanno fatto il motore della loro stessa identità, il fulcro, il significante-sorgente del proprio essere comunità. Si pensi per un momento ai grandi miti di fondazione, all’epica e alle epopee di cui ancor oggi vengono nutriti i nostri figli e i nostri nipoti a scuola: a cominciare dalla guerra di Troia con le sue spietate carneficine e i suoi combattimenti con scempio del corpo dei vinti. Né si può dire che queste siano eccezioni nel quadro variegato delle culture e dei popoli.
Se volgiamo lo sguardo alla cultura dell’India, a questo Paese che predica e coltiva i valori dell’ahimsa, la nonviolenza, questa civiltà che ci parla tuttora con il culto ascetico della nonviolenza di Gandhi, ebbene qui nel cuore della sua letteratura, poetica e religiosa al tempo stesso si ritrova l’epopea della guerra, Il Mahabharata, grandioso racconto di battaglia, di scontro e sterminio nel grande campo di battaglia di Kurukshetra. È Dio stesso, Krishna, avatar di Vishnu ad incitare il principe Arjun che guida uno dei due schieramenti, a non esitare di fronte al nemico, e ad affrontare il combattimento, la strage dei suoi stessi cugini nemici. Messaggio non solo di valore e virtù, ma di identificazione con il dharma, con l’ordine cosmico, nucleo teologico eminente dell’identità culturale hindu. Non è da meno la Bibbia, su cui non ci soffermiamo, né il Corano, entrambi tutt’altro che cauti in materia di teologia della guerra, santa e divinamente gloriosa quando incontra il martirio in combattimento.
Cose del passato, si dirà, ormai diventate leggenda innocua. Ma cerchiamo ancora, guardiamo da una parte e dall’altra di questi picchi, o culmini nella curva di evoluzione della guerra. “Prima”, intanto, in un prima convenzionale che retrocede verso le forme meno potenti di civiltà, verso quei limiti che un tempo si sarebbero detti del primitivo, dei selvaggi. Qui ci si imbatte in una sorta di indulgenza etnologica che blandisce i fenomeni della violenza, i più efferati e ferini, ne fa delle espressioni addolcite di autenticità primigenia. Guerre innocenti, magari ripugnanti ai nostri occhi, oggi, ma ben integrate nell’equilibrio delle comunità organiche che vivono o vivevano in un loro stato di benessere senza peccato.
Non pochi dei nostri colleghi e autori di monografie esemplari (non solo Pierre Clastres della Archeologia della violenza, ma, per venir più vicino, Philippe Descola, narrante partecipe della vita dei Jivaros, famosi cacciatori di teste amazzonici [3]) non fanno una piega di fronte ai costumi alquanto sanguinari dei loro soggetti d’etnografia. Scritti ed esperienze, bisogna dire, che ci hanno attratto, che spesso sono diventati parte della cultura antropologica contemporanea, e talvolta supporto di ideologia della società senza (o contro) lo Stato.
Il breve saggio esemplare di Lévi-Strauss Guerra e commercio fra gli indiani dell’America del Sud [4] occupa un posto seminale in questa tradizione antropologica. Seminale e denso di problematicità teorica. Vi si spiega infatti che nella condotta dei gruppi seminomadi della foresta l’alternativa fra combattersi (e uccidersi) da una parte, e dall’altra scambiarsi beni, oggetti, in breve, tra guerra e mercato, struttura l’esistenza stessa delle società, o piuttosto della società. La guerra è l’opzione latente, la norma culturale che attiva relazioni tra comunità che non si conoscono, o che si ignorano. Al pari del commercio, insomma, la guerra produce relazioni. È sulla traccia di questo principio latente, direi, che il concetto di scambio negativo, proposto da Marshal Sahlins può figurare come termine perfettamente funzionale nel diagramma delle logiche di relazione fra gruppi. Al dono si oppone il furto, all’amicizia l’inimicizia. L’uno non può reggersi senza l’altro, così come la pace non è che il rovescio della guerra.
Sfuggire a questa gabbia, staccarsi dall’orbita ciclica della violenza che si sprigiona e si diffonde per poi esaurirsi ed abbattersi nello stato di riposo, della non-guerra, eliminare per sempre il bisogno di inimicizia: è questo il grande problema antropologico che stiamo vivendo al suo parossismo, alle soglie del rischio di auto-distruzione? È su questa soglia fatale che siamo sospinti a volgere contro la nostra stessa “natura” le capacità di trasformazione di noi stessi? Il compito che si intravede oltre i bagliori sinistri delle armi più perfette, oggi, all’estremità opposta rispetto a quel prima di cui parlavo, quel prima della violenza primitiva, è tremendamente arduo, ingigantito tanto quanto gigantesco e di efficienza massima, quasi totale è oggi l’insieme dei sistemi militari di distruzione.
Un’antropologia della guerra oggi, al culmine del progresso della civiltà delle armi, temo sia fuori dalla portata dei nostri poveri mezzi di ricerca e di interpretazione. Ma qualcosa possiamo sforzarci di dire. In primo luogo, sulle concezioni, e sulle percezioni (ma oltre, sulle rimozioni) del “nemico”. Sulla conoscenza del nemico, o fra nemici. L’odio fra i popoli, la conoscenza, indotta o surrogata mediante gli stereotipi dell’odio di massa, insomma la conoscenza odiatrice, è nel tempo presente insieme proditoria e fatua. Occorre alimentare degli stereotipi esausti per rinfocolare sentimenti distruttivi, così come attivare fabbriche di falsità e di denegazione dell’umanità straniera. Accanto a questa pratica di ideologia dell’inimicizia, va innescato un meccanismo pervasivo di oscuramento che annulli il rapporto fra la sorgente dell’aggressione e il suo esito.
Le armi uccidono, devastano, annientano, ma il rapporto fra il niente che rimane dopo la distruzione e il punto di inizio, la sorgente dell’atto distruttivo, viene alienato, estromesso dalla coscienza. La bomba esplode, ma l’autore reale dell’atto svanisce, come svanisce, disintegrato dallo “spostamento d’aria” o dal “crollo del palazzo”, la vittima da sotterrare nella fossa comune.
Verrebbe da pensare alla commedia dell’innocenza che in tempi lontani gli antropologi scovarono nei rituali di caccia presso certi popoli, siberiani e non solo, o nei rituali di sacrificio. La commedia consisteva nel discolparsi davanti alla vittima immolata o alla preda uccisa dicendo: non sono io che ti ho tolto la vita, ma il coltello, la freccia. Così oggi il bombardamento si trasfigura, diventa missione aerea, il lancio di missili diventa traiettoria, le case diventano “obiettivi”. Il drone assassino inconsapevole, come il coltello sacrificale, non porta nessun pilota che comandi il fuoco, magari colpisce un supermercato o una scuola, ma non è colpa di nessuno, è il drone che ha sbagliato obiettivo…
I giocattoli mortali sono diventati ormai i prodotti di lusso che gli Stati si affannano a fabbricare e a confrontare fra loro in un gioco perverso, il gioco del provare a sfiorare la fine del mondo. Il gioco segna ormai il culmine di evoluzione della guerra. So di avvicinarmi a un terreno incerto e di gusto acido, ma mi colpisce l’intreccio fra la passione della guerra e il gioco. Forse una via di ispezione che l’antropologia può aprire è proprio quella del guardare l’umano attraverso il microscopio culturale dei vizi più accattivanti e innocenti delle sue guerre simulate. Nei combattimenti simbolici, a squadre o singoli, che siano d’arti marziali o di sport antagonistici, si mette in scena, sublimandolo, l’annientamento dell’avversario, con il corredo simbolico della gloria per il vincitore, della strategia di attacco e difesa, del valore e del coraggio. La sconfitta produce sottomissione e consenso gerarchico e, in trasparenza, oltre l’amicizia sportiva che riscatta l’amaro della violenza performativa, una sorta di potere.
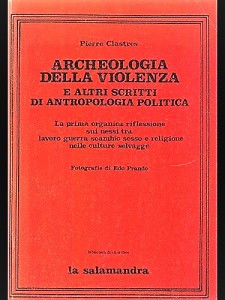 (Pseudo)simmetria della violenza
(Pseudo)simmetria della violenza
L’evoluzione della guerra porta a qualche cosa che, ben oltre la metafora, spinge sempre più in alto il potlach della distruzione reciproca, calcolabile fino al rischio estremo di perdere se stessi nella sfida che mette in gioco la vita del nemico. O io o tu: se hai il coraggio di sfidare la mia sfida, che ti ha già distrutto in spirito prima di affrontarti sul campo, io stesso metto in gioco, sul banco delle puntate, me stesso.
E allora? Siamo uguali, alla fine dei conti siamo la stessa cosa? La guerra amalgama, spinge verso la reciproca assimilazione delle parti in contrasto; un’osmosi incontrollabile trasmette da una parte all’altra del fronte le molecole avvelenate della volontà di morte. E, con queste, il rischio di occultare nella simmetria dell’agire mortale, le ragioni e i torti. Chi c’è dentro, chi viene aggredito e si batte per difendersi non vedrà certo in questo modo le cose: la sua violenza acquista il crisma incontestabile della giustizia, le sue armi sono portatrici di giusta violenza per la propria salvezza. Neppure il più neutro, imparziale e oggettivo osservatore dei fatti potrà mettere in dubbio questa disparità; prendere come principio di verità la simmetria delle parti in contrasto non è solo fallacia, diventa irresolutezza, disimpegno. E opportunismo, perché aspettare di vedere chi vince per decidere chi aveva ragione, dove stava la verità equivale a sottomettere la propria ragione alla ragione della forza.
Ma allora, quale via, quale metodo bisogna seguire per comprendere in uno stesso impegno scientifico entrambe queste condizioni, quella che coglie la ragione di giustizia e quella che osserva e partecipa al contagio della violenza? L’etnografia della guerra dovrebbe stare fra le parti in contrasto, o magari farsi partecipe di entrambe? Idealmente, forse, sì: per dar conto della inter-azione, della complementarità nello scambio negativo fra nemici, l’etnografo scrupoloso dovrebbe registrare i fatti, le azioni, le pulsioni e le ragioni degli uni e degli altri. Così come la produzione di morte che ognuna delle parti in lotta emana nel fare degli uomini che combattono dei guerrieri, attori che incorporano la violenza militare in cui sono interpreti, soggetti e oggetti insieme.
Oggi più che mai, mentre il nostro sguardo viene fatto partecipe della cronaca quotidiana di distruzione, delle case sventrate, dei tank fracassati, degli incendi e delle bombe, della guerra trasmessa per immagini, e per discorso, abbiamo il privilegio di vivere la storia in diretta. La guerra parla, la guerra si mostra, si rappresenta. L’uso sempre più ricorrente del concetto e del termine “narrazione” non è innocente. Il resoconto degli eventi, dell’accadere in presa diretta, e pronto quasi immediatamente a diventare racconto, un passo appena prima che diventi storia compiuta, res gestae, ci porta a casa il fatto compiuto. Diventiamo spettatori di un accadere programmato e al tempo stesso sanzionato dalla irreversibilità del prodotto finito.
Introdurrò ora un tema un po’ deviante, deviante e ruvido. L’empatia che il vedere e partecipare risveglia nelle coscienze occidentali, degli spettatori non coinvolti, ma turbati e indignati, non ha solo una radice genericamente umana. Tocca delle percezioni diremo pre-logiche (nel senso di qualcosa che si muove ad un livello percettivo inconscio, qualcosa che precede il logos, il dire e il sapere). Guardiamo e ci guardano i volti dei profughi; scopriamo che “sono come noi”, ci assomigliano, è un po’ come se li sentissimo sensibilmente, fisicamente, forse esteticamente, comunicanti con la nostra stessa identità…, già quale? Identità continentale, europea, cristiana? Oppure, tautologicamente, occidentale?
I più orientali degli occidentali, un po’adfines, affini, come se dai precordi d’una remota comunanza d’origine si rivelasse in una specie di riconoscimento inconscio, una memoria precordiale che attraversa la soglia differenziale che unisce (e divide) Oriente e Occidente. Faglia fisica, storica, identitaria. Soggetta a modi contrastanti di affioramento: esprime unione ed empatia quando ci si sente dalla stessa parte, ma distacco, perfino trauma etnico quando prevale l’attrazione da poli contrapposti più lontani e potenti. Quando, ad esempio, la sconfinata congregazione slava (e il mito pan-slavista) si contrappone a quella mediterranea, o mitteleuropea, per non dire teutonica, o celtica… Non so se la violenza armata d’oggi risvegli con evocazioni come queste i mostri primordiali che da tempo abbiamo cacciato nelle ceneri del passato. Mi riferisco piuttosto a nuove, emergenti forme di appartenenza e di osmosi (e catalisi) identitaria. Relative, appunto, e fluide, in funzione della scala intercontinentale, e di placche storiche e culturali più larghe: Asia, Europa, sud-Asia, Vicino Oriente.
Placche culturali e di solidarietà empatica. Per quanto imbarazzante, il fatto è che non comunichiamo a tutti gli “altri”, a tutte le vittime di oppressione, di violenza, la stessa dose di compassione. Quel “sono come noi” è la spia d’una scala differenziale di identificazione che ci apre alla solidarietà gratuita, virtualmente incondizionata che invece somministriamo con cautela, se non con maltolleranza, a chi da distanze etniche maggiori si affaccia ai nostri confini con uguale bagaglio di sofferenza, ma sprovvisto di sufficiente somiglianza.
L’asse di opposizione Oriente-Occidente, Europa-Asia percorre oggi come ieri lo spazio geo-etnico (direi l’etnosfera se non mi preoccupasse la scivolosità teorica del neologismo). È la potenza d’attrazione dei grandi poli di civiltà, delle masse continentali di identità, a muovere queste correnti impetuose di aggressione, di disconoscimento di tradimenti e di divorzi. Una insidiosa simmetria di auto-rappresentazioni, e di inversioni ingombra la scena della visione di sé e dell’altro da sé: da una parte l’ombra del “dispotismo orientale” di contro alla luce della democrazia occidentale, dall’altra parte lo spregio per l’Occidente decadente ed avido di dominio di contro alla integrità morale e patriotica. Più lontana e gigantesca, immobile nella sua autosufficienza, ma attiva al parossismo nell’intrapresa commerciale e finanziaria, la nazione Cina, moderno chung-kuo, l’Impero di mezzo incarna l’estremo altro da noi, ci mostra un modello di disciplina totalizzante, che unisce il collettivo e l’individuale nella etica capillare della responsabilità e dell’obbedienza.
Che le ramificazioni delle linee di frattura non coincidano esattamente con le linee di confine fra i blocchi demografici ed etnici lo dimostra il ripetersi di sanguinosi e spietati conflitti armati fra genti molto vicine e, spesso, comunicanti per stratificazioni condivise di storia e lingua. Nei Balcani, sappiamo bene, e ora nel sud dell’antico impero russo. Per non parlare di episodi molto più sanguinosi lungo la fascia che dall’Iran, l’Iraq, l’Afghanistan, il Pakistan arriva fino al subcontinente indiano (bengalesi dell’est contro bengalesi dell’ovest, indiani di appartenenza hindu e indiani islamici dl Pakistan, tamil e cingalesi nel Sri Lanka…)
In tutti questi casi, o in molti, lo scarto etnico che contrappone una regione all’altra, o un “popolo” all’altro va compreso non come la premessa, ma come l’esito di processi culturali, e strutturali, che agitano, erodono, rigenerano, oppongono le identità locali. Se, da una parte, le identità si presentano come appartenenze ascritte, predicabili a priori, in misura non minore, dall’altra parte, sono esposte incessantemente ai flussi di sintesi, di scissione e riconversione. Pensare che un popolo sia qualcosa di dato, immodificabile, che si mantiene fedele a se stesso e che la sua storia si svolga seguendo le leggi newtoniane della causalità lineare, e soprattutto che vada trattato come un oggetto chiuso, geometricamente classificabile in un casellario di classi etniche o di tipologie culturali preformate è quanto mai fuorviante, non solo in termini cognitivi, ma altrettanto in termini pratici e politici.
Ho la sensazione che nell’accelerazione drammatica del conflitto russo-ucraino, si stia producendo appunto uno di questi rivolgimenti, dislocamenti di aggregazione identitaria che in altro linguaggio e con altre prospettive categoriali avremmo definito etnici. In realtà la supposta famiglia slava, un patchwork assai esteso di ramificazioni regionali, linguistiche e religiose che si propaga dalla Russia asiatica al Baltico, ai Balcani, al Mar Nero e oltre può forse conservare il valore d’un referente etno-simbolico, ma non altrettanto facilmente l’energia aggregante della comunità. Un referente simbolico che si appiglia al connettivo linguistico (e alla sua ancestrale derivazione indo-europea), alla continuità spaziale, alla religione, alle forme di vita e agli stili.
Che la cultura nazionale russa pretenda di costituire il nucleo consacrato di questo dominio d’identità condivisa è ben comprensibile, ed è su questa gelosa esclusiva, su questa egemonia etno-identitaria che Putin cerca di far valere le sue ragioni sulla nazione ribelle, quella che egli considera una non-nazione. Ha ragione il presidente Zelesnky a dire che il nemico russo vuole cancellare, distruggere l’Ucraina come nazione e Putin in effetti non nasconde il suo rabbioso desiderio di riprendersi il Paese, a cominciare dal cuore antico di fondazione della identità rus’. Secondo Putin, e probabilmente secondo il sentire comune in Russia, l’Ucraina e la Russia condividono la stessa identità profonda, son un tutt’uno. Tesi questa che Putin ha ripetuto molte volte, ancora pochi mesi prima dell’invasione: «During the recent Direct Line, when I was asked about Russian-Ukrainian relations, I said that Russians and Ukrainians were one people – a single whole».
Genti, dunque co-sustanziate come parti dello stesso spazio storico e spirituale: «parts of what is essentially the same historical and spiritual space» [5]. Basterebbe questa drastica, inappellabile premessa per cogliere alla radice dello scontro una radicale, insuperabile questione di identità: identità condivisa, per amore o per forza, contro un’identità rivendicata, antagonista e “altra”. Ma, nella dialettica delle identità vi sono forme e pratiche differenti, molteplici e perfino mutevoli. Alla appartenenza che viene, diremmo, per eredità o per dato di fatto, vanno accompagnati altri atti o comportamenti identitari.
I censimenti, nell’Ucraina di prima e dopo la disintegrazione dell’URSS, basavano l’appartenenza etnica, russa o ucraina, sulla scelta dei cittadini, era una auto-attribuzione. Chi si riconosceva come russo era russo, chi come ucraino era ucraino. Più che un dato di fonte legale, l’identità diventava un fatto privato. Poteva cambiare, ridefinirsi (ri-identificazione) e dar luogo a identità composite, o miste. Poteva confondersi con l’appartenenza per cittadinanza, per origine dei genitori, etc. Anche per questo motivo la proporzione delle componenti, russa e ucraina, cambia vistosamente nei dati demografici fra prima e dopo la caduta dell’URSS: la parte russa crolla dalla quasi maggioranza di due terzi a poco meno di un quarto sul totale della popolazione. Sia chiaro, non si parla qui di scelte soggettive secondo il gradimento individuale. Non si tratta di un sef-service nel menu delle offerte etniche. In quel momento, come oggi, il campo di forza delle alternative, delle egemonie opposte è attraversato da tensioni impetuose che spostano le aree di riconoscimento.
Il ritrovarsi fra simili e l’opporsi ai diversi entro spazi fisici e mentali che sono nello stesso tempo condizionati e condizionanti non dipende solo dal passato, dalla storia e dal patrimonio simbolico che in questa o quell’area di coltura ha radicato la sua presa. Impreviste, e imprevedibili sintesi a venire si fanno strada nel fermento di identità potenziali che sfuggono alla stessa categoria di “etnico”, e che anticipano inedite modalità di riconoscimento di sé e di relazione con altro da sé.
L’attrazione dell’“Occidente”, la forma e la forza stessa di questa incombente, primordiale categoria d’orientamento nel paesaggio globale della cultura, domina oggi la scena internazionale. Difficilmente si potrebbe riempire questo complesso, questo mondo, il mondo occidentale, d’un contenuto etnico. Nonostante i tentativi di leggere la cultura europea, americana, o euro-americana in termini d’etnografia, non abbiamo ancora visto emergere un quadro, sia pure solo descrittivo, che possa esser letto come “antropologia dell’Occidente”.
La prospettiva in cui va posto questo problema, il problema della geopolitica dell’etnicità, è piuttosto quella del contrasto, dello scarto fra lo spazio cosmopolitico, etnicamente neutro, e in larga misura de-etnicizzato, da una parte, e dall’altra i territori dell’etnicità, o di relativa resistenza identitaria, che stanno “fuori”, un fuori geografico e al tempo stesso non locale. Uso controvoglia questi avverbi, “fuori”, “dentro”, ma devo farlo perché il linguaggio che oggi domina la cronaca della guerra e delle domande di alleanza configura esattamente una geografia dei confini culturali in termini di “ingresso” e “uscita”. La frontiera dell’alleanza militare evoca e materializza il margine di un’orbita di identificazione che offre a chi ne sta fuori, appunto, la possibilità di “entrare” a farne parte, di diventare parte di noi. Diventare occidentali dunque, e con ciò attraversare quella mutazione che sterilizza, o almeno mette in mora la carica etnica contesa e immette nel corredo degli strati di identità dei nuovi arrivati una componente superiore, inclusiva e proiettiva.
L’evoluzione disumana della natura umana
Il nostro sguardo non può spingersi oltre l’orizzonte che a malapena intravediamo oggi tra i bagliori delle esplosioni distruttive e l’esodo disperato dei civili verso i confini occidentali, verso la salvezza e la accoglienza di chi cerca i nuovi “come noi”. Questo discorso si è aperto con i grandi, irrisolti interrogativi che cercano l’origine della guerra nel profondo della nostra umanità, sia essa da definire come natura, natura umana, oppure come storia o evoluzione delle leggi di formazione delle società. Origine e persistenza della violenza armata, e del riprodursi in nuove radici.
Non è futile riprendere questo tema, e vedere qualche risposta che in antropologia e dintorni è stata avanzata. Lasciando da parte la varietà minuta delle proposte, e delle etnografie, perfino troppo abbondanti, conviene limitarsi a due tesi, piuttosto divergenti, che portano motivi, origini ed esiti a loro modo plausibili. La prima, piuttosto etologica, o etologico–psicologica, cerca, e trova nella aggressività innata della nostra psiche la fonte della condotta violenta di gruppo, della violenza organizzata contro gruppi nemici, prede umane o popolazioni da sottomettere con la forza. La seconda, al contrario, si rivolge alle condizioni esterne, ecologiche ed economiche della sopravvivenza; in particolare, interpreta il conflitto violento fra popolazioni contigue come espressione estrema della contesa per il possesso di risorse scarse, siano queste alimentari, beni preziosi, territori, esseri umani (uomini da lavoro, donne come prede sessuali e riproduttive).
L’asse di divergenza, come si vede, si divide tra due poli, il primo psico-genetico (la violenza affonda le sue radici nell’istinto aggressivo dell’uomo), il secondo più orientato verso una dimensione materialista, si appoggia sulle costanti strutturali di sussistenza delle società. Con tutta evidenza, entrambe queste spiegazioni della origine della guerra restano poco più che dei princìpi astratti di orientamento finché non vengono messi alla prova nel confronto con i fatti. Ed è appunto alla prova della tragica esperienza che stiamo vivendo che si dovrebbe misurarne l’utilità. Mi sembra che possa dirci qualcosa di interessante, tanto per cominciare, la seconda delle ipotesi, quella della teoria delle “risorse scarse”. Vien subito da riconoscere, per esempio, che le risorse che appaiono imporsi all’attenzione, e che di fatto sono al centro di uno scontro impetuoso, impetuoso e vasto, molto più vasto dei campi di battaglia e delle aree di confronto armato diretto, sono quelle di cui ci approvvigioniamo ogni giorno per scaldarci, alimentare i motori delle auto, cucinare ecc.: il petrolio, il gas, e poi il frumento, l’olio di semi…
Una guerra intorno alle fonti d’energia allora? Il gas russo, risorsa scarsa (per l’Europa) sotto continua minaccia di riduzione? Certamente questo è un lato della questione che non può essere messo da parte, ma a me sembra che le risorse oggetto dello scontro non siano solo quelle che scorrono negli oleodotti, e che anzi queste restino ancora – relativamente – in secondo piano: il piano della minaccia e delle paure, ma non ancora attive nella guerra. L’ipotesi delle risorse contese può trovare tuttavia qualche aggancio interessante se si passa dal piano delle risorse materiali a quello delle risorse immateriali, come mi pare rivelino certe inflessioni retoriche che i nemici, l’aggressore e la vittima, si scambiano indirettamente quando si evocano gli spazi e i patrimoni “spirituali”.
La sovranità, l’indipendenza, e, ancora una volta l’identità sono i beni che da una parte si cerca di togliere o di negare, dall’altra di difendere, di valorizzare e di accrescere. Forse c’è in gioco qualcosa di ancora più estremo, impalpabile e non quantificabile che si esprime nel potere, nel dominio, nel valore. Non mi spingo oltre in questo regressus d’astrazioni. Tengo piuttosto a richiamare un altro aspetto, un lato meno evidente nella dinamica della violenza, che pure ci si offre tutti i giorni nelle sue brutali manifestazioni. È quello che potremmo definire economia del negativo, la circolazione e l’erogazione dei “mali” come rovescio o risposta ineliminabile della contesa sui beni. Che cosa produce, in fin dei conti, l’aggressione, la distruzione, l’omicidio organizzato e diretto verso il nemico se non una sistematica disseminazione di mali? Il “dare la morte”, termine anodino, quasi neutro come il suo corrispettivo “togliere la vita” denuncia nella sua ambiguità retorica – quel “dare” che sembra appunto dire che qualcuno dà e qualcuno riceve – l’indissociabilità tra i due lati della dinamica di ostilità, tra le risorse e le anti-risorse, tra le risorse positive e quelle negative. Non si può conquistare senza distruggere, né prendere senza togliere. Il problema, e forse il grande, eterno inganno, sta nel capovolgimento di questo binomio. Sta nell’illusione che il togliere assicuri il prendere, che il negativo si trasformi in positivo, che l’arma mortale generi nuova vita, che la vita perduta per chi è colpito, porti incremento di vita per chi colpisce.
Qui l’etnologia trova sprazzi di confronto piuttosto illuminanti. Nella sua forma più primordiale, l’aggressione diretta si accompagna, spesso, alla maledizione a distanza, all’opera magica dell’indurre malattia, morte e rovina prima e senza il contatto fisico. E d’altronde questo modo di amministrare il negativo non nasce nella guerra. È qualcosa di più generale. Nel cuore stesso della comunità, il male diventa qualcosa che si può isolare, separare, trasferire su un essere, umano, animale, ed espellerlo. O infliggerlo ad altri.
Sembrerà un po’ tirata per i capelli, ma l’analogia che potrebbe suggerire il confronto con la guerra moderna mi pare che possa suggerire qualche spunto di riflessione. Molte delle armi più letali colpiscono oggi appunto a distanza, molto oltre la portata dei fucili o delle mitragliatrici, e soprattutto oltre la portata della vista dei combattenti, nell’ignoto. E molte di queste sono concentrati di veleno, gas letali, mine beffarde che uccidono chi si azzarda a toccarle. A me paiono precisamente dei pacchi malefici, preparati nei laboratori, impregnati di forza omicida per esser proiettati nello spazio di vita del nemico proprio per togliere parti di vita. Oggetti maledetti, oggetti mal-fattori.
So bene che uno schema come questo non serve al di là d’una semplice proposta di prova, come tentativo di istruire letture possibili delle forme e delle forze misteriose che si materializzano nella guerra. Dobbiamo riconoscere il fatto che l’odio, la volontà di infliggere il male e la passione distruttiva si sviluppano entro e con lo sviluppo della civiltà, fino a diventare oggetti alieni, strutture che oltrepassano la coscienza e il potere di dominio dei soggetti che li somministrano. È a questo livello, in una sorta di strato superiore, sovrastrutturale, dei sistemi sociali che ha preso potenza quella aggressività di cui parlano i sostenitori della spiegazione psico-genetica. Non trovo qui, tuttavia, nessuna traccia etologica, di istinto primario, limbico nella tecnologia sofisticatissima e alienata della industria delle armi, nelle strategie offensive telecomandate, nelle armi biologiche che hanno portato ormai la “nostra” guerra molto vicina alla perfezione d’annientamento. Il nemico che siamo stati capaci di generare, ormai, è la nostra stessa aggressività armata, che si è separata da noi stessi, si è esternalizzata, ha trasceso non solo la nostra natura animale, ma anche la sovranatura che la scienza, l’etica, l’arte, il pensiero hanno potenziato oltremisura.
Dialoghi Mediterranei, n. 55, maggio 2022
Note
[1] R. F. Murphy, Headhunter’s Heritage, Berkeley University Press, 1960.
[2] Una utile rassegna tematica su questi temi si può trovare nella raccolta di saggi a cura di Alisse Waterston, An Anthropology of War. Views from the Frontline, Berghahn Books, 2009.
[3] Philippe Descola, Les lances du crépuscule: Relations Jivaros, Haute-Amazonie Plon Parigi, 1993.
[4] Claude Lévi-Strauss, Guerre et commerce chez les indiens de l’Amerique du Sud. “Renaissance” New York, 943.
[5]Vladimir Putin “On the Historical Unity of Russians and Ukrainians”, July 12, 2021 http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
___________________________________________________________________________
Piergiorgio Solinas, ha insegnato per molti anni Antropologia Culturale ed Etnologia all’Università di Siena, e in diverse Università all’estero. Ha lavorato e pubblicato soprattutto sulla parentela, l’antropologia economica, l’etno-demografia e la cultura materiale, con ricerche sulla mezzadria toscana, sui pastori sardi immigrati in Toscana, sulle forme recenti di famiglia. Tra le sue ultime pubblicazioni: Colore di pelle colore di casta. Persona rituale, società in India (2015); Ancestry. Parentele elettroniche e linguaggi genetici (2015); Lettere dagli antenati. Famiglie, genti, identità (2020).
______________________________________________________________