«La verità è una coperta che lascia scoperti i piedi» (Todd Anderson, L’attimo fuggente)
Premessa: Verga e i mostri
Il teatro italiano maggiore, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, frutto per lo più di schemi maturati dall’élite culturale del tempo, si configura come testo letterario d’elaborazione, privo dell’immediatezza popolare che la commedia dell’arte o il teatro dei pupi o la canzone dei cantastorie, legati al ciclo dei campi, dei mestieri e della religiosità, portavano con sé.
Il problema della testualità e quindi dell’indipendenza più o meno marcata di un certo genere di verismo dagli schemi classici della rappresentazione scenica può servire ad individuare il vero fulcro portante dell’asse Verga-letteratura verista-concezione sociale e quindi del modulo narrativo della più alta espressione verista siciliana. Non si tratta qui di iniziare un discorso regionalistico o prettamente dialettale ma è indispensabile arrivare a capire di quali strumenti espressivi era in possesso il nostro autore e in quale misura tali moduli erano mutuati veristicamente dalla realtà. Si tratterà quindi, in fondo, di porre in discussione la veridicità del verismo o, in altri termini, il realismo linguistico, strutturale e sociale della corrente verghiana non già perché vorremmo che l’arte fosse simile alla realtà, ma poiché proprio il riflesso socio-politico del verismo si inquadra nel contesto di una riscrittura d’arte che s’intestò la responsabilità di narrare al nord la distanza tra nord e sud, tramite una fabbrica di creature elementari che rese archetipici i mostri siculi, nell’Italia più mittle-europea. Mostri che non raccontarono mai la ribellione, né denunciarono la miseria del Mezzogiorno, quanto la bestialità e l’irredenzione di creature prive di qualsivoglia prospettiva di riscatto.
Le nostre argomentazioni proveranno ad individuare determinate strutture ricorrenti nel verismo, che vennero utilizzate come trait d’union tra il vero storico e l’opera d’arte. Tali strutture si configurano come erma bifronte, contenenti in sé sia i caratteri storici propri della Sicilia a cavallo tra Ottocento e Novecento, sia di quelli tipicizzati dal mondo interiore dell’autore e utilizzati poi all’occorrenza in chiave comico figurale o drammatica, per testimoniare un abbassamento. Soltanto alla luce di tale risultato apparirà chiaro come sia lecito parlare di una possibile corrispondenza dall’alto e dal basso delle figure linguistiche e sociali. Laddove per alto si intende lo strato linguistico codificato nel linguaggio del padrone cui corrisponde lo schema sociale di una borghesia che, abbandonato il proprio ruolo storico assunto già alla fine del Settecento, ovvero quello di classe rivoluzionaria, si codifica adesso come la nuova aristocrazia, prendendo in sé, in tale trasformazione, tutti i caratteri conservatori e paternalistici dei ceti dominanti. E dove per basso si intende invece lo strato popolare dei vinti, per dirla con Verga, a cui corrisponde invece un linguaggio per certi versi incontaminato, autentico e realistico, fatto di modi non letterari, ma mutuato dal linguaggio comune, e ravvivato dai moduli espressivi della comunicazione orale che, nella forma di traduzione italiana, risulta spesso totalmente compromesso.
Questa corrispondenza, proprio in Verga, che in italiano scrive per gli Italiani italofoni, è possibile solo alla luce di un archetipo umano, o scenico che dir si voglia, frutto di una simbiosi operata tra realtà ed idealità, tra popolano autentico e mito del buon selvaggio, tra borghesia reazionaria e mito dell’alta borghesia progressista, insomma tra la realtà storica e la sua funzionale trasfigurazione artistica.
Insomma in tali moduli e tali schemi si codifica l’arte verista, presentando sulla scena non il vero, ma una specie di verisimile borghese, che contiene in potenza solo la smorfia dell’espressione popolare, ma che non riesce a rappresentarla in maniera nettamente fotografica, né per animam, ma mista in una specie di terzo uomo o schema mediano, creato interamente dall’autore per costruire un mostro orribile ed immobile che non può né ribellarsi né redimersi. La maschera che ne viene fuori talvolta ride talaltra piange, ma narra sempre con un unico ghigno; una morsa, quella dei vinti, che non concede rivoluzione o critica nel Mezzogiorno.
L’Italia che si affaccia al Novecento, infatti, è ancora un vulcano dentro cui, soppresse, sobbollono tutta una serie di istanze tradite, di aneliti frustrati, di colonizzazioni non compiute o compiute solo in parte. L’Italia non ha certo il volto compatto che ci si aspetterebbe dall’enfasi risorgimentale nella sua accezione neoborghese. Il processo sempre crescente di analfabetismo nelle campagne, la presenza ancora più inquietante della feudalità nell’ex Regno delle due Sicilie, la piemontesizzazione dell’Italia sotto il vessillo di casa Savoia, le cannonate del Generale Bava Beccaris sulla folla dei dimostranti a Milano per sedare la rivolta, il cerimoniale di palazzo Carignano che diede il suggello alla tanto attesa Unità d’Italia, trascinano la condizione popolare nel Mezzogiorno verso forme sempre più esasperate di rimpianto del Regno borbonico miste a una larvale creazione cooperativa di risposte rivoluzionarie.
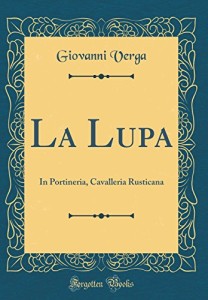 Se è vero che il grido di libertà, di unità e di indipendenza è sempre stato la bandiera su cui i carbonari-cospiratori prima, i liberal-patriottici dopo, hanno costruito un improbabile sentimento nazional popolare, è da verificare a fondo quali e quante radici reali avesse tale sentimento e a che livelli, soprattutto, esso fosse avvertito. La situazione sociale e storica degli uomini e delle donne del profondo Sud, nonché dei loro bambini era infame. I giovani erano rubati al lavoro dal nodo della coscrizione militare; i vecchi erano oppressi dagli abusi del campierato; i bambini erano sottoposti ad un efferato sfruttamento minorile nelle miniere, mentre una condizione di analfabetismo generale ritardava una forma efficace di codifica critica. Quello che l’Unità d’Italia aveva segnato era una occupazione mal riuscita di un territorio che pagava il prezzo doppio dell’eredità feudale borbonica, per il passato prossimo, e dei nuovi insediamenti filo governativi, inglesi o piemontesi, per il presente.
Se è vero che il grido di libertà, di unità e di indipendenza è sempre stato la bandiera su cui i carbonari-cospiratori prima, i liberal-patriottici dopo, hanno costruito un improbabile sentimento nazional popolare, è da verificare a fondo quali e quante radici reali avesse tale sentimento e a che livelli, soprattutto, esso fosse avvertito. La situazione sociale e storica degli uomini e delle donne del profondo Sud, nonché dei loro bambini era infame. I giovani erano rubati al lavoro dal nodo della coscrizione militare; i vecchi erano oppressi dagli abusi del campierato; i bambini erano sottoposti ad un efferato sfruttamento minorile nelle miniere, mentre una condizione di analfabetismo generale ritardava una forma efficace di codifica critica. Quello che l’Unità d’Italia aveva segnato era una occupazione mal riuscita di un territorio che pagava il prezzo doppio dell’eredità feudale borbonica, per il passato prossimo, e dei nuovi insediamenti filo governativi, inglesi o piemontesi, per il presente.
La distanza verista e la storia vicina
Nella lettera a Verdura sul progetto del ciclo dei vinti Giovanni Verga lo definiva
«una fantasmagoria della lotta per la vita, resa però coi mezzi adatti. (…) Ho in mente un lavoro che mi sembra bello e grande, una specie di fantasmagoria della lotta per la vita (…). Lotta provvidenziale che guida l’umanità per mezzo ed attraverso tutti gli appetiti alti e bassi alla ricerca della verità. Insomma cogliere il lato drammatico, ridicolo o comico di tutte le fisionomie sociali, ognuno con la sua caratteristica, negli sforzi che fanno per andare avanti in mezzo a quest’onda immensa che è spinta dai bisogni più volgari e dall’avidità della scienza ad andare avanti incessantemente, pena la caduta e la vita, per i deboli e i maldestri».
E ancora: «La sincerità dell’arte, in una parola, potrà prendere un lato della fisionomia della vita italiana moderna a partire dalle classi infime, dove la lotta è limitata al pane quotidiano»1.
Lo stesso Verga scriveva a Capuana, mostrando le nudità ed incongruenze più recondite dell’impalcatura fotografica verista, le testuali parole:
«Perciò avrei desiderato andarmi a rintanare in campagna, sulla riva del mare, tra quei pescatori e coglierli vivi come Dio li ha fatti. Ma forse non sarà male che io li consideri da una certa distanza in mezzo a una città come Milano o Firenze. Non ti pare che per noi, l’aspetto di certe cose non ha risalto che visto sotto un dato angolo di visuale, e che mai riusciremo ad essere tanto schiettamente ed efficacemente veri allorquando facciamo un lavoro di ricostruzione intellettuale e sostituiamo la nostra mente ai nostri occhi?»2
La tesi di Baldi in merito alla capacità verghiana di aggregare in gruppi distinti ed in sé omogenei le opinioni pur contrastanti delle varie frange del tessuto sociale, annullando equamente se stesso come narratore ora nell’una ora nell’altra, senza tuttavia lasciare i personaggi in uno stato di disgregazione atomistica, non giustifica l’eccessivo straniamento (per dirla con Luperini) dell’autore. Il quale, pur desiderando andare a sperimentare di persona la vita nelle case dei pescatori sulla riva del mare, ritrae se stesso da questo onere all’insegna di una specie di verismo a distanza, che predilige la contemplazione mentale alla sperimentazione dei luoghi e dei fatti da vicino. È questa stessa distanza che smonta anche l’improbabile socialismo verghiano, almeno così come lo legge Asor Rosa3.
Nell’Ottocento, infatti, la finanza, dapprima fondata sull’oro, si affina nella regolamentazione del credito, mentre si misurano su nuove basi economiche i rapporti interni allo Stato, alle sue componenti sociali e alle relazioni con gli altri governi. Dagli anni settanta in poi (passando per le tappe obbligate della prima e della seconda Internazionale Socialista) si formano le prime Unioni Contadine; le classi subalterne si coalizzano nelle prime forme di Società Operaia. C’è, anche se ad un livello ancora epidermico, ma nettamente distinguibile, la prima e vera forma di presa di coscienza da parte degli strati più bassi della popolazione, dai contadini agli operai (anche se in Sicilia di fabbriche ce ne sono ben poche); insomma tutti i salariati nullatenenti iniziano, accorpandosi, anche in Sicilia, a reagire alla miseria e allo sfruttamento, all’analfabetismo e alla fame.
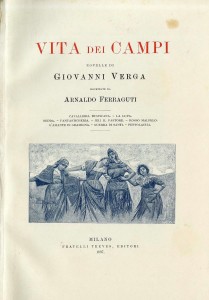 L’attività letteraria di Verga, quindi – a partire già dal romanzo Una peccatrice (1866) o Storia di una capinera (1869) o anche nell’opera di svolta che è la novella Nedda (che è del 1874), fino alla silloge maggiore Vita dei Campi (1880) – si svolge in un periodo storico in cui le spinte socialiste, o comunque le pressioni della classe operaia, proletaria e sottoproletaria, sono una realtà ben tangibile ed ampiamente, anche se disorganicamente, reclamante.
L’attività letteraria di Verga, quindi – a partire già dal romanzo Una peccatrice (1866) o Storia di una capinera (1869) o anche nell’opera di svolta che è la novella Nedda (che è del 1874), fino alla silloge maggiore Vita dei Campi (1880) – si svolge in un periodo storico in cui le spinte socialiste, o comunque le pressioni della classe operaia, proletaria e sottoproletaria, sono una realtà ben tangibile ed ampiamente, anche se disorganicamente, reclamante.
Nel 1880 esplodono i primi veri scioperi organizzati a carattere di rivendicazione. Nel 1889 s’assiste alla formazione del Partito Socialista. E tutto ciò dimostra a chiare lettere la presenza dei primi fermenti sociali anche in Sicilia. Dal basso del Paese, nelle putìe dei barbieri o nelle prime adunanze contadine, iniziano infatti a sorgere cellule anarchiche. Trecentocinquantamila persone aderirono con entusiasmo e generosità al grande moto dei Fasci Siciliani; ed è impossibile proporre un’interpretazione storica che prescinda dal livello di adesione popolare e dalla mobilità delle masse nella lettura moderna di un enorme e violento movimento popolare come quello siciliano fasciato. Non sarebbe possibile parlare di mobilitazione delle masse senza un lavoro di consapevolezza storica e critica dei problemi mista alla visione, talvolta utopica, delle risoluzioni: insomma quel che appare evidente storicamente è che le classi popolari andavano acquisendo, proprio in quegli anni, la convinzione, animata da disperazione, che il mondo poteva e doveva cambiare. Non era ancora la consapevolezza di cui parla il socialismo scientifico ma era già molto più di un brontolio sordo e solitario.
Verga e Capuana non danno un minimo di feed-back, di retrospettiva, di quello che in nuce già divampava nell’animo del popolo siciliano. Anche nell’opera maggiormente additata dai critici come la più aperta al sociale, Dal tuo al mio, Verga risolve il socialismo in un passaggio della roba, dal tuo al mio, in una sorta di baratto merceologico tra beni, che si conclude in un circolo vizioso. Si ha il netto sentore che il senso del peccato che marchia i mostri, le creature elementari nella produzione drammaturgica verghiana, assuma storicamente i contorni di una visione che non riesce a percepire, per colpa della distanza, la rivolta politica già in nuce, ovvero di una visione che, pur dicendosi veristica, non riesce a leggere la qualità rivoluzionaria dell’aggregazione sociale, per colpa del filtro ideologico di casta.
Il bisturi, ereditato da Zola, insomma, viene usato da Verga per apportare incisioni, e neanche troppo profonde, nel tessuto sociale dei vinti che vuole rappresentare, e non con lo scopo, anatomicamente più onesto, di segmentare tutte le parti della società fino a riconoscere che anche i mostri hanno, o possono senz’altro avere, un pensiero, una speranza, una coscienza. Elementari non sono, dunque, queste creature e men che mai hanno una sola piatta dimensione qualificata dal comune ambito di vinti. Brulicano di istanze e di passione, in vero, mentre cercano forme di aggregazione in grado di riscattarli dalla orribile situazione sociale.
Verga si limita ad apporre, o meglio a frapporre, dei tabù, degli schemi mediani tra i fatti e la comprensione degli stessi, tra i mostri irrazionali ed impulsivi e l’intellezione del loro operato, in modo da portare sulle scene terrore e scandalo, che sollevano lo spettatore borghese in una condizione catartica di confermata superiorità e di immunità da tali bassi appetiti.
Anche Capuana – ben accortosi dei mutamenti ideologici e sociali di quella sicilianità che voleva smettere i panni sporchi del sicilianismo per rivendicare una nuova idea di popolo e di società – denuncia quasi sconcertato ne L’isola del sole, sul finire degli anni ottanta, l’atteggiamento di quelle contadinelle che non passano più per le strade con i veli sul viso; denuncia quasi spaventato l’arroganza dei nuovi giovani che, in maniche di camicia e col berretto alto sulla fronte, ti fissano dritto negli occhi, senza più il pudìco ritegno degli anni passati, senza più quel senso di rispetto e d’onore che abitavano nella vecchia Sicilia.
Bozzetto di analisi verista per La Lupa
La Lupa, andata in scena in prima al Teatro Gerbino di Torino il 26 gennaio 1896, adattamento della novella eponima, seppur ispirata ad un fatto di cronaca nera, presenta una descrizione dei tipi e dei caratteri che ne tratteggia un andamento inverso alla realtà: dai molti all’uno, dalla voce al silenzio, dal coro all’io, laddove proprio in quegli anni la storia ci parla di singoli che si fecero fasci, di silenzi che divennero rivolte corali.
Nella scena prima dell’atto I, in cui sono posti in evidenza i caratteri del dramma (tutti escluso quello della protagonista eponima e della futura vittima delle sue febbri, Nanni) e si svolgono le massime interazioni tra i personaggi, si denota chiaramente una caratterizzazione agro-rurale in qualche modo stereotipa. Una stereotipia che si allontana ancora dal fotografico verista, in quanto tradotta in una lingua italiana, di certo sconosciuta ai soggetti che interagiscono in scena, appannaggio della comprensione del pubblico borghese dell’Italia del nord.
I personaggi vanno da compare Janu, il capoccia, serio e contegnoso come conviene alla sua età e al suo ruolo, fedele alle buone usanze antiche sin nel taglio della barba e che sputa sentenze grave e serioso al pari di Ponzio Pilato; a Malerba, il buffone della compagnia, con la sua faccia da scimmia dal ghigno malizioso; agli anonimi, tutto sommato, Bruno, Cardillo e Neli, grigi e monotoni, legati ai ritmi e ai riti della solita giornata lavorativa. Da quest’incipit, affollato di tipi umani e di interazione scenica, si scivola verso l’ultimo atto con un’impressione progressiva di impoverimento della scena, mentre emerge sempre di più l’intenzione verghiana tendente ad isolare, alla fine, il solo ed unico personaggio: la Lupa. O forse, come vedremo, il suo petto.
Nell’Atto I, scena I, il sipario si apre sull’aia, all’imbrunire, tra le capanne dei mietitori e i mucchi di covoni. Il sottofondo è dato da un vociare dei contadini che intonano delle canzoni antiche utilizzate per confermare una malinconia radicata: sono in scena Bruno, Malerba, Neli, Cardillo, Grazia, Lia, Zia Filomena, compare Janu e Nunzio. È da notare che la presenza di quelli che, d’ora in avanti, saranno sempre assunti come comprimari della vita dei campi, è segnata da rilievi psicologici secondari, marginali, anonimi o velati tra le oscure pieghe di un antico peccato culturale: la loro personalità si confonde con il coro della vox populi, dedita al pettegolezzo espresso con il mezzotono o con il mormorio.
La scena II e la scena III introducono i personaggi principali, isolandoli, quasi a volerne rimarcare la solitudine in fatto di comunicazione e di esistenza e, in ogni caso, portandoli ad un piano gerarchicamente superiore agli altri; nella scena II compare Nanni, e solo nella scena III la ‘Gna Pina, la Lupa.
Subito la Lupa viene inquadrata in una prospettiva di isolamento dettata dall’immediata ironica apertura di Malerba:
Malerba: O, ‘Gna Pina, benedetta, grazia mia,
cuore mio, venite qua che vogliamo
fare un terremoto!
Anche la risposta della ‘Gna Pina evidenzia ciò che abbiamo notato: ‘
Gna Pina: No. Voglio ballare
con compare
Nanni, se son degna
di questo onore.
Tra la scena IV e la V si verifica la presentazione di Mara, figlia de la Lupa, prima nel suo dialogo con Nanni:
Nanni: Non volete ballare neanche voi?
Mara: No, scusatemi, non ballo.
Nanni: Che avete? Le gambe molli?
O avete il cuore duro?
Mara: No, vi ringrazio, anzi…
scusatemi compare Nanni.
e poi nella scena V, paradossalmente proprio nella sua assenza, e nella scena VI, in cui ricompare a difendere la madre dall’ira maliziosa di Malerba.
Ed ecco che inizia quel processo di isolamento che si è cercato dall’inizio di evidenziare. Dalla scena VIII i personaggi avviano i processi di comunicazione a coppie di due o a gruppi ristretti di tre al massimo, con evidenti gerarchie sul piano prettamente comunicativo e con la consapevolezza, anche se non secondaria, che la propria vita è comunque posta sotto l’egida di un destino a cui è inutile opporsi. Ci si accorge solo allora di tante gerarchie e di tanti piani intermedi interni al dramma: gerarchie non di carattere socio-economico, ma vere e proprie gerarchie di comunicazione.
La Lupa non comunica, né può farlo, con nessuno dei personaggi del dramma: non può farlo con Malerba, il cui riso e la cui allegria paradossale operano uno sfoltimento semplicistico della dura vita dei campi; non può farlo con gli anonimi comprimari della vita dei campi, perché in essi non v’è traccia di un possibile lavoro d’abbozzo psicologico che possa indurre al tentativo di comunicazione; non riesce a farlo neanche con sua figlia, troppo poco esperta, troppo semplice e ingenua, concepita e realizzata com’è dal Verga al pari di un idiota capace soltanto di invocare madre, madonna, e santi del cielo, oppure di scagliare esasperate ed inutili maledizioni.
La Lupa non comunica in realtà neanche con Nanni. La figura maschile è infatti quasi predestinata ad un rapporto sessuale ed oscuro, adombrato tra le pieghe indefinite, eppur vocianti, del pudore sociale (il famigerato e sempiterno mondo in cui tutti sanno ma fanno finta di non sapere), destinato ad essere un oggetto anche nel tradizionale rapporto maschilistico-sessuale (nella Sicilia del tempo dove al marito si dà del vossia o del voscenza) e marchiato per sempre per questa colpa tanto da doverla scontare con la disperazione e l’abbrutimento.
Tutto questo, alla fine della lettura del dramma, dà il senso pieno di una solitudine abnorme che si inspessisce attorno alla vita dei personaggi ed anche (oltre alla già notata idea di convergenza strutturale imperniata sulla formazione di un solo personaggio completo a tutto tondo) il sentore di una gerarchizzazione dei piani comunicativi fondamentali.
Quasi una tragedia di frammenti sul piano dell’evoluzione testuale e di conseguenza anche scenica, quindi, quella de La Lupa, che tende per sua stessa esigenza chiudersi sempre di più nell’interno oscuro e primitivo della ‘Gna Pina.
Insomma ne La Lupa si assiste ad una regressione verso l’Io operata dal Verga su basi non certo psicanalitiche: dagli aperti spazi della campagna – quello che alcuni critici hanno definito l’agro della favola verghiana – e quindi dalle diverse maschere e/o personaggi iniziali, all’avvicendarsi, quasi spasmodico, delle scene con due personaggi soltanto, con dialoghi sempre interlocutorî, ed in ambienti sempre più chiusi, fino a quell’angolo sotto la tettoia dove l’urlo di Nanni: Ah il diavolo siete! sancisce il buio in scena e la presunzione da parte dello spettatore-lettore del compiersi del delitto liberatorio.
La figura che più pareva in procinto di prendere quota in questa conclusione, ovvero Nanni, resta alla fine eclissata da quella de la Lupa, la quale permane fino all’ultimo quale figura protagonista. A rigore, nel crescendo della chiusa, lo spettatore o il lettore dovrebbe essere preso a seguire – se non altro per uno slancio dinamico – la figura di Nanni che avanza pallido, stralunato, con la scure che luccica al sole: ma in verità è innegabile che anche in questa scena, chi domina è la Lupa, anche nel silenzio. Il suo petto nudo, scoperto dallo strappo della maglia, che accoglie il colpo ferale, è tutto il dramma di questa scena finale, così come ne era, nella novella, il primo accento. La Lupa, scrive Verga nell’opera narrativa, ha ancora soltanto un seno fermo! Nanni, di fronte a quel petto è soltanto un piccolo uomo balbettante.
C’è una specie di terrore religioso diffuso in tutto il dramma per il peccare disperato e fatale di questa donna, quasi votata al male e, quindi, al sesso senza limiti. Di questo terrore religioso è invasa per prima la stessa protagonista, la quale subisce la sua colpa, sin dall’inizio, quasi senza agire; la Lupa subisce, infatti, il suo desiderio peccaminoso come una legge inesorabile ed imperscrutabile: ‘Gna Pina lo accetta, e con esso accetta la conseguenza estrema: il freddo che placa i bollori del sangue, nel sangue. Ciò, solo esibendo quel seno, ancora soltanto fermo che la marchia di colpa, ed in un sostanziale silenzio. Non al pari delle grandi protagoniste della tragedia greca, Medea o Antigone, nel La Lupa non v’è traccia di lògos o diàlogos, né di odè. Solo frammenti rapidi. Punzecchiature. Nessuna fraseologia complessa, ma un tetro silenzio intervallato da sibili. Quanto di più lontano dall’eloquio di Medea che mortifica Giasone o delle frasi di Antigone che scheggiano le Legge dei vivi di Creonte. Nulla di più lontano da quel dire delle eroine e antieroine tragiche che schiacciano l’uditore, misurandone proprio linguisticamente il corto raggio del pensiero e dei valori.
 La catarsi rappresentativa nei teatri del nord Italia
La catarsi rappresentativa nei teatri del nord Italia
Il meccanismo che mette in moto tale rappresentazione ad un pubblico raffinato quale quello della aristocrazia sabauda è da ricercarsi non solo nella posizione sociale del Verga, ma anche in una struttura comunicativa che evochi esoticamente qualcosa di stupefacente, grottesco fino allo spasimo, in grado di ricreare pathos e nello stesso tempo terrore nello spettatore. Da questa bestialità che veste i panni del sicilianismo deriva l’archetipo di un uomo, non personaggio, che si piega sempre davanti ad un fato oscuro e imperscrutabile vivendo nell’ignoranza estrema delle sue azioni.
Non c’è mai, nei personaggi verghiani, alcun tentativo di riappropriazione di se stessi e della propria dignità morale o mentale, di intellezione finanche minima del proprio operato, di critica delle ragioni storiche e sociali. Le creature elementari, tanto discusse e tanto commentate, reagiscono impulsivamente a stimoli che non sanno né controllare né selezionare. Il fato, come una sorta di peccato originale, incombe sempre impietoso sulle vicende della storia, sugli amori istintuali, sulle scelte di vita con un’invadenza pari a quella della provvidenza di manzoniana memoria. Evidenziando tale bestialità irrazionale il teatro verghiano opera una sorta di catarsi nello spettatore ancora ottocentesca; il pubblico, infatti, certamente rivive il pathos imposto dal terrore e dallo stupore, ma lo sublima in una sorta di consapevolezza finale della propria rinnovata e confermata superiorità umana. Tutti sono più uomini di fronte ai mostri.
Dai personaggi verghiani, dalla loro espressione esotica, in un italiano solo apparentemente dialettofono, dalla loro esasperata propensione all’azione, emerge nello spettatore borghese la coscienza della propria superiorità naturale sul prototipo della bestia-personaggio, attraverso un distanziamento da ciò che accade sulla scena, che viene perciò visto come lontano ed improbabile per il proprio mondo e quindi confinato in una lontananza borghese che ne dà, poi, una parvenza di consolante assenza. Dal terrore, quindi, lo spettatore ricava il senso e la consacrazione del proprio equilibrio, della propria rettitudine morale, della propria e innegabile salvezza rispetto a quel mondo carnale, impulsivo e sanguinario. È questa la chiave di volta ottocentesca e borghese del verismo verghiano, che si dipana a servizio dell’umano ma soltanto nel suo creare, nella distanza, la mostruosità dell’archetipo siculo.
Il fosco peccato dei mostri attiva nel pubblico borghese una rinnovata coscienza di classe salva, ancor più rafforzata e stabilizzata nella propria santità (per usare il termine che più stride con peccato), nella propria immunità sostanziale, sia essa politica o sociale, dai fatti incestuosi, violenti, irrazionali, bestiali, di quella Sicilia realisticamente o veristicamente rappresentata.
Un teatro di reazione e non un teatro di rivoluzione
Le famose creature elementari, rozze a dismisura, ignoranti fino all’eccesso, malvagie sino alla soglia del demoniaco, rappresentano in tutto e per tutto la categoria o l’archetipo dell’eccesso (si ricordi a tal proposito che per Verga Rosso Malpelo è malpelo, cattivo, soltanto perché ha i capelli rossi!).
Le creature elementari in realtà elementari non sono, né quindi possono essere vere, ma esotiche; anzi esse sono il frutto di una operazione di creazione artistica che ha per modello poetico il verisimile ragionato. Non dunque creature elementari quanto creature letterarie fin troppo elaborate dalla mano verista in virtù della suddetta categoria dell’eccesso. In quest’ottica il peccato originario ed indelebile de la Lupa conduce necessariamente alla maledizione e alla perdizione del personaggio; così come compare Alfio deve per forza colpire con il coltello a serramanico per ben tre volte il rivale perché il suo onore è stato macchiato; e così come Mazzarò deve per forza essere l’accumulatore acefalo della roba – mulo più dei muli ma senza blasone – sino al limite del finale: roba mia vienitene con me!
La interazione tra i personaggi che si rende più possibile nel teatro verghiano è quella che si concretizza nello schema comportamentista della concatenazione causale tra stimolo ricevuto e risposta immediata. Manca l’organismo in grado di mediare la risposta: di contenerla, di raffreddarla, di elaborarla, di renderla intelligente. I personaggi-mostri, quindi, assumono di fronte ai valori e ai disvalori, al bene e al male, alla verità e alla menzogna, un atteggiamento passivo ma mai riflessivo. Sembra quindi che a tali personaggi sia del tutto preclusa ogni capacità di intellezione inerente i fatti ordinari e straordinari che accadono intorno a loro. Ogni stimolo ricevuto provoca una risposta immediata (ma non per questo vera e/o sincera) che si potrebbe ben dire elementare perché non filtrata attraverso alcuna capacità che possa solo dare il benché minimo sentore di una qualche evoluzione intellettiva. È più ovvio, dunque, inquadrare il crescendo che viene a determinarsi nel finale de La Lupa nei margini d’una esplosione nervosa, nevrotica ed incontrollabile, piuttosto che in una reale dinamica interna alla psiche di ogni personaggio. Nessun personaggio si evolve, nella scrittura scenica di Verga.
Tutti questi mostri dell’iper-azione devono, nel senso pulsionale ed emotivo. Non un dovere, dunque, di natura morale, ché l’etica è a loro estranea in qualche modo, ma una spinta irrazionale vestita da impulso naturale. Devono, dunque, perché sono fatti così; devono, perché il sangue che viene fatto scorrere dall’autore nelle loro vene è simile a quello delle bestie istintive che reagiscono di scatto alla vera o presunta aggressione. Devono, perché la loro legge è soltanto quella dettata dalla lotta per la sopravvivenza, come ostriche che cercano di star ferme sullo scoglio che impedisce d’essere spazzate via della corrente; devono, perché per loro vige ancora la legge del taglione; devono, perché la loro ignoranza è alimentata dall’assenteismo e dalla latitanza delle istituzioni etiche, sociali, religiose; devono, perché lo Stato, in Sicilia, serve soltanto ad essere eluso proprio perché visto sin dal primo impatto garibaldino come estraneo.
Ecco perché mentre la Sicilia aveva bisogno di un teatro, di un romanzo, di una letteratura in genere di riabilitazione, di denuncia, di rivoluzione, Verga le propose invece una serie di novelle, romanzi e drammi di reazione, di presunta descrizione verista, che in realtà celavano il desiderio delle classi dominanti e sfruttatrici di tenere le creature elementari in quello stato di ignoranza e di soggezione facilmente dominabile, senza che mai una qualche coscienza o dignità della Sicilia post-unitaria potesse prendere le mosse e divenire, come onda, impetuosa e devastante.
Perché è vero ieri, come è vero oggi, che un popolo rozzo e incolto è molto più facile da dominare rispetto ad uno colto e ricco di intelligenza della storia e della società. E quindi del mondo stesso, e della vita. Altrove, ad esempio, Giuseppe Giusti Sinopoli (1866-1923), autore teatrale sconosciuto ai più, con La Zolfara raccontava davvero con verismo la condizione inumana in cui versavano le zolfatare dell’Isola, dove lo sfruttamento e la malversazione minorile convergevano nell’arricchimento del potere dominante. Ma questa sarebbe, appunto, un’altra storia, davvero verista4.
Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020
Note
[1] G. Verga, Lettere sparse, a cura di G. Finocchiaro, Bulzoni Roma 1979: 79-80.
[2] G. Verga, Lettere a Capuana, a cura di G. Raja, Le Monnier Firenze 1975: 114.
[3] G. Baldi, L’artificio della regressione, tecnica narrativa, ed ideologia del Verga verista, Liguori, Napoli 1980; A. Asor Rosa, Il caso Verga, Palumbo Palermo 1975; R. Luperini, Verga moderno, Laterza Roma Bari 2005 e R. Luperini, Giovanni Verga. Saggi (1976-2018), Carocci Roma 2019.
[4] G. Giusti Sinopoli, La zolfara. Dramma in tre atti, Feltrinelli Milano 2018. S. Pattavina, Teatro Siciliano, edizioni Dharba Palermo 1990, vol I.
______________________________________________________________
Giacomo Bonagiuso, laureato a Palermo in Filosofia, poi in Lettere, ha conseguito il Dottorato Internazionale di Ricerca in «Etica e Antropologia» presso l’Università degli Studi di Lecce, con un periodo di studi a Friburgo, sotto la guida di Bernard Casper, allievo di Martin Heidegger. Si è specializzato presso la Scuola di Alta Formazione di Aqui Terme in Letture Filosofiche della Bibbia. Studioso del pensiero ebraico, si è recentemente occupato anche del rapporto tra la filosofia e le arti, in specie il teatro e il cinema. Ha insegnato Etica Pubblica nell’Università di Palermo e diretto il Teatro Selinus di Castelvetrano Selinunte e la sua Scuola per giovani interpreti. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: Nòstoi, gli eterni ritorni (1993); Il Mago della Pioggia (1998); Non credo più (1997); Sum. Cogito. Ergo? Frammenti di finesecolo (2000); Forme cave del non. La fabbrica del teatro e il paradosso del cinema (2009); La soglia e l’esilio. Asimmetrie di tempo e spazio nel Nuovo Pensiero ebraico (2009).
______________________________________________________________












