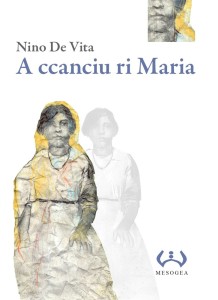Walter Benjamin ha annotato che non occorre viaggiare per avere qualcosa da raccontare. Il narrare è pratica quotidiana, coincide col vivere, appartiene alla oralità e alla colloquialità delle esperienze di tutti i giorni. Costitutivo e fondante della natura umana, il racconto abita nelle prime forme della comunicazione, fin dalle origini filogenetiche della evoluzione, essendo facoltà umana elementare, universale, transculturale. Lo hanno certificato gli studiosi della fisica della mente ma anche, sotto altri aspetti, gli antropologi, i quali hanno documentato i nessi intimi e inscindibili – fin dall’infanzia, fin dalla preistoria – tra il narrare e il conoscere, tra la genesi del linguaggio e la elaborazione dei racconti. Ciò che distingue gli uomini dagli animali sembrerebbe non essere la parola in sé ma la parola che si fa metafora, immagine, intreccio, trama, la costruzione di una storia, la capacità di connettere cose, nomi ed eventi e disporli su un ordinato asse spaziotemporale.
Sia essa simulazione o ricostruzione, finzione o realtà, nel gioco simbolico del “come se” che è parte fondamentale del patrimonio esperienziale con cui si viene al mondo, la narrazione attraversa tutte le culture, articola il vocabolario di tutte le lingue, corrisponde ad un bisogno avvertito da tutti gli uomini. Raccontare significa un po’ migrare, trascendere i confini della propria individuale esistenza, istituire una relazione, mettere una storia in comune e così transitare da una vita ad un’altra, da una identità ad un’altra. Mentre narriamo siamo narrati, essendo ciascuno di noi – da testimone o da protagonista, da locutore o da interlocutore – dentro tutte le storie che abbiamo sentito e che abbiamo raccontato. «Ognuno di noi è una sorta di crocicchio ove le cose accadono» – ha scritto Lévi-Strauss – e dove le storie si embricano, – aggiungiamo noi – si moltiplicano, si ibridano, trapassano nell’immaginario, che non è l’opposto del reale ma rende il reale verosimile e intelligibile proprio perché narrabile. Anzi, a guardar bene, il mondo che esperiamo deve essere immaginabile e immaginato per dirsi davvero reale. La plausibilità di ogni fatto di scienza o di ogni atto di fede ha bisogno di una storia che lo ispiri, di un racconto che lo spieghi, di una trama che lo sostenga.
Da qui hanno origine i miti, da qui nasce la letteratura, che altro non è che narrazione, fascinazione, produzione di metafore, invenzione di universi paralleli. Nel dipanare i fili ingarbugliati della vita vissuta perché sia rappresentata, le storie che diventano racconti – con un inizio, una fine e una serie di vicende nel mezzo – organizzano e ordinano il mondo, costruiscono un orizzonte di senso, dispiegano un disegno, un percorso, un destino. «La narrativa d’ogni tipo, d’ogni tempo e d’ogni paese – ha acutamente affermato Italo Calvino – mi si presenta con l’immagine d’una foresta di storie, dove a un primo sguardo sembra che ogni pianta si confonda con le altre, ma appena si fissa l’attenzione ci si accorge che nessuna pianta è uguale a un’altra». Non menzogna né artificio, la letteratura è la fabbrica delle storie, la mappa delle vite possibili e verosimili, il catalogo delle esperienze impossibili e inverosimili. Contiguo e per vie carsiche consanguineo dell’antropologo con il quale intrattiene rapporti di reciproca fecondazione in quanto raccoglie le voci e studia le vite degli altri, il narratore possiede la capacità, secondo la felice definizione di Orhan Pamuk, di «raccontare la propria storia come se fosse la storia di un altro e la storia di un altro come se fosse la propria».
A fronte della crisi contemporanea delle “grandi narrazioni”, documentata da Jean-François Lyotard nella sua nota tesi sulla condizione della postmodernità, restano quanto mai vitali e consustanziali allo stesso mondo digitale del nostro tempo le storie che trovano oggi nel modello dello storytelling uno straordinario pullulare di agenzie mediatiche. Quando all’ipertrofia dell’immagine si accompagna l’atrofia dell’immaginario, in corrispondenza simmetrica all’impoverimento progressivo dell’esperienza surrogata dalla tecnologia virtuale, la narrazione da dispositivo conoscitivo ed ermeneutico può convertirsi in potente strumento suasivo al servizio della comunicazione politica ed economica destinata a colonizzare e plasmare le menti dei consumatori e degli elettori. In questo contesto i confini tra finzione e verità si vanno sfocando fino a sovrapporre e confondere le due dimensioni, cosicché la pervasività del reality sostituisce la realtà e tocca alla letteratura, quella fuori dai format della fiction, ristabilire il valore sociale del narrare, quel suo dare ordine al disordine del vissuto aprendo inediti spazi di senso tra le invenzioni dell’immaginazione e la scorza dura dei fatti realmente accaduti. Senza dissolvere la realtà effettuale in un gioco artificioso di proiezioni fantasmatiche, la narrazione in letteratura, coniugando semantica e fonetica, ha la proprietà di risolversi in un processo cognitivo che attinge alla genesi del linguaggio, alle radici della civiltà dell’uomo. Tra noi e il mondo, prima di ogni altra mediazione strumentale, ci sono sempre state le parole del raccontare. E da Omero a Borges abbiamo imparato che gli uomini prima che alla specie sapiens appartengono a quella narrans.
Che la letteratura sia uno straordinario palinsesto di storie in cui fatti e protagonisti sono veri anche quando sono inventati, essendo davvero reale ciò che è reale nelle pagine della narrazione, è assunto che trova una esemplare attestazione nelle poesie di Nino De Vita, la cui vocazione al racconto appartiene all’uomo, prima ancora che al poeta, al suo modo di essere, di entrare in rapporto con gli altri, di stare nel mondo. La sua naturale attitudine al fascino dell’affabulazione, la sua predisposizione a trasferire nella scrittura le risorse performative dell’oralità, quel bisogno e quel piacere di costruire microstorie nel largo respiro dei settenari, ci riconducono alle ragioni antiche e profonde per le quali narriamo, alle forme elementari di memoria sociale nate attorno al fuoco nelle veglie delle prime comunità. Nella grammatica di questo modello narrativo è possibile individuare temi, tecniche, simboli, procedure, stili e ritmi propri della cultura popolare, un vasto corpus di materiali letterari di interesse antropologico, una morfologia e una sintassi prossime, per taluni aspetti, al di là delle evidenti differenze di ordine espressivo, al codice tradizionale dei contastorie.
Che scriva in versi ma preferisca il registro del racconto non è la sola singolarità della sua figura di poeta. Se è vero che Nino De Vita compie, in fondo, il percorso simmetricamente inverso ma sostanzialmente uguale a quello privilegiato da Vincenzo Consolo che scriveva poesia in forma di prosa, frutto di una ricerca e di una scrittura filologicamente accurate, è anche vero che la sua poesia sfugge ai generi convenzionali, attraversando e contaminando nella messa in forma dei testi le suggestioni dell’apologo e la trama dei lazzi e delle facezie di certa novellistica siciliana, la cantabilità delle ballate e le asprezze dei drammi che irrompono nella vita quotidiana, la ritualità teatrale dei fatti scanditi da dialoghi e contrappunti sonori unitamente agli accenti di un’epica di vinti e di antieroi, senza cavalieri e senza dèi. Racconto lirico o pura narrazione, ai confini di più linguaggi, l’insieme di storie – ciascuna delle quali costituisce un unicum – compone un mosaico strutturato di trame e di intrecci, descrive il paesaggio di un mondo abitato da un’umanità che letterariamente porta i segni dell’identità siciliana: la ragione sofistica e la corda pazza, la luce e il lutto, il miele e il fiele, le contraddizioni e le congiunzioni degli opposti, le manie e le stramberie, la prepotenza e la violenza ma anche la grazia e la pietà.
Non meno singolare, se non unica, è la lingua del poeta, il dialetto di una sperduta contrada del marsalese che ha nome Cutusìo, piccolissimo grumo di case che nella poesia come nella vita di Nino De Vita è parafrasi di quel sentimento dell’abitare la terra vissuto come radicamento e iscrizione della presenza umana nel mondo. Attorno a questo luogo della memoria e alla memoria del luogo, axis mundi e fondamentale fulcro generativo della revêrie del poeta, ruotano i protagonisti dei piccoli fatti che hanno il potere epifanico di svelare grandi verità. Qui ogni cosa, e ogni accadimento pur non essendo fuori dall’ordinario, assume un riverbero di luce straordinaria, una non comune densità simbolica. Il poeta ama l’infinitamente piccolo: il dettaglio degli oggetti inanimati che d’improvviso si animano; le più minute sfumature dei gesti e delle posture dei personaggi, le impercettibili screziature del viso e del corpo
(«c’u ùvitu appuntiddatu/ nno mànicu ra zzappa»; «Taliava ô nfacciu r’idda;/ ddoppu arristau a mmicciari/’ i manu chi s’avia/ agghiummuniatu ncapu/ ’u ventri»).
Dentro questo angusto perimetro spaziale, che è centro nodale dei legami territoriali e genealogici, orizzonte ideale e sentimentale, una sorta dell’Aleph di Borges, «il luogo dove si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli angoli», si consuma, ancora una volta, la storia narrata nell’ultimo suo libro, A ccanciu ri Maria (Mesogea 2015), la piccola vicenda di un amore e di una beffa, sul filo di un paradosso eminentemente siciliano. L’ordito di una fuitina è al centro della fabula ovvero della materia del racconto ma è nell’intreccio, cioè nella sua dinamica interna, nella costruzione del discorso e nella sua architettura formale che rivela la sua efficacia poetica. Scabro e abbastanza semplice è il fatto: Pietro ama riamato Maria e decide di rapirla ma al posto dell’innamorata, per una serie di circostanze non previste, finisce nella notte per portarsi a casa la sorella Margherita, destinata a Calogero ma poi sposata a Pietro.
Anche Maria
– «passatu ’u tempu ri / còlluri »– andrà in sposa ad altro uomo, «unu ru Dàttulu,/ mi pari».
Nel microcosmo dei vinti descritto dal poeta sui sentimenti e sulle volontà degli uomini sembra prevalere la tirannia di un destino che verghianamente o leopardianamente schiaccia i poveri cristi ad una rassegnata condizione, all’arcano e oscuro garbuglio di una vita «chi mpirugghia». Ciò che accade sta nell’ordine misterioso e ineluttabile del nascere e del morire, sotto il cielo di una Storia che asseconda i segni e i disegni della Natura, con il volgere eguale delle stagioni, le mille e diverse forme creaturali dell’esistere nella terra abitata, in una relazione di reciproca dipendenza, da uomini, piante ed animali. Ancora una volta, nella poesia di Nino De Vita il paesaggio è presenza pervasiva e totalizzante, la campagna è quella permeata dalla civiltà contadina, è il timpuni assulazzatu del feudo, tra alberi di mandorlo e di ulivo, distese di vigne e qualche gelso e fico. Ma nella dimensione panica della vita è il selvatico a dominare sul coltivato:
«cannizzola e frattumi», «truffazzu ri curriola», «giummara/ nno mezzu, ê latu, irvazza/ mintastru, cuta, spini, / felli».
Non un idillio teocriteo né un bozzetto bucolico evoca lo scenario brulicante di umori dentro il quale si muovono i personaggi di questa storia, protetti e accompagnati da uno sguardo benevolo, da un laico sentimento di pietà, da un unico abbraccio che stringe tutta la comunità degli abitanti.
Il poemetto è un sapiente alternarsi e intrecciarsi di sequenze descrittive e narrative, di squarci sulla natura circostante, su piante, macchie e acque dei canali, apparenti digressioni che interrompono e scompongono l’ordine logico e cronologico del racconto, ne articolano o spezzano il ritmo, ne accentuano la tensione. L’anacronia ovvero la discordanza tra la successione reale dei fatti e quella rielaborata del discorso produce un effetto di rimescolamento non solo temporale ma anche semantico. Costruita à rebours con la tecnica raffinata dell’incastro, in modo che gli accadimenti nella loro esposizione retrospettiva procedano a salti nel tempo e nello spazio, rincorrendosi e rimbalzando avanti e indietro in un sorprendente gioco di rinvii interni, la storia sembra voler raccogliere gli accenti dei diversi testimoni in un’eco polifonica che certo non nasconde né tanto meno dissolve l’io narrante dell’autore ma lo mimetizza e lo accorda nel concerto delle altre voci, essendo meno onniscente e più interno alla prospettiva di ciò che fanno e pensano i personaggi. I contrappunti temporali e lo slittamento dei punti di vista danno vita ad un percorso narrativo spiraliforme che in più punti svela dei significati e altri ne occulta o sospende, per giungere infine all’epilogo in cui precipita l’evento con le sillabe di sgomento che rompono il lungo silenzio della donna rapita a ccanciu ri Maria.
Il poeta racconta e nel mettere in forma di versi l’esile vicenda ne cerca e ne dipana il senso profondo, senza mai giudicare e senza mai rinnegare l’intima appartenenza a quel mondo in cui riconosce la sua infanzia e la sua memoria. La storia stenta a svolgersi e trasferirsi nella scrittura, confessa lo stesso autore:
«Eu scrìvila vulia/ sta storia. E ammeci ’i cosi/ ch’avia a cuntari ’un si/ facìanu».
I fatti non si compivano, restavano sospesi, si inceppavano, «come uno zolfanello che si è inumidito, un colore che sbiadisce…», precisa De Vita, che più avanti ribadisce la sofferta e travagliata genesi del raccontare quanto aveva ascoltato:
«Siddu una ngagghia cci/ fussi, una canniatura,/ pi sfilittari ru/ chiuppu ch’un si spirugghia…»
Sente il bisogno di liberarsi dal groppo di quella notte, perché di quell’offesa deve scrivere, «della sventura nell’oscurità». Nella sua struttura il poemetto in più passaggi sembra flettersi in forma di metaracconto, in cui l’autore, all’ombra del gelso o chiuso nella sua stanza, rivela al lettore le ragioni dello scrivere, interrogandosi sulla natura stessa del narrare, sulle stesse procedure nel loro farsi – dal fatto all’antefatto, al climax, come in una partitura cinematografica con flashback e ralenti – sul difficile e doloroso viatico necessario per giungere a una qualche conoscenza della realtà:
«Ô ciuciuliu pinzai,/ tramazzatu, all’accupu,/’u rriminìu ri dda/ notti…».
Il cunto non sarebbe tale senza il suo speciale codice di scrittura, senza quella lingua inimitabile e impareggiabile che è il dialetto di De Vita, un unicum che, nel restituire la voce degli uomini di Cutusìo, sembra essere proiezione empirica e concreta estroflessione dei luoghi come dei corpi degli abitanti. Segni autobiografici in quanto strettamente connessi alla scoperta infantile del mondo, i vocaboli recuperati dal poeta sono il frutto di una ricerca condotta tutta all’interno delle possibilità espressive della lingua orale. Da qui l’uso delle iterazioni e dell’ellissi, dei dialoghi e della teatralizzazione scenica, della perfetta mimesi dei linguaggi non verbali. Così, per esempio, è efficacemente espressa la passione di Pietro per Maria:
«Unn’a finia, ’un finia,/ siruti ncostu Petru ri talialla./’U mussu cci ammicciava/ siddu rriria, ’u curaddu/ ri labbra si parlava,/’u sangu annunca cci/ bbuttiava».
E Maria si ritraeva timida, arrossiva:
«s’arrisagghiava,/ russiava».
Il confronto con la pagina a fronte della traduzione in italiano è uno splendido corpo a corpo, una sfida che dimostra quanto sia vero ciò che ha scritto Italo Calvino: «Sappiamo tutti che la poesia in versi è intraducibile per definizione; ma la vera letteratura lavora proprio sul margine intraducibile di ogni lingua». Nel fragile e segreto colloquio tra le due lingue che si guardano a specchio senza che l’una sia calco letterale dell’altra, le parole si illuminano di nuova e originale linfa e si compenetrano vicendevolmente nei significati come nelle sonorità metriche. Un esempio tra i tanti della viva tensione tra lessico e semantica:
«Nno celu fa mutanzia,/ agghica ’u mmernu e ngagghia/’i cosi tutti nuri./ Si ncanìa/ nne ciaramiri ’u ventu,/ ciucia pi nne ciaccazzi/ ri porti».
«Nel cielo il tempo muta,/ arriva l’inverno e trova/ le cose tutte nude./ Si intana/ nelle tegole il vento,/ soffia nelle fessure/delle porte».
Nel laboratorio linguistico di Nino De Vita il dialetto non ambisce a farsi colore locale, non insegue ingenui purismi né indulge in compiaciuti estetismi, tanto più che declina storie dure e vere e non si estenua nella regressione in un mondo primitivo né si rifugia nell’intimismo e nella evasione lirica e nostalgica. La lingua del poeta non è invenzione iperletteraria né struggimento vernacolare. Non è artificio di arido sperimentalismo né arcadico e arcaico sentimentalismo. È la koinè di una piccola comunità, che il poeta salva dall’oblio, recupera con acume filologico ma anche con sensibilità diaristica, restituisce come un dono ricevuto, un debito da sciogliere, una voce materna, riplasmata e mescidata nel liquido amniotico delle prime esperienze esistenziali. In bilico tra oralità e scrittura, le parole sono atti d’amore, segni di un alfabeto di affetti, epifanici ricongiungimenti di significati e significanti. Potremmo ripetere per De Vita quanto a proposito del dialetto ha magistralmente scritto Luigi Meneghello: «La parola del dialetto è sempre incavicchiata alla realtà, per la ragione che è la cosa stessa, appercepita prima che imparassimo a ragionare, e non più sfumata in seguito, dato che ci hanno insegnato a ragionare in un’altra lingua. Questo vale soprattutto per i nomi delle cose». Quel che ha ascoltato, osservato, vissuto, il poeta racconta, come un contastorie sul filo della memoria, come l’Ulisse omerico che nella reggia di Alcinoo non narra di imprese eroiche ma del travagliato periplo dei mortali. Così Nino De Vita assume quel piccolo universo creaturale e pulviscolare che abita nelle appartate contrade di Marsala a teatro universale in cui si gioca il destino dell’uomo e si scopre il senso o il non-senso della Storia. C’è sicuramente qualcosa di più dell’osservazione partecipante dell’antropologo nello sguardo del poeta. C’è la dimostrazione che – nel segno del racconto quale paradigma di conoscenza del mondo e della vita, dell’umana perenne ricerca delle ragioni anche in ciò che non ha ragione – antropologia e letteratura spesso si stringono la mano, si abbracciano, sono più che compagne. Sono sorelle.
Dialoghi Mediterranei, n.15, settembre 2015
________________________________________________________________
Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia.
________________________________________________________________