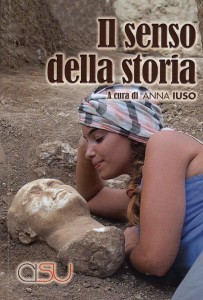Da quando gli storici degli Annales hanno dimostrato che la storia e l’antropologia, almeno per i fenomeni di “lunga durata”, sono complementari, i rapporti fra le due scienze si sono fatti più espliciti e più continui. Così le iniziative e le attività di quelle comunità in cui sono in corso processi di patrimonializzazione e, nello stesso tempo, tutte le autobiografie e le biografie di personaggi che hanno vissuto importanti vicende storiche e sociali diventano occasioni di nuove riflessioni per gli studiosi delle due discipline.
Dei libri usciti recentemente, che affrontano questi temi, ne illustriamo qui due; il primo riguarda l’uso della storia e delle tradizioni culturali di certe comunità, nostrane ed esotiche (Il senso della storia, a cura di Anna Iuso, CISU, Roma 2018); l’altro contiene invece una lunga intervista con la quale Antonio Fanelli ricostruisce la biografia di un atipico personaggio che è stato uno dei protagonisti politici dell’Emilia negli anni 1945-90 (Carlèn l’orologiaio. Vita di Gian Carlo Negretti: la Resistenza, il PCI e l’artigianato in Emilia-Romagna, Il Mulino, Bologna 2019).
Il senso e l’uso della storia
Il libro curato da Anna Iuso documenta abbastanza ampiamente quelle attività che vanno dalla rievocazione alla ricostruzione e alla patrimonializzazione, e che vengono realizzate col ricorso all’uso e spesso all’abuso della storia. Tutte queste iniziative sono di grande interesse per gli antropologi che ne possono studiare le motivazioni, possono seguirne i conseguenti processi culturali e possono riflettere sugli esiti che raggiungono.
Ad affrontare la questione posta dal titolo del volume è un gruppo di studiosi che si sono dedicati all’esame delle pratiche di utilizzazione della storia orale e degli archivi in diverse parti del mondo. I loro contributi hanno il pregio di farci capire in cosa consista la patrimonializzazione per le diverse comunità e di farci conoscere i modi e i mezzi con cui una comunità si appresta a condividere il patrimonio di conoscenze, di valori ed esperienze culturali del passato con lo scopo di costruirsi una qualche identità. Inoltre, le informazioni e le riflessioni che ci vengono date ci fanno vedere come, nel tentativo di scrivere un’altra storia, elementi tradizionali si intreccino con valori e modi della cultura di massa e come quest’intreccio metta insieme classi sociali diverse.
A queste problematiche si aggiungono altre due questioni: la prima riguarda una ricostruzione affidabile della storia di quelle comunità per le quali non esiste una documentazione scritta delle loro vicende etniche, politiche e culturali, che può avvenire attraverso il recupero delle narrazioni orali; la seconda è più espressamente politica e attiene al fatto che l’uso della storia, orale e scritta, diventa strumento di lotta per la conquista del potere, mentre, per quelle comunità soggette al potere straniero, il recupero delle tradizioni si trasforma in supporto alla rivendicazione di una indipendenza dal dominio coloniale.
Oltre all’introduzione della Iuso, il volume comprende, raccolti in due sezioni (Usi e disusi; Saperi diffusi), il contributo di Fabio Dei che, pur parlando di vicende italiane, dà le coordinate teoriche per valutare i fenomeni studiati; seguono poi i saggi di Matteo Sottilotta, Stefano Maltese, Giacomo Nerici, Matteo Aria, Matteo Gallo, Fulvio Cozza e Francesco Aliberti che ci informano su vicende che interessano l’Europa, l’Africa e l’Oceania.
Sottilotta, ci parla delle tombe dei re del Buganda (dette masiro) ed in particolare di quelle di Kasubi, il cui clan, manipolando fonti archivistiche ed orali, cerca di impedire che altri clan possano sottrargli il potere politico e, nello stesso tempo, è impegnato ad emancipare il potere centrale dalle tradizioni religiose e culturali in uso dai clan in epoca precoloniale.
Abbastanza simile a quella ugandese è la vicenda, su cui ci informa Stefano Maltese, relativa agli Nzema (Ghana) presso i quali i chiefs oltre ad essere detentori di un diritto sulla terra, sono anche custodi della memoria degli antenati. Ancora in periodo coloniale, si aprì una lunga controversia tra i chiefs per la conquista del potere politico; la contesa, che dura tutt’ora, avviene sia contrapponendo una contro l’altra le diverse narrazioni storiche orali, sia servendosi della documentazione archivistica, sia portando in tribunale i propri avversari con lo scopo di ottenere dai giudici sentenze che attestino la veridicità e la legittimità delle proprie ricostruzioni storiche. La patrimonializzazione auspicata da tutti i chiefs, conclude l’Autore, serve solo «per usi politici interni».
Giacomo Nerici si occupa di quella parte del popolo Sami, una volta allevatori e pastori di renne, che vive nella zona settentrionale della Norvegia. Essi sono stati emarginati dal «carattere omologante dell’assistenzialismo statale» che, volendo considerare tutti uguali i propri cittadini, ha negato alle comunità del Nord qualsiasi diversità culturale. Dopo la seconda guerra mondiale queste hanno riscoperto il loro passato, riappropriandosi di quanto c’era nei musei e nella documentazione di ispirazione egemonica; nello stesso tempo qualcuno ha ripreso l’antica cultura sciamanica, ricorrendo, però, a fenomeni similari di altri popoli e perfino a elementi di culture legate alla New Age. Attualmente il popolo dei Sami è diviso: tra di loro c’è chi, ripudiando il passato, considerato troppo arcaico, accetta le nuove forme di convivenza moderna; e c’è chi, invece, non accettandole perché imposte dallo Stato, tenta di ricostruirsi una storia propria appoggiandosi a quel poco che resta della loro tradizione culturale.
Matteo Aria e Matteo Gallo si occupano di comunità dell’Oceania alle prese con il recupero della propria storia. Gallo narra le vicende delle popolazioni Kanak della Nuova Caledonia che il governo coloniale francese ha privato di ogni memoria; ed invece la memoria c’era, scolpita su pietre collocate su una zona dell’isola, i pètroglyphes. Sennonché il tempo e i colonialisti hanno fatto dimenticare la loro presenza. Oltre i Kanak, sono alla ricerca di un proprio patrimonio culturale anche i caldoche, i discendenti degli europei che per primi abitarono quelle zone.
Molto interessante la situazione nelle isole della Polinesia francese, specie di Tahiti, dove il processo recente di patrimonializzazione si affida alla ricostruzione e alla evocazione, senza rifiutare anche forme di spettacolarizzazione (a volte fruibili a pagamento), ma con un’evidente e forte presenza del «ruolo creativo e generativo della tradizione». La riappropriazione del passato va di pari passo con il tentativo di conquistare l’indipendenza dalla Francia. Ciò non toglie che la Fête, la più importante manifestazione della cultura tahitiana veda unite la cultura indigena e quella coloniale.
Fulvio Cozza e Francesco Aliberti ci riferiscono di due modi di “fare storia” che possiamo mettere a confronto con quelli raccontatici negli interventi di Sottilotta e di Maltese, che spiegano come le narrazioni non ufficiali riescano, con le “piroette logiche” di cui parla la Iuso, a manipolare le vicende del passato.
Il primo ricostruisce la storia di una cittadina calabrese, oggi abbandonata dai suoi abitanti, basandosi non sui documenti storici né sui racconti orali, ma rileggendo i testi scritti da Giovanni Giuranna, un compaesano che raccontava la storia del paese mescolando la documentazione storica con i racconti di tradizione orale. In conclusione, Cozza come ricercatore non può negare la validità scientifica degli studi, ma come ex membro di quella comunità, non può che parteggiare emotivamente con la ricostruzione piuttosto fantasiosa del Giuranna.
Francesco Aliberti è stato incuriosito da un gruppo che su Facebook pubblicava vecchie fotografie (anni ‘60-‘80 del secolo scorso) del quartiere Montesacro di Roma con commenti che si riferivano sia alle trasformazioni urbanistiche avvenute negli ultimi decenni, sia ai diversi modi con cui si manifestava la presenza delle persone ritratte. La pubblicazione delle foto rispondeva in primo luogo all’esigenza di esprimere un sentimento di nostalgia per la perdita di tratti tipici del quartiere e per riaffermare la propria “romanità”; successivamente, confrontando l’oggi con la grandezza di Roma antica, le foto sono servite a sottolineare il degrado della città degli ultimi anni. Nessuno del gruppo, però, si chiede il perché di questo degrado, quasi che la situazione odierna si sia creata da sola, senza l’intervento o la non-azione di alcuno.
Questo il sunto dei contributi. Da parte sua, nell’Introduzione Anna Iuso comincia con la considerazione che «tutto il lavoro di selezione, che le memorie personali e di gruppo operano sul proprio vissuto, tende all’individuazione di un ordine diacronicamente costruito, che miri a legittimare l’agire del presente e giustificare l’operato del futuro». Rileva poi che coloro i quali si assumono l’incarico di ricostruire e ordinare gli elementi sono persone che non hanno a che fare con il potere o con l’accademia: si tratta di singoli o di gruppi che, per motivi politici o per collettivi velleitarismi identitari cercano di tracciare una narrazione storica che intreccia fatti veri con vicende più o meno verisimili. Le loro “storie” non sempre collimano con quella ufficiale, che anzi spesso è contestata in parte o del tutto; addirittura la Iuso scrive che queste narrazioni a volte contengono «piroette logiche ed interpretative per riuscire nell’intento di dare un senso alla storia della propria comunità». E comunque chi trasmette questo tipo di storie ritiene di farlo legittimamente.
Diverso è il caso, aggiunge la Iuso, della riscrittura della storia quando le esperienze archeologiche danno indicazioni certe, tali da dare spessore concreto alle leggende popolari; in questo caso alla storia va attribuito un nuovo valore in quanto “bene comune” da valorizzare (l’esempio riportato è quello di Torremaggiore, località dove morì l’imperatore Federico II).
A Fabio Dei tocca, come dicevo poco più su, di esaminare i fenomeni in atto per inquadrarli nel più generale quadro della circolazione culturale, per dedurne linee direttive, per saggiare l’efficacia delle analisi antropologiche. Le sue riflessioni riguardano soprattutto la situazione italiana e si basano su una ricerca da lui progettata sulle numerose feste “storiche” nate negli ultimi decenni. Dopo aver distinto le rievocazioni dalle ricostruzioni, Dei traccia velocemente la storia di queste iniziative, ne individua gli animatori che spesso agiscono al di fuori delle istituzioni, dando vita, ed è questa la novità, a delle “comunità patrimoniali” come quelle teorizzate dalla Convenzione di Faro. Queste attività nate “dal basso” hanno in qualche modo cambiato le funzioni delle discipline antropologiche che invece di patrimonializzare il passato «sono divenute discipline che studiano i processi di patrimonializzazioni del passato». Riprende poi le considerazioni di Lowenthal secondo il quale mentre una volta la nostra attenzione era rivolta a trovare nel presente tracce del passato cui non si voleva rinunciare, oggi invece la patrimonializzazione serve a segnare, nei confronti del passato, «la radicale differenza e la peculiarità identitaria» della comunità. In queste celebrazioni del passato Dei nota che accanto ad elementi autentici coesistono forme e stili della cultura di massa che sono negativamente giudicati da antropologi e folkloristi.
Come si diceva prima, le argomentazioni di Dei costituiscono un quadro completo di tutte le problematiche connesse alla patrimonializzazione, per ognuna delle quali ci sono risposte utili, come quella importante, mutuata da Bausinger: alla base di tutte le iniziative di acquisire un patrimonio culturale c’è «la dinamica della cultura popolare; più gli orizzonti esistenziali (spaziali, temporali, sociali) si espandono e si fanno strutturalmente invisibili, più sentiamo il bisogno di ricrearli simbolicamente attraverso il lavoro della cultura».
Il libro, malgrado tutti i contributi non abbiano la stessa forza persuasiva (alcuni mostrano un’esposizione poco ordinata e prolissa), ha certamente il merito di mettere a confronto le varie esperienze che si svolgono nel mondo a proposito di patrimonializzazione. Non si tratta solo di iniziative che cercano di ricostruire una narrazione storica affidabile, come nel caso di popoli dell’Africa e dell’Oceania, o di proposte da avanzare all’Unesco per un riconoscimento ufficiale, da parte di comunità italiane, ma anche di atipiche ricostruzioni storiche tra nostalgia, come quella del gruppo romano, e fantasia come quella raccontata da Cozza, o come quelle dei Polinesiani che mescolano vicende vere con storie ipotetiche.
I contributi pubblicati nel libro ci offrono l’opportunità di fare altre considerazioni. In alcuni processi di patrimonializzazione ci sono evidenti segni, da parte di gruppi politici o etnici, di manipolazione della storia, sia quella di tradizione orale, sia quella scritta. La cosa non ci deve scandalizzare perché, almeno da Giulio Cesare in poi, sappiamo che le narrazioni storiche spesso sono esposte attraverso il filtro di interessi personali o di gruppo (e come si dice volgarmente: “la storia è scritta dai vincitori”). Sappiamo anche che là dove non ci sono fonti certe è possibile piegare il corso della storia a favore della propria parte o contro la parte avversa. A volte, nascono narrazioni “altre” che si oppongono alla storia ufficiale in maniera più o meno forte, ma quasi sempre poggiando su basi deboli e confuse, come è di certi movimenti nati in Italia negli ultimi anni del secolo scorso (leghisti, neoborbonici, meridionalisti alla Pino Aprile). Possiamo dire che il senso della storia non è uguale per tutti. Il fatto è, come scrive Fabio Dei, citando Lowenthal, che spesso si confonde la storia con la celebrazione di un passato più fantasticato che vero, più sognato che reale, nel tentativo, in un mondo spaesato, di darsi un’identità. E forse è difficile, se non impossibile, che questi due modi contrapposti di sentire la storia possano trovare una sintesi.
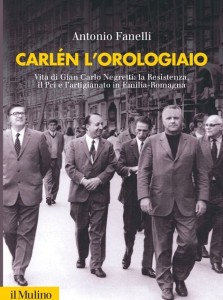 Gnint c’incaglia, niente ci ferma
Gnint c’incaglia, niente ci ferma
Negli ultimi decenni abbiamo letto molti diari di guerra, quelli di giovani contadini che si sono trovati a combattere nelle trincee della prima e della seconda guerra mondiale; abbiamo poi letto storie di vita contadina che parlavano del passaggio da un mondo povero ad uno più ricco ma forse più disumano; abbiamo letto, infine, molti memoriali e racconti relativi agli anni del fascismo, della Seconda guerra mondiale, dei lager nazisti e della Resistenza antifascista …. Possiamo dire che, dalla scoperta negli anni ‘70/80 del secolo scorso della “storia orale”, la storia e l’antropologia si sono serviti a lungo di queste pubblicazioni, per rileggere e analizzare, da altri punti di vista, i periodi cruciali delle vicende degli Italiani.
Erano libri in cui si leggevano storie di paure, di fame, di terrore, di fatiche straordinarie, di battaglie: tutte tessere che andavano a formare il mosaico composito di un Paese in continua trasformazione sociale e culturale, insanguinato da due tremende guerre mondiali, lacerato da una feroce guerra civile e poi da violenti contrasti di classe. E soprattutto erano libri in cui la visione delle cose era alquanto manichea: in genere i cattivi erano gli altri, mentre i protagonisti delle vicende narrate erano sempre i buoni.
E poi, improvvisamente, arriva Antonio Fanelli, con il suo volume Carlén l’orologiaio. Vita di Gian Carlo Negretti: la Resistenza, il PCI e l’artigianato in Emilia-Romagna (Il Mulino, Bologna 2019), nel quale il protagonista non è il resistente o il dirigente proletario moralmente integro, tutto dedito alla libertà e ai destini del proletariato, ma una persona dalla forte personalità e dalle mille sfaccettature, nella quale coesistono male e bene, pietà e violenza, e che riesce con il suo racconto a scardinare tutte le nostre certezze storiche e politiche.
A parte la straordinarietà del personaggio, la vicenda che ci narra Fanelli è abbastanza simile a quelle ricordate poco più sopra, ma essa è raccontata secondo un’ottica del tutto diversa da quella presente negli altri libri: è come se la vicenda fosse narrata dal protagonista di un romanzo picaresco, un po’ spaccone e un po’ temerario, a volte cinico altre volte umano. La stessa ottica caratterizza anche il racconto delle vicende postbelliche, quando il Carlèn diviene un dirigente politico, un organizzatore di cultura e soprattutto uno dei grandi promotori di un settore molto importante dell’economia emiliano-romagnola come quello dell’artigianato.
Ciò che lega, in modo indissolubile, la prima parte del racconto a quella finale è un principio da cui il protagonista non ha mai pensato di deflettere e che si compendia nell’espressione dialettale gnint c’incaglia, “niente ci blocca”:
«Cosa vuol dire gnint c’incaglia?; vuol dire che se tu hai da risolvere un problema, che devi trovare questo legno e non sai come fare allora devi sapere dove trovare il legno. Devi sapere se dev’essere segato e dove trovi la sega… Quando io dissi facciamo il gruppo Gnint c’incaglia, mi dissero: “e cosa deve essere?” Facciamo un gruppo che risolve i problemi irrisolvibili. Un gruppo di furbi, non di coglioni».
 Per avvicinare Gian Carlo Negretti, detto “Carlèn l’orologiaio”, Fanelli ha avuto bisogno di ricorrere a degli intermediari, a persone che conoscevano da vicino l’uomo che era non solo schivo ma anche molto diffidente. In ciò lo ha aiutato Rudi Assuntino, uomo di spettacolo, che aveva conosciuto Negretti mentre effettuava una ricerca sul “Teatro popolare di Massa”, di cui Negretti si era occupato al tempo in cui era responsabile, per il Comune di Bologna, del “Centro della cultura popolare”. Assuntino quindi, diventato amico di Negretti, ha potuto non solo agevolare l’incontro tra Carlèn e Fanelli, ma è stato presente in molti momenti dell’intervista. Ed è proprio Rudi Assuntino che si assume l’incarico di tracciare, all’inizio del volume, un succinto ritratto del personaggio Carlèn, quasi a predisporre l’animo del lettore ad affrontare, nelle pagine successive, un protagonista di eventi al di fuori, spesso, della normalità.
Per avvicinare Gian Carlo Negretti, detto “Carlèn l’orologiaio”, Fanelli ha avuto bisogno di ricorrere a degli intermediari, a persone che conoscevano da vicino l’uomo che era non solo schivo ma anche molto diffidente. In ciò lo ha aiutato Rudi Assuntino, uomo di spettacolo, che aveva conosciuto Negretti mentre effettuava una ricerca sul “Teatro popolare di Massa”, di cui Negretti si era occupato al tempo in cui era responsabile, per il Comune di Bologna, del “Centro della cultura popolare”. Assuntino quindi, diventato amico di Negretti, ha potuto non solo agevolare l’incontro tra Carlèn e Fanelli, ma è stato presente in molti momenti dell’intervista. Ed è proprio Rudi Assuntino che si assume l’incarico di tracciare, all’inizio del volume, un succinto ritratto del personaggio Carlèn, quasi a predisporre l’animo del lettore ad affrontare, nelle pagine successive, un protagonista di eventi al di fuori, spesso, della normalità.
A sua volta poi è il Fanelli che, in un’ampia introduzione messa insieme ricucendo e raccordando molti frammenti dell’intervista, ricostruisce la personalità di Carlèn con i suoi tic linguistici, le sue espressioni iperboliche, e con la sua straordinaria capacità di raccontare ed illustrare gli eventi del passato con grande sincerità e lucidità, nonché con notevole ironia e una inarrestabile affabulazione.
Il primo capitolo è dedicato all’adolescenza e alla giovinezza di Carlèn, vissute a Calderara, un paese adagiato lungo le rive del Reno, in un ambiente proletario, tra contadini, artigiani e tante famiglie povere, i cui membri, in mancanza di lavoro, erano spesso costretti per sopravvivere a rubare. Tra loro c’erano cattolici, c’erano fascisti, ma soprattutto c’erano socialisti e anarchici. Negretti non è tenero con i ladruncoli, né con gli anarchici: con i primi adotterà, durante la Resistenza, una dura e rigorosa pedagogia che li porterà a diventare buoni cittadini, con gli altri sarà sempre fortemente critico e sarà contento solo quando li vedrà andare via, emigrati in Francia. La stessa avversione mostrerà nei confronti di tutti gli estremisti, sia quelli incontrati durante la guerra partigiana, sia, negli anni successivi, quelli che criticavano da sinistra la politica del PCI. Il suo giudizio su costoro è tranchant; ritiene che essi siano “bubboni” da estirpare immediatamente e con grande decisione:
[Durante la guerra di Resistenza] «Questa volta ti abbiamo disarmato, ma un’altra volta tu dopo non ti disarmiamo più, attenzione! Perché facevamo presto a prendere delle decisioni, quando le cose prendono queste svolte bisogna essere decisi. Sono mica cosa da discutere nei partiti queste cose qui, sono cose che si decidono in pochi. Quando c’è un bubbone bisogna toglierlo via per il bene di tutti».
E riferendosi alle vicende più vicine: «Bisogna sempre tenerli a bada gli estremisti».
In possesso solo della licenza di quinta elementare, è costretto fin da bambino ad imparare un lavoro: sceglie quello dell’orologiaio, un mestiere di artigiano che segnerà la sua mentalità e i suoi comportamenti fino alla vecchiaia. Di quest’arte, da lui sempre esaltata, sarà oltremodo fiero fino a porla sullo stesso livello delle conoscenze tecnico-scientifiche, comparando, con qualche presunzione, l’orologiaio con gli scienziati che mandano i missili nello spazio, per il semplice fatto che in missilistica ci sono meccanismi di grande precisione come quelli degli orologi. A rafforzare questa convinzione c’era anche l’esperienza che aveva fatto da giovane all’aeroporto militare di Bologna, che ogni tanto, abitando con la famiglia in quei pressi, andava a visitare per commettervi qualche furto, e dove comunque aveva imparato a conoscere gli strumenti di precisione come gli altimetri, di cui divenne esperto.
Pur provenendo da una famiglia di orientamento cattolico, non schierata politicamente (a parte uno zio, fratello del padre, finito col fare la spia dell’OVRA e diventato poi, nel dopoguerra, funzionario della questura di Bologna), Negretti nel 1943 si iscrive al Partito comunista, allora clandestino. Quando si arrivò al momento di prendere le armi contro tedeschi e fascisti, era pronto a costituire un gruppo: la conoscenza profonda del territorio dove viveva e della gente che vi abitava gli permise di muoversi durante la guerra partigiana con grande facilità. Tuttavia era necessario avere la fiducia dei contadini, in maggioranza mezzadri, perché senza il supporto del mondo contadino, specie in quel territorio della pianura padana, la lotta contro i nazifascisti non avrebbe avuto successo. Era necessario, quindi superare la diffidenza dei contadini; Negretti seppe trovare i modi e i mezzi per ottenerne la fiducia, imponendo ai proprietari dei poderi, a volte con le armi in pugno, di sottoscrivere i contratti colonici che non si facevano più da decenni; così, conoscendo e toccando con mano che lui stava dalla loro parte, contadini e mezzadri gli dettero piena fiducia. Nei momenti più difficili Negretti riusciva sempre a trovare la soluzione adatta a superarli.
Nei capitoli successivi, egli racconta la sua attività di dirigente politico: commissario per conto del PCI di una zona di montagna difficile da gestire; poi a capo del “Centro di cultura popolare” istituito dal Comune di Bologna e del “Teatro di Massa”, un’esperienza durata poco anche perché la censura politica di quegli anni impedì a Negretti di realizzare un ampio progetto alla cui direzione era stato chiamato Luchino Visconti.
Ovviamente Carlèn fu costretto a trasferire nell’organizzare e presiedere l’impresa culturale e teatrale a lui affidata, il motto gnint c’incaglia (“niente ci ferma”) che lo aveva guidato nella conduzione della guerra partigiana. Il Comune, infatti, gli aveva dato solo il compito di creare il centro culturale e di promuovere le iniziative del Teatro di Massa, ma non gli aveva messo a disposizione nemmeno un centesimo, tanto che per stampare un volantino era costretto a ricorrere a cartolerie e stamperie che con trucchi, furbizie e sotterfugi vari riusciva a non pagare. Rudi Assuntino e Luciano Leonesi, inventore del Teatro di massa, raccontano molti aneddoti, riportati nel volume, in cui Negretti appare come un deus ex machina che dal nulla riusciva a mettere insieme iniziative e attività anche di difficile realizzazione.
 Il Partito lo riteneva essenziale, ma non gli dava incarichi di grande responsabilità politica a causa di quel suo zio funzionario della questura; non poteva, tuttavia, fare a meno di lui perché, per la sua esperienza di combattente, diventava indispensabile quando si trattava di organizzare un gruppo paramilitare che tenesse a disciplina sia i più irrequieti degli ex partigiani, sia coloro che non avevano smesso di commettere furti nel territorio di Calderara; oppure ricorrevano a lui quando si trattava di affidargli compiti di ordine pubblico in caso di eventuali scontri di piazza come quelli che allora avvenivano in tempo di scioperi e di duri conflitti sindacali. Addirittura, lo incaricavano di fare la guardia del corpo a Togliatti (che stimava ed ammirava moltissimo) quando questi si recava a Bologna. E poi i dirigenti locali gli riconoscevano quella sua insuperabile capacità di saper organizzare qualsiasi attività che faceva dimenticare loro, quando ne avevano bisogno, le sue manchevolezze.
Il Partito lo riteneva essenziale, ma non gli dava incarichi di grande responsabilità politica a causa di quel suo zio funzionario della questura; non poteva, tuttavia, fare a meno di lui perché, per la sua esperienza di combattente, diventava indispensabile quando si trattava di organizzare un gruppo paramilitare che tenesse a disciplina sia i più irrequieti degli ex partigiani, sia coloro che non avevano smesso di commettere furti nel territorio di Calderara; oppure ricorrevano a lui quando si trattava di affidargli compiti di ordine pubblico in caso di eventuali scontri di piazza come quelli che allora avvenivano in tempo di scioperi e di duri conflitti sindacali. Addirittura, lo incaricavano di fare la guardia del corpo a Togliatti (che stimava ed ammirava moltissimo) quando questi si recava a Bologna. E poi i dirigenti locali gli riconoscevano quella sua insuperabile capacità di saper organizzare qualsiasi attività che faceva dimenticare loro, quando ne avevano bisogno, le sue manchevolezze.
Anche se il Partito lo riteneva inaffidabile, e Carlèn lo sapeva, egli continuava a lavorare per esso, riaffermando, però, sempre una sua forte autonomia ed esprimendo apertamente il suo dissenso quando la linea del Partito gli sembrava troppo astratta e lontana dai problemi reali:
«[Nel partito] non avevo paura di niente perché io avevo il mio lavoro, se c’era da stare a casa io sapevo già cosa dovevo fare, io non ero come quelli che andavano in federazione per avere un lavoro. No, non mi interessava niente».
Era soprattutto inviso ai comunisti di Calderara, dove, nonostante i suoi meriti, non fu mai consigliere comunale, né gli fu mai richiesto di fare un comizio per il 25 Aprile, perché non gli perdonavano l’aver fatto parte del gruppo di controllo contro i ladri, nei confronti dei quali dice, usando un’espressione molto forte, di aver svolto operazioni di “pulizia etnica”.
Nel 1959 ci fu un’altra svolta nella vita pubblica di Gian Carlo Negretti: il PCI, tramite il responsabile dell’Artigianato, lo volle come collaboratore per organizzare il nascente movimento degli artigiani, formato in buona parte da operai licenziati dalle fabbriche per motivi politici e sindacali. Occorreva partire da zero, inventarsi una politica del settore, convincere i Comuni a predisporre le aree artigianali con piani regolatori appropriati, lottare contro mentalità burocratiche e prive di creatività, trovare le risorse finanziarie necessarie. All’inaugurazione di uno dei tanti insediamenti artigianali, Gagliani, il primo presidente dell’artigianato ebbe a dire:
«Quando lui [Negretti] partì con questa iniziativa gli dissi in segreteria che era matto e tutti mi diedero ragione … Ma lo era davvero, perché lui ha fatto delle cose da matto che io non le avrei mai fatte e adesso dobbiamo ringraziarlo perché qui adesso ci sono quattordici fabbriche … guardate, Negretti ha fatto questa roba qui».
 In effetti, Carlèn se non era matto certamente aveva il coraggio o l’incoscienza di rischiare molto anche a livello personale. Così, come aveva messo a repentaglio la propria vita durante la guerra partigiana e negli anni immediatamente successivi, si tuffa nell’opera di costruzione dell’artigianato emiliano-romagnolo con tutto il suo entusiasmo, frutto non di emotività ma di grande lucidità e sangue freddo. Come quando per agevolare le imprese artigiane e per sollecitare i Comuni a provvedere alle aree necessarie, comprava “virtualmente” i terreni; poi, con un procedimento alla rovescia, andava dagli assessori per predisporre il piano regolatore ed infine si recava presso le banche per farsi finanziarie e finalmente pagava i terreni da lui “acquistati” solo in parola. Sarebbe bastato incontrare un piccolo ostacolo in questo aleatorio percorso per pagare in solido di persona.
In effetti, Carlèn se non era matto certamente aveva il coraggio o l’incoscienza di rischiare molto anche a livello personale. Così, come aveva messo a repentaglio la propria vita durante la guerra partigiana e negli anni immediatamente successivi, si tuffa nell’opera di costruzione dell’artigianato emiliano-romagnolo con tutto il suo entusiasmo, frutto non di emotività ma di grande lucidità e sangue freddo. Come quando per agevolare le imprese artigiane e per sollecitare i Comuni a provvedere alle aree necessarie, comprava “virtualmente” i terreni; poi, con un procedimento alla rovescia, andava dagli assessori per predisporre il piano regolatore ed infine si recava presso le banche per farsi finanziarie e finalmente pagava i terreni da lui “acquistati” solo in parola. Sarebbe bastato incontrare un piccolo ostacolo in questo aleatorio percorso per pagare in solido di persona.
Negretti, tuttavia, non è stato solo organizzatore e fondatore della Confederazione dell’artigianato, ma ha anche contribuito alla formazione della legge nazionale che regola il lavoro artigianale ed ha condotto una sua personale lotta contro la corruzione:
«Io quando vado in un’azienda la prima cosa che devo fare è spiegare all’azienda come si deve comportare, devo aiutarla, perché sennò che funzione ho io? Solo di andare a sanzionare? Allora non ha enso! … Sono organi che … nessuno adopera perché sono abituati con le amicizie, quella è corruzione, capito? È da lì, è da noi che comincia la corruzione, a questo livello».
Non lavorava per sé, per arricchirsi (ha sempre abitato nella stessa casa popolare assegnatagli a suo tempo), e si è accontentato di poco: si è ritirato dal lavoro con una pensione di impiegato di seconda categoria: «Se facessi ora una vertenza alla CNA, gli porto via due miliardi … Mi vergognerei solo ad entrare …». Non ha lavorato nemmeno per il partito; quando organizzò, in seno alla Confederazione nazionale, gli artigiani romagnoli, si trovò davanti gruppi di persone schierati con i repubblicani di Pacciardi, che erano visceralmente anticomunisti; ma anche con loro cercò contatti e rapporti che alla fine dettero esiti positivi.
«Ma non li ho mica voluti portare via gli artigiani repubblicani per farli diventare comunisti! Non faccio mica queste operazioni io, attenzione, io faccio delle operazioni per una politica dell’artigianato, perché sennò sono tutte baggianate che non servono a niente … Io facevo la politica dell’artigianato, per un aiuto alle aziende, un lavoro specifico, finalizzato a loro».
La sua più grande soddisfazione, quindi, è stata quella di ricevere, nel 2002, anno del pensionamento, una targa di ringraziamento da parte della Regione per l’attività e l’impegno «profuso a favore dello sviluppo dell’artigianato in Emilia-Romagna».
A conclusione del volume Fanelli aggiunge un capitolo molto importante se non addirittura necessario, intitolato Ascoltare una voce e raccontare una cultura. Carlèn l’orologiaio e l’Emilia «rossa». Nel primo paragrafo affronta problemi di metodologia sull’intervista e sull’uso che se ne può fare per costruire la biografia dell’intervistato. Poi rifà il ritratto del Negretti ma stavolta con l’aiuto dei documenti che riportano i giudizi dei dirigenti della federazione bolognese del PCI che hanno, in certi momenti importanti, esaminato e valutato il suo lavoro e la sua personalità. Nell’ultimo paragrafo Fanelli cerca di definire l’azione politica di Negretti (stalinista? socialdemocratico? riformista? pragmatico? Forse tutte queste cose che convivono inestricabilmente insieme) alla luce della teoria e della politica di Togliatti nei confronti del ceto medio.
Rispetto a tutto il volume è molto evidente l’importanza che assumono l’introduzione e il capitolo finale in cui Fanelli ha svolto le sue considerazioni sulla personalità del Negretti, sul suo pragmatismo portato alle estreme conseguenze, mettendo in evidenza le sue capacità di grande organizzatore, la sua notevole duttilità che gli consente di passare da capopartigiano ad uomo di partito, dalle lotte contadine a responsabile della cultura (cinema, teatro) e poi a fondatore, insieme con altri, dell’economia emiliana basata su centinaia di imprese artigiane; nonché l’abilità di individuare il cuore dei problemi, sia quando si trattava di settori in cui era fortemente competente, come la meccanica, sia a livello di produzione, sia a livello di mercato, campi in cui mostrava un’attitudine particolare a capire qual era il settore chiave.
Fanelli ha anche cercato di spiegare l’alterità del personaggio, la sua diffidenza nei confronti delle persone con cui aveva a che fare («io voglio sapere con chi parlo, che cosa ha fatto»), non tutti si potevano avvicinare a lui, specie se gli chiedevano notizie sulla sua vita, sulle decisioni e i suoi comportamenti assunti in momenti drammatici come quelli della guerra partigiana. La diffidenza era certo figlia della cultura contadina, specie dei mezzadri che dovevano guardarsi dalle insidie dei padroni e dei fattori, nasceva anche dall’esperienza della lotta quotidiana per la sopravvivenza a Calderara, ma è pure frutto dell’esperienza bellica, di una guerra partigiana che in Emilia raggiunse momenti di grande ferocia. In quei momenti, per fidarsi, prima di dare il via ad azioni in cui era in pericolo la vita di tante persone, era necessario conoscere profondamente chi si aveva a fianco.
La stessa diffidenza ha nei confronti di Fanelli; egli non ha mai raccontato la sua vita, non ha voluto mai scrivere memorie di guerra, giudica poco attendibili i vari diari pubblicati nel corso della seconda metà del Novecento. È consapevole che a rendere pubbliche le cose che sa, oltre a fornire argomenti di pettegolezzo e basse speculazioni a giornali e partiti, finirebbe per riaprire ferite antiche, per riaccendere sentimenti di odio e di vendetta; per questo sta zitto. E se deve confidare qualcosa, ma non tutto, a uno studioso, questi deve essere una persona seria, di cui ci si può fidare. Quella di Carlèn è una storia da raccontare solo all’interno di una comunità in cui è fortemente condivisa una scelta politica di sinistra e antifascista, altrimenti non racconta nulla; l’intervistatore deve essere profondamente leale e deve calarsi interamente nei panni del protagonista, deve capire, se non condividere, il suo modo di pensare e di valutare la realtà storica.
Per questo, prima che inizi l’intervista, Fanelli è interrogato ed esaminato, deve fornire altri elementi, oltre alla giustificazione che si tratta di una ricerca storica, che per Negretti non è sufficiente. Egli vuole essere sicuro, non solo sulla comunanza di idee politiche, ma perché non vuole essere frainteso nemmeno quando la conversazione tocca argomenti poco importanti. Sa che la guerra partigiana fu un fatto eccezionale, terribile: «in guerra si deve fare quello che si deve fare ma non esagerare»; e soprattutto non se ne può parlare come di avvenimenti semplici su cui tutti possono concordare e non si possono esplicitare tutte le vicende, alcune delle quali potrebbero dare altre occasioni a chi oscenamente ama disseppellire certe tragiche vicende con il solo scopo di denigrare una parte degli ex belligeranti.
 A questo punto non resta che tentare di spiegare il significato del motto, gnint c’incaglia, che ha guidato per un’intera vita le azioni del Negretti. Rudi Assuntino affronta il tema nella sua Premessa e lo spiega con una frase che sembra sinteticamente citare la volgarizzazione del pensiero del Machiavelli:
A questo punto non resta che tentare di spiegare il significato del motto, gnint c’incaglia, che ha guidato per un’intera vita le azioni del Negretti. Rudi Assuntino affronta il tema nella sua Premessa e lo spiega con una frase che sembra sinteticamente citare la volgarizzazione del pensiero del Machiavelli:
«gnint c’incaglia come regola di vita significa fare ad ogni costo, senza confini etici e giuridici, perché la finalità va raggiunta e l’etica è racchiusa nella ragione stessa che ispira le lotte collettive e orienta l’operato degli uomini d’azione come Carlèn»
In effetti il motto negrelliano sembrerebbe l’applicazione di quella formula falsamente e surrettiziamente attribuita a Machiavelli: il fine giustifica i mezzi. Ma mi sembra che le cose non stiano esattamente così; e non credo nemmeno che Carlèn conoscesse il Segretario fiorentino. È vero, comunque, che nella sua visione del mondo e nelle sue azioni si possa riconoscere quell’intelligenza capace di capire che per raggiungere ogni obiettivo è necessario saper scegliere mezzi specifici, quelli e solo quelli che garantiscano l’esito che si era prefisso. Che non è spiegabile con l’espressione “il fine giustifica i mezzi”. Il gnint c’incaglia è quasi un imperativo categorico, necessario durante la guerra partigiana, ma poi Negretti lo trasferisce anche nella vita civile e politica di tutti i giorni; esso presuppone che per raggiungere lo scopo prefisso a volte è necessario superare la morale corrente, capovolgere il senso comune, rischiare la sconfitta.
C’è in Negretti una determinazione ferrea, necessaria in tempi difficili, come il periodo resistenziale, quando deve affrontare vicende tragiche («Se c’era uno che rubava non si doveva fucilare?»); sa che non è bello e giusto presentarsi a casa dei proprietari dei poderi con le armi spianate, ma se vuole la complicità e il supporto del mondo contadino, i contratti colonici scritti sono indispensabili e lui «fa quel che doveva fare». E tutto gli riusciva perché oltre all’intelligenza aveva il coraggio, forse anche il piacere di scommettere sulla riuscita delle sue azioni.
Con un siffatto abito mentale Carlén ha sempre agito, ed ha continuato ad indossarlo anche dopo la fine della guerra, quando era necessario costruire un mondo nuovo, con un’altra etica, con altri rapporti sociali e umani. Anche qui torna in mente Machiavelli quando teorizza un “nuovo Stato”, per la cui nascita sono necessarie la forza del leone e l’astuzia della volpe. Carlèn, nel suo piccolo, è convinto che la società che nascerà dopo la sconfitta del fascismo avrà una sua moralità, diversa da quella in cui si era costretti ad agire violandone le leggi: una nuova società in cui nessuno sarà costretto a rubare per sopravvivere, a commettere violenza per castigare malvagi, perché non ci saranno più i malvagi. La coscienza di dar vita ad un nuovo Stato e ad una nuova società era presente nella mente di Negretti, perché profuse molte energie nell’impegno pedagogico di trasformare i molti ladruncoli che facevano parte della sua banda partigiana in tanti futuri cittadini provvisti di una nuova moralità e di una nuova consapevolezza sociale.
Egli ha la certezza, a volte la sicumera, di aver capito tutto del lavoro e della vita grazie alla sua esperienza pratica, e per questo ritiene di non aver bisogno di leggere i classici del marxismo; dopo aver scorso qualche pagina del Capitale questa fu la sua reazione: «… sono cretinate che vanno bene per uno che sia un grande filosofo … Sono cose inutili, proprio, fuori dal mondo». Ma poi, per dire che ha capito il pensiero di Marx, con un po’ di inconsapevole presunzione, interviene su problemi di cui per lungo tempo si sono occupati molti studiosi senza riuscire a risolverli, mentre lui, semplice autodidatta, con la quinta elementare, ritiene di poter sciogliere uno dei nodi più intricati della teoria marxista, e cioè il rapporto tra struttura e sovrastruttura. Ecco come lo spiega all’intervistatore Antonio Fanelli:
«Perché tu lo sai che i grandi studiosi del marxismo hanno lottato decine e decine di anni per stabilire se era – aspetta che te lo voglio dire con parole precise – se era l’interesse che creava l’idea o se invece era l’idea che creava l’interesse. Te sei arrivato a questo conquibus? Io ci sono arrivato. È l’interesse che crea l’idea».
Ragionamento che conduce ad una conclusione netta, che non ha bisogno di far propria l’ultima titubanza di Engels che, dopo aver affermato che la sovrastruttura dipende dalla struttura, aggiungeva: in ultima analisi. Questa sua certezza di poter superare qualsiasi problema con il suo efficace pragmatismo, lo porta a diffidare degli intellettuali e a sbeffeggiarli se non hanno, oltre alla dottrina, anche il carisma:
«[Ci sono] nei partiti dei funzionari a tempo pieno che non sanno niente … della vita, è gente che è andata all’università e perciò sa parlare bene … sa scrivere bene ma poi se alla fine non stringiamo qualcosa di concreto la cosa diventa difficile».
Negretti non aveva remore di sorta, era iscritto al Partito comunista ma ragionava sempre con la sua testa e con il suo modo di vedere le cose, soprattutto sentiva la necessità di raggiungere l’obiettivo che si era fissato, a costo di mettersi contro tutti; aveva anche il coraggio di opporsi e contestare i dirigenti, basandosi sulla conoscenza pratica delle cose; a lui non interessava l’immagine pubblica del partito, per lui importante era che il progetto di cui si discuteva fosse realizzato secondo le regole del lavoro e non secondo l’ideologia: «Io seguivo il lavoro e non l’ideologia», «anche perché nel partito erano più ignoranti che altro».
Nei confronti degli intellettuali e delle teorie politiche ha una profonda idiosincrasia che si rafforza ogni volta che vede il suo pragmatismo uscire vincitore dalle diatribe e dalle battaglie in seno agli organismi politici. Mi viene da pensare, si parva licet componere magnis, che in fondo Negretti è la realizzazione della politica che avrebbe avanzato qualche decennio successivo il dirigente cinese Deng Xiaoping: «Non importa che il gatto sia nero o bianco, basta che sappia cacciare i topi». Che poi, a guardar bene, è stata anche la caratteristica della politica del PCI in Emilia Romagna.
Dialoghi Mediterranei, n. 43, maggio 2020
______________________________________________________________
Mariano Fresta, già docente di Italiano e Latino presso i Licei, ha collaborato con Pietro Clemente, presso la Cattedra di Tradizioni popolari a Siena. Si è occupato di teatro popolare tradizionale in Toscana, di espressività popolare, di alimentazione, di allestimenti museali, di feste religiose, di storia degli studi folklorici, nonché di letteratura italiana (I Detti piacevoli del Poliziano, Giovanni Pascoli e il mondo contadino, Lo stile narrativo nel Pinocchio del Collodi). Ha pubblicato sulle riviste Lares, La Ricerca Folklorica, Antropologia Museale, Archivio di Etnografia, Archivio Antropologico Mediterraneo. Ultimamente si è occupato di identità culturale, della tutela e la salvaguardia dei paesaggi (L’invenzione di un paesaggio tipico toscano, in Lares) e dei beni immateriali. Fa parte della redazione di Lares. Ha curato diversi volumi partecipandovi anche come autore: Vecchie segate ed alberi di maggio, 1983; Il “cantar maggio” delle contrade di Siena, 2000; La Val d’Orcia di Iris, 2003. Ha scritto anche sui paesi abbandonati e su altri temi antropologici.
_______________________________________________________________