di Leo Di Simone
A nessun cercatore di Dio verrebbe mai in mente di andarlo a cercare a Korogocho. Per un tale tipo di ricerca si privilegiano gli spazi metafisici, raggiungibili con l’anima, con le facoltà spirituali, con la forza della contemplazione, con gli esercizi ascetici. Anche la ricerca cristiana, spesso dimentica dell’umanità di Gesù Cristo e dunque segnata da un monofisismo implicito scaturente dalla dogmatica ufficiale delle chiese, non si orienta facilmente verso la megalopoli di Korogocho dove Dio ha stabilito di fissare la sua dimora, fuori dalla cinta sacrale. E basta ricordare la lezione del profeta Ezechiele che vide la gloria di Dio abbandonare il tempio di Gerusalemme per andare ad abitare in terra straniera.
Il tempio, che costituiva l’orgoglio di Israele, sarebbe stato distrutto per la volontà di Yahveh, ad opera dei popoli del nord della Palestina divenuti strumenti inconsapevoli del suo castigo. Ma non tutti sarebbero periti; alcuni si sarebbero salvati, i più fedeli, un «piccolo resto», quelli «che sospirano e piangono per tutti gli abomini che si compiono» in Gerusalemme. Una volta profanato il tempio, il profeta descrive la gloria di Yahveh che si alza, si posa sul carro dei cherubini e parte attraverso la porta orientale, quella da cui erano usciti gli esiliati, seguendoli sui polverosi sentieri verso l’esilio. La sua presenza lì era terminata (cf. Ez 9-10), sarebbe andato in esilio nel mondo.
Con la stessa enfasi profetica di Ezechiele, profeta avversato perché annuncia la fine catastrofica della storia culturale del suo popolo, portando simbolicamente su di sé i peccati della nazione, Alex Zanotelli, missionario non meno scomodo del profeta, racconta la sua esperienza allucinante e salvifica a Korogocho, una delle tante baraccopoli di Nairobi, la capitale del Kenya, città di quattro milioni di abitanti dove il 60% della popolazione vive nell’inferno delle baraccopoli e del degrado urbano. Il nome Korogocho in kikuyu, la lingua del luogo, significa “confusione”. Il suo libro La solidarietà di Dio [1] non è meno vibrante della profezia di Ezechiele.
 A Korogocho, tra gli esiliati della terra, i poveri di Nairobi, i reietti del postmoderno, padre Alex Zanotelli ha trascorso dodici anni della sua attività di missionario comboniano, disseminando nel magma di quell’infernale baraccopoli trentasei piccole comunità cristiane che celebrando il «Dio della vita» potessero proclamare il messaggio che «Dio è Dio che cammina con i poveri, con gli ultimi e che vuole la libertà, che vuole dignità, che vuole che questa gente si rimetta in piedi» [2].
A Korogocho, tra gli esiliati della terra, i poveri di Nairobi, i reietti del postmoderno, padre Alex Zanotelli ha trascorso dodici anni della sua attività di missionario comboniano, disseminando nel magma di quell’infernale baraccopoli trentasei piccole comunità cristiane che celebrando il «Dio della vita» potessero proclamare il messaggio che «Dio è Dio che cammina con i poveri, con gli ultimi e che vuole la libertà, che vuole dignità, che vuole che questa gente si rimetta in piedi» [2].
L’esperienza di padre Alex Zanotelli è illuminante da tanti punti di vista, a partire da quel trauma personale senza il quale non può attuarsi nessuna autentica conversione, nessuna seria riflessione sulla vita umana e sulla natura di Dio: «È andato in pezzi anche il mio concetto di Dio» e «questa esperienza mi ha tirato fuori dal mio mondo borghese, intellettuale, e mi ha fatto realmente sporcare le mani dentro la storia» [3]. È emersa cioè l’esperienza esistenziale della fede cristiana; non adesione ideale e astratta a verità o dogmi di fede ma assimilazione all’esperienza del Dio “abbassatosi”, incarnato in Gesù, e di Gesù “disceso agli inferi”, nello stadio più abissale della sua kenosi.
Scendere a Korogocho dalle altezze indorate del mondo dello spirito borghese globalizzato ha significato per Alex Zanotelli essere solidale con la sofferenza degli “infimi”, con la loro disperazione che cerca motivi di sopravvivenza frugando nell’immensa discarica di rifiuti posta ai confini della baraccopoli di Korogocho, dove confluiscono gli scarti della città ricca, della Nairobi residenziale, Muthaiga con le sue ville da favola e i servizi ultramoderni, un mondo dai valori capovolti che mostra in maniera ancora più cruda e inumana la situazione dei baraccati.
Ma Dio non abita nelle ville sontuose di Muthaiga; quella è ormai una città senza Dio e per quella città Dio è morto. La sua gloria si è recata ai margini della città, nell’inferno di Korogocho, dove nessun benpensante può sospettate sia scesa a infangarsi. Ed è da qui che bisogna partire per fare teologia, la teologia come riflessione utile all’umanità contemporanea in gran parte martoriata e umiliata: dal basso, dalla regione degli inferi dove Cristo è disceso per portare la luce di Dio. Da questo sabato santo della storia dove Dio tace, dopo che il tempio del corpo del suo Figlio è stato distrutto (cfr. Gv 2, 13-22) dall’iniquità umana e giace nel sepolcro; e la croce nuda si fa emblema della crudeltà degli uomini, mentre si attende che qualcosa accada per non vanificare la fede, la speranza, l’amore.
Nel 1969, in una meditazione tenuta per la Pasqua il teologo Joseph Ratzinger ebbe a scrivere: «Sabato santo: giorno della sepoltura di Dio; non è questo in maniera impressionante il nostro giorno? Non comincia il nostro secolo ad essere un grande Sabato santo, giorno dell’assenza di Dio…?». Svilupperà poi tutta la sua meditazione adagiandola su uno sfondo culturale che si avvantaggia dell’urlo lacerante di Nietzsche elevato tra terrore ed angoscia: «Dio è morto! Dio rimane morto! E noi lo abbiamo ucciso!». Concluderà con riferimenti teologicamente penetranti sulla luminosità della croce vuota da contemplare il Sabato santo, ma ribadendo «l’oscurità divina di questo giorno che […] parla alla nostra coscienza».
Sembra così il Sabato santo un giorno di muta mestizia che per secoli è stato vissuto con accenti luttuosi, giorno emblematico di un’epoca come la nostra che cerca di sedare con l’oppio dell’attivismo e la menzogna del welfare il trauma dell’assenza, ritrovandosi però incapace di trovare la via d’uscita dalla sua «angoscia mortale» per dirla con Søren Kierkegaard. Eppure, paradossalmente, conclude Ratzinger, «La morte di Dio in Gesù Cristo è nello stesso tempo espressione della sua radicale solidarietà con noi. Il mistero più oscuro della fede è nello stesso tempo il segno più chiaro di una speranza che non ha confini» [4].
Ora, possiamo noi cristiani condividere questa affermazione di assenza? Percepiamo davvero questo clima di silenzio di Dio? Possiamo concepire un giorno terreno, un solo giorno, o anche una sola ora, o un solo attimo, in cui Dio non opera salvezza? Leggendo il reale con ottica umana l’assenza di Dio può apparire persino plausibile! Ma basta scavare un poco più a fondo nella rivelazione per apprendere che in realtà ci fu un grande trambusto quel giorno, perché Dio infranse la regola di riposo che s’era data, e la infranse per mezzo del suo Figlio datoci come «segno di contraddizione» che si accentua anche nel silenzio assordante di quel sabato.
Nel racconto della passione secondo Giovanni apprendiamo che quell’anno il sabato sarebbe stato un sabato speciale, perché coincideva con la Pasqua ebraica. Gesù muore nel giorno della Parasceve, vigilia di preparazione della festa pasquale e nell’ora in cui nel tempio si immolavano gli agnelli. Tutto in Giovanni ha un significato preciso e una cronologia puntuale. Ed è proprio a motivo della Pasqua incombente che Gesù viene sepolto in fretta, nel giardino vicino al luogo della crocifissione. Poi cala la notte, illuminata dal gelido bagliore del plenilunio di Nisan, si entra nel riposo sabatico riempito dal rituale pasquale. Il giardino ha bagliori spettrali, la pietra pesante nasconde e protegge il cadavere. E qui comincia la Pasqua di Gesù e l’azione silenziosa di Dio. Silenziosa ma salvificamente attiva perché “opera” nonostante la morte ed anzi nella morte, per reciderne la radice maligna. Dio non è morto e solo chi è distratto può credere il contrario.
In quel principio di Shabat cominciò a diffondersi la tenue e dolce melodia della vita, che si svilupperà sino al “fortissimo” domenicale; la udiamo emergere dal silenzio nel racconto dell’apostolo Pietro, il quale ci dice che Gesù non rimase inerte come esige la morte, ma iniziò l’esodo pasquale proprio in quel Sabato che fuori dal sepolcro, nel gelido giardino, sembrava immoto come tutti gli altri. Cosa fece? «Discese agli inferi» e «andò a portare l’annuncio anche alle anime prigioniere che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua» (1Pt 3, 19-20). Come vi andò? «nello spirito» ci dice l’apostolo, perché era stato «messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito» (3, 18).
Il contesto del testo indica la ragione per cui Cristo è considerato nello stato di morte, anteriore alla Risurrezione: è perché va a visitare i morti come spirito separato dalla carne; va a portare la salvezza ad altre anime separate dal loro corpo; in definitiva compie la sua missione in virtù di una comunanza di destino con loro, è solidale con loro. Ha assunto il loro stato per salvarle da questo stato. La teologia cristiana ci dice che non ha salvato nulla che non abbia assunto, e tutto ciò che ha assunto lo ha salvato. La redenzione è la solidarietà di Dio, l’amore che si spinge fino all’inferno per autenticarsi operando. E qui risuona il motivo della kenosis, dell’abbassarsi di Dio, del suo mutare, unitamente a quello della sua trascendenza. Il principio di non contraddizione qui perde il suo senso.
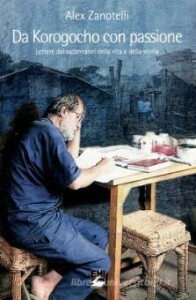 «Ho scelto di andare a Korogocho – dice Alex Zanotelli – perché è la peggiore delle baraccopoli di Nairobi. Scendere a Korogocho significa effettivamente scendere con i poveri, condividere con loro la sofferenza, fare la scelta effettiva degli ultimi». Le baraccopoli di Nairobi sono tutte nel fondo valle, vi si scende, e si ha la sensazione «di fare la discesa agli inferi di Gesù. Gli inferi non solo della sua morte, morte di malfattore, morte di schiavo, morte di sobillatore politico, ma gli inferi della Galilea. Lui li ha scelti come luogo privilegiato da cui dire alla sua gente, soprattutto agli emarginati, agli schiavi, agli esclusi che Dio è Papà» [5]. Gesù, in questo suo viaggio tocca il punto più estremo della precipitazione kenotica; è disceso oltre la porta della solitudine umana, nel fondo abissale dell’angoscia mortale dove davvero Dio è morto. Ma non per rimanervi! Pietro ricorda che anche qui si è realizzata la profezia del salmista: «non è stato abbandonato negli inferi» (Sl 16,10); scende negli inferi per liberare quell’umanità schiava della morte e condurla oltre il mare oscuro del nulla, in un nuovo esodo pasquale verso la terra promessa da Dio e che è lui stesso, lui libertà e liberatore. E ancora una volta infrange il Sabato, ne sconvolge l’immobilità con un movimento epocale, con un lavoro mai visto né ritenuto possibile. Nel Sabato “opera” e ne distrugge la consistenza idolica recuperandone il senso originario di luogo dell’incontro con Dio, di tempo in cui Dio si mostra. Lui è Signore del Sabato e la salvezza dell’uomo viene prima del Sabato, di tutte le leggi religiose, di tutti i culti cerimoniali, di tutte le false tradizioni, di tutte le retoriche consolatorie e inconsistenti. Così “opera”, e compie l’opera del Padre suo, realizza il “sogno di Dio”.
«Ho scelto di andare a Korogocho – dice Alex Zanotelli – perché è la peggiore delle baraccopoli di Nairobi. Scendere a Korogocho significa effettivamente scendere con i poveri, condividere con loro la sofferenza, fare la scelta effettiva degli ultimi». Le baraccopoli di Nairobi sono tutte nel fondo valle, vi si scende, e si ha la sensazione «di fare la discesa agli inferi di Gesù. Gli inferi non solo della sua morte, morte di malfattore, morte di schiavo, morte di sobillatore politico, ma gli inferi della Galilea. Lui li ha scelti come luogo privilegiato da cui dire alla sua gente, soprattutto agli emarginati, agli schiavi, agli esclusi che Dio è Papà» [5]. Gesù, in questo suo viaggio tocca il punto più estremo della precipitazione kenotica; è disceso oltre la porta della solitudine umana, nel fondo abissale dell’angoscia mortale dove davvero Dio è morto. Ma non per rimanervi! Pietro ricorda che anche qui si è realizzata la profezia del salmista: «non è stato abbandonato negli inferi» (Sl 16,10); scende negli inferi per liberare quell’umanità schiava della morte e condurla oltre il mare oscuro del nulla, in un nuovo esodo pasquale verso la terra promessa da Dio e che è lui stesso, lui libertà e liberatore. E ancora una volta infrange il Sabato, ne sconvolge l’immobilità con un movimento epocale, con un lavoro mai visto né ritenuto possibile. Nel Sabato “opera” e ne distrugge la consistenza idolica recuperandone il senso originario di luogo dell’incontro con Dio, di tempo in cui Dio si mostra. Lui è Signore del Sabato e la salvezza dell’uomo viene prima del Sabato, di tutte le leggi religiose, di tutti i culti cerimoniali, di tutte le false tradizioni, di tutte le retoriche consolatorie e inconsistenti. Così “opera”, e compie l’opera del Padre suo, realizza il “sogno di Dio”.
Il Sabato santo è una sorta di ossimoro salvifico, un viaggio nell’immobilità della morte, un passaggio nel riposo, un movimento nella quiete, un inno di gloria nel silenzio; in esso viene ripristinata la sua originaria istituzione in favore dell’uomo. Il sabato, infatti «è per l’uomo e non l’uomo per il sabato» (cfr. Mc 2, 27-28); il giorno di riposo è imposto alla terra e agli uomini allo scopo di frenare i tentativi umani di “controllare” la natura e “massimizzare” le forze di produzione: «dato che la terra è di Dio e i suoi frutti sono un dono, l’uomo deve distribuirli equamente invece di capitalizzarli e ammassarli […]. Una visione, questa, radicalmente contraria all’economia dominante […] al Sistema che uccide per fame 20-30 milioni di persone all’anno e dichiara inutili oltre un miliardo di esseri umani» [6]. Dio ricorda al suo popolo che la terra gli è stata elargita in dono, che Israele è il popolo liberato dall’Egitto e non può tornare a quel sistema di schiavitù. Quando lo facesse Dio cercherà sempre altri schiavi da liberare; gli schiavi sono, infatti, “porzione” della sua eredità.
Solo che non è facile convincere gli uomini dell’abominio della loro schiavitù, di questa condizione innaturale in cui si ritrovano considerandola naturale; della necessità di un esodo verso la luce, oltrepassando le tenebre della morte, in un desiderio di ricerca di Altro oltre la condizione del sé. E si può anche richiamare la filosoficità del tema, così come lo sviluppa Platone nel VII libro della sua Repubblica, narrando il celebre «mito della caverna». Platone descrive una umanità ignara della propria condizione di schiavitù, per cui l’unica realtà è quella delle ombre delle cose; il filosofo pensa a cosa succederebbe se fosse liberata dalle sue catene e guarita dalla sua ignoranza, se uno tra gli schiavi fosse sciolto, e poi costretto ad alzarsi, a girare il collo, a camminare verso l’alto, verso il fuori, a guardare verso la luce e poi infine vedere il sole, non l’immagine del sole nelle acque o in altri luoghi, ma il sole stesso…
«E quando poi si ricordasse – continua Platone – della dimora di un tempo, di quello che in essa credeva di sapere e dei suoi compagni di prigionia, non credi che sarebbe felice del suo cambiamento e sentirebbe pietà di quegli altri? E mettiamo che scendesse di nuovo nella caverna e riprendesse il suo vecchio posto: non si troverebbe forse come cieco, giungendovi improvvisamente dalla luce? E se dovesse di nuovo distinguere le ombre, in gara con quelli rimasti prigionieri, prima che i suoi occhi tornassero a vedere (e ci vorrebbe senz’altro molto tempo), non farebbe egli ridere? E non si direbbe di lui che li ha rovinati per essere salito sopra, e quindi non vale la pena nemmeno di tentare una simile salita? E chi cercasse di liberarli e di portarli su, se potessero prenderlo, non lo ucciderebbero?» [7].
Questo celebre brano sembra l’incipit di una ricerca fenomenologica non ancora conclusa e una sorta di praeparatio evangelica, un’appercezione prefigurativa dell’incarnazione del Logos che dal suo empireo scenderebbe giù, «sentirebbe pietà di quegli altri», si sentirebbe “solidale” con quegli altri immergendosi fino al fondo delle loro tenebre, con la consapevolezza dell’incomprensione e della possibilità di essere ucciso.
È lo stesso itinerario compiuto dal Dio descritto dalla fenomenologia di Emmanuel Levinas che lo invera nella necessità della «Passione» in favore dell’Altro. Dio che Levinas definisce «Attività più attiva», Essere supremo estremamente libero che si umilia per nascondersi nella passività più passiva lasciandosi completamente assorbire da essa. Il filosofo, ebreo lituano naturalizzato francese, nato nella tradizione giudaica, studioso del Talmud e non ignaro della relazione giudaico-cristiana pensa alla traduzione fenomenologica degli assunti di quelle religioni. Dice infatti:
«Il problema comporta d’altro canto, e come producentesi da questa passività spinta nella Passione al suo limite ultimo, l’idea di espiazione per gli altri, cioè di una sostituzione: l’identico per eccellenza, ciò che non è intercambiabile, ciò che è l’unico per eccellenza, sarebbe la sostituzione stessa. Queste idee, a prima vista teologiche, rovesciano le categorie della nostra rappresentazione. Voglio dunque chiedermi fino a che punto queste idee che valgono incondizionatamente per la fede cristiana abbiano un valore filosofico; in che misura esse possono mostrarsi nella fenomenologia» [8].
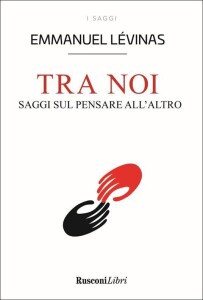 Nella fenomenologia come filosofia del concreto, possiamo dire, quale è stata quella di Levinas, filosofia della carne e del volto dell’Altro che sovverte le categorie dell’ideale per rintracciare quelle del reale, in quanto l’Altro non è una rappresentazione che accade nella mia mente ma un Volto che mi sta davanti, non un’idea ma carne e sangue. Una fenomenologia, quella di Levinas, che ribalta tutte le posizioni raggiunte dall’osservazione fenomenologica di Heidegger che approda all’Essere come volontà cieca e impersonale, una divinità anonima, fredda e senza volto che non tiene in nessuna considerazione l’essere umano, come il nazismo che lo reifica quale cogente espressione di quella volontà alla quale è inutile opporsi. Ricerca, quella di Heidegger, di una nuova ontologia dove sono escluse le relazioni, l’amore e la dimensione etica. L’uomo è «per la morte» e deve accettare di finire nel nulla. Come sostiene Gianluca De Gennaro, «Levinas definirà la filosofia heideggeriana come filosofia del potere e dell’ingiustizia, dove il soggetto, non mettendosi mai in causa, mantiene una figura all’interno dell’essere ma perde il suo volto. Con questa frase Levinas vuole indicare l’incapacità del Dasein heideggeriano (esserci, n.d.r.) di relazioni autentiche con altre persone; l’uomo di Heidegger non ha un volto, è privo di qualcosa di personale da poter presentare a un altro volto che egli incontra» [9], come la divinità anonima che si cela dietro ciò che lui chiama Essere.
Nella fenomenologia come filosofia del concreto, possiamo dire, quale è stata quella di Levinas, filosofia della carne e del volto dell’Altro che sovverte le categorie dell’ideale per rintracciare quelle del reale, in quanto l’Altro non è una rappresentazione che accade nella mia mente ma un Volto che mi sta davanti, non un’idea ma carne e sangue. Una fenomenologia, quella di Levinas, che ribalta tutte le posizioni raggiunte dall’osservazione fenomenologica di Heidegger che approda all’Essere come volontà cieca e impersonale, una divinità anonima, fredda e senza volto che non tiene in nessuna considerazione l’essere umano, come il nazismo che lo reifica quale cogente espressione di quella volontà alla quale è inutile opporsi. Ricerca, quella di Heidegger, di una nuova ontologia dove sono escluse le relazioni, l’amore e la dimensione etica. L’uomo è «per la morte» e deve accettare di finire nel nulla. Come sostiene Gianluca De Gennaro, «Levinas definirà la filosofia heideggeriana come filosofia del potere e dell’ingiustizia, dove il soggetto, non mettendosi mai in causa, mantiene una figura all’interno dell’essere ma perde il suo volto. Con questa frase Levinas vuole indicare l’incapacità del Dasein heideggeriano (esserci, n.d.r.) di relazioni autentiche con altre persone; l’uomo di Heidegger non ha un volto, è privo di qualcosa di personale da poter presentare a un altro volto che egli incontra» [9], come la divinità anonima che si cela dietro ciò che lui chiama Essere.
E non sappiamo a quale dio si riferisse Heidegger con la celebre tardiva dichiarazione «Solo un dio ci può salvare» [10]; difficile pensare si riferisse al Dio della rivelazione giudaico-cristiana che si manifesta come Dio degli ultimi, degli esclusi, di chi non conta, di chi è condannato, di chi è esule, di chi «è sbattuto fuori dal Sistema» come dice Alex Zanotelli [11]. Molto più probabilmente pensava al «Gott mit uns» del sistema nazista che fa da pendant all’altro motto americano «In God We Trust» impresso sul dollaro. Il Dio del Sistema, trascendente, separato, assoluto, grande architetto dell’universo, onnipotente quanto basta per chiedergli interventi a proprio favore che ribaltino le coordinate della storia o che faccia da prestanome per obliterare le iniquità. Ma dopo Auschwitz, Hiroshima, i gulag e le innumerevoli pulizie etniche quel Dio sembra essersi dimesso, tanto da essere ritenuto morto.
 Un Dio del Sistema non consente di guardare in faccia tutti i diseredati che vivono a Korogocho, rappresentanti di tutti gli scartati della terra sbattuti «fuori dal Sistema»; guardarli in faccia mette in pericolo il Sistema che si ritiene depositario dell’onnipotenza di Dio; mette in crisi quell’ontologia dell’onnipotenza che appare come fagocitazione degli enti da parte dell’essere, appannaggio delle filosofie della potenza, dell’«Io penso», dell’«Io posso» che portano inevitabilmente al dominio e alla sopraffazione del prossimo. Levinas osserva che già a partire da Eraclito, a partire dunque dai primordi della storia del pensiero, «l’essere si rivela al pensiero filosofico come guerra» (Πόλεμος come principio di tutte le cose) e l’ontologia, quando giunge al culmine del suo sviluppo non esita, come in Heidegger, a coniugarsi col nazismo e l’antisemitismo [12]. La critica di Levinas è sistemica e radicale: «La filosofia occidentale è stata per lo più un’ontologia: una riduzione dell’Altro al Medesimo» che sul piano pratico comporta la violenza sull’uomo e l’intolleranza verso il «diverso» [13]. Solo un Dio che si muove a compassione per loro, che si fa con loro solidale, che gioca con loro la sua vita può salvare i disperati di Korogocho; un Dio non congeniale a quella filosofia e che nonostante i tentativi di addomesticarlo è rimasto assolutamente «diverso» e rifiutato dal Sistema insieme agli ebrei che liberava:
Un Dio del Sistema non consente di guardare in faccia tutti i diseredati che vivono a Korogocho, rappresentanti di tutti gli scartati della terra sbattuti «fuori dal Sistema»; guardarli in faccia mette in pericolo il Sistema che si ritiene depositario dell’onnipotenza di Dio; mette in crisi quell’ontologia dell’onnipotenza che appare come fagocitazione degli enti da parte dell’essere, appannaggio delle filosofie della potenza, dell’«Io penso», dell’«Io posso» che portano inevitabilmente al dominio e alla sopraffazione del prossimo. Levinas osserva che già a partire da Eraclito, a partire dunque dai primordi della storia del pensiero, «l’essere si rivela al pensiero filosofico come guerra» (Πόλεμος come principio di tutte le cose) e l’ontologia, quando giunge al culmine del suo sviluppo non esita, come in Heidegger, a coniugarsi col nazismo e l’antisemitismo [12]. La critica di Levinas è sistemica e radicale: «La filosofia occidentale è stata per lo più un’ontologia: una riduzione dell’Altro al Medesimo» che sul piano pratico comporta la violenza sull’uomo e l’intolleranza verso il «diverso» [13]. Solo un Dio che si muove a compassione per loro, che si fa con loro solidale, che gioca con loro la sua vita può salvare i disperati di Korogocho; un Dio non congeniale a quella filosofia e che nonostante i tentativi di addomesticarlo è rimasto assolutamente «diverso» e rifiutato dal Sistema insieme agli ebrei che liberava:
«Ho visto, ho visto l’afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori; perché conosco i suoi affanni; e sono sceso per liberarlo dalla mano degli Egiziani, e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso» (Es 3, 7-8).
L’attività intrapresa dal trascendente è l’abbassamento: Dio si fa humilis, scende nell’humus della terra, si umilia nella condizione di chi Lui ha fatto di terra, adāmā; si fa solidale con la sua creatura oppressa, si dona in quanto il donarsi è la dinamica interna della sua vita. L’Antico Testamento non fa che proporre, col suo linguaggio, tipologie liberatorie, pasquali dell’abbassamento di Dio inverate poi nell’antitipo dell’Incarnazione e dell’azione liberatrice di Gesù, il suo Cristo, in cui si può contemplare il volto di Dio in quanto è rotta la monoliticità monadica della sua onnipotenza e la kenosi manifesta la vera natura della sua trascendenza nel volto di colui che venuto al mondo è stato collocato all’ultimo posto. Dio che nasce «da donna» rompe l’assolutezza del monoteismo: se ha una madre vuol dire che è anche figlio ed essendo figlio è in relazione col padre. Ciò significa una relazione originaria, come asserisce il Prologo di Giovanni: «In principio era il Logos e il Logos era “verso” Dio e il Logos era Dio» [14]. E il significato principale di logos (dalla radice leg) esprime originariamente non tanto un dire quanto l’attività del mettere insieme, del raccogliere, del radunare, dunque relazione [15]. Il «Logos verso» (λόγος πρὸς) esprime relazione assoluta e originaria.
Dio trascesosi nell’atto creativo, fuori di sé, non per caso, non per necessità ma per la liberissima opzione di dono che ha in Altro la sua referenza, si precipita sino al fondo dell’atto creativo, là dove la sua immagine è impressa nell’Altro che ha perso la somiglianza con Lui e il significato della sua filiazione per l’uso improprio della stessa libertà donatagli. Quando l’essere umano perde la sua umanità datagli come corona dell’atto creativo e recede allo stato ferale, nella schiavitù egotica di una confortevole caverna ha bisogno che “un Dio” lo salvi. Lo cerca, lo immagina, ma non a Korogocho, non nella diversità ontologica. Ha bisogno, allora, che qualcuno lo prenda per mano e lo porti lì, perché solo lì potrà vederlo nel volto dell’Altro. Perché lì non c’è il Dio dell’ontologia ma il Dio dell’etica. Non il Dio assoluto, inconoscibile secondo l’indagine della critica kantiana, inaccessibile, assolutamente Altro perché ab-solutus, sciolto da qualsiasi vincolo, ma il Dio della Relazione che sintetizza le “relazioni sussistenti” del suo essere trinitario, «diverso»: cioè tre persone in intima e costante relazione tra loro che in questa relazione fondano la loro natura e la loro forza e dignità. Relazione perfetta che vediamo risplendere nella massima opera della Trinità: l’Incarnazione del Figlio di Dio e la sua donazione sulla croce: nel volto del povero bambino e nel volto insanguinato del crocifisso.
Nel volto del povero, dice Levinas, accade la manifestazione di Dio, perché
«L’idea di una Verità che si mostra nella sua umiltà, come una voce di fine silenzio secondo l’espressione biblica, l’idea di una Verità perseguitata non è forse l’unica modalità possibile della trascendenza? Non a causa della qualità morale dell’umiltà che io non voglio affatto contestare, ma a causa della sua modalità d’essere che è, forse, la sorgente del suo valore morale. Manifestarsi come umile, alleato del vinto, del povero, del perseguitato significa appunto non rientrare nell’ordine» [16].
Dio non rientra nella medesimità dell’ordine teoretico ma nella diversità della vita. Nel volto del povero si manifesta una Verità trasgressiva che capovolge i termini classici della trascendenza intesa in maniera unidirezionale, verso l’alto; la direzione della trascendenza verso l’humus, nella modalità dell’humilis è propria di Dio che si dirige in basso per dar voce a chi non ha voce nell’atto morale necessario nella sua stessa natura relazionale. In questa trascendenza ontologica il volto del povero rivela il trascendimento etico come conseguenza naturale della Relazione sussistente in Dio all’interno della quale c’è l’Altro, c’è il volto povero del Figlio bambino e crocifisso in cui si rivela l’assolutamente trascendente, l’infinità dell’infinito (Levinas la chiama «infinizione») che ci viene incontro e si mostra come tale. Il volto è un discorso, parla e vive biblicamente nel povero, nello straniero, nella vedova e nell’orfano; nella sua epifania è etica, è ciò che non si può uccidere, ciò che guardandoti negli occhi dice: «tu non ucciderai».
 Il passaggio dall’ontologia all’etica, il considerare l’etica, come fa Levinas, non più una branca della filosofia ma «filosofia prima» deve indurci a cercare Dio non più con la ragione, ma con la vita, non con la teoresi ma utilizzando la vita come strumento di conoscenza. Non nell’infinito fuori la nostra misura ma nel contingente della misura nostra dove si è voluto calare come Altro ad Altri. Non nelle ipostasi ma nella carne del Figlio che è la carne dell’Altro che si può toccare per riconoscerne le infermità contemplando in esse le proprie. La tradizione ebraica rinchiude l’ontologia di Dio in quattro consonanti impronunciabili, mentre narra le sue gesta in favore del suo popolo che culminano nella liberazione pasquale; e Gesù di Nazareth sigilla quella pasqua con la sua che è stata passaggio esistenziale dalla morte alla vita per il semplice fatto di aver incarnato l’opera di Dio, il suo “sogno”, il suo “Regno”, la sua etica solidale di liberazione, e per averlo fatto da Straniero, da Diverso, da Escluso dal Sistema. Questo suo “mistero” deve liberarci dalle insidie di ogni Sistema che tenta di catturare Dio nelle maglie delle ideologie correnti, per farne uno strumento del delirio di onnipotenza. La storia è costellata di tali ideologie, fino al presente. Ciò dovrebbe costituire un monito per il cristianesimo che ha, in teoria, aderito all’azione pasquale del Figlio dell’Uomo che «non ha dove posare il capo», solidale con tutti gli Altri delle Korogocho di questa terra.
Il passaggio dall’ontologia all’etica, il considerare l’etica, come fa Levinas, non più una branca della filosofia ma «filosofia prima» deve indurci a cercare Dio non più con la ragione, ma con la vita, non con la teoresi ma utilizzando la vita come strumento di conoscenza. Non nell’infinito fuori la nostra misura ma nel contingente della misura nostra dove si è voluto calare come Altro ad Altri. Non nelle ipostasi ma nella carne del Figlio che è la carne dell’Altro che si può toccare per riconoscerne le infermità contemplando in esse le proprie. La tradizione ebraica rinchiude l’ontologia di Dio in quattro consonanti impronunciabili, mentre narra le sue gesta in favore del suo popolo che culminano nella liberazione pasquale; e Gesù di Nazareth sigilla quella pasqua con la sua che è stata passaggio esistenziale dalla morte alla vita per il semplice fatto di aver incarnato l’opera di Dio, il suo “sogno”, il suo “Regno”, la sua etica solidale di liberazione, e per averlo fatto da Straniero, da Diverso, da Escluso dal Sistema. Questo suo “mistero” deve liberarci dalle insidie di ogni Sistema che tenta di catturare Dio nelle maglie delle ideologie correnti, per farne uno strumento del delirio di onnipotenza. La storia è costellata di tali ideologie, fino al presente. Ciò dovrebbe costituire un monito per il cristianesimo che ha, in teoria, aderito all’azione pasquale del Figlio dell’Uomo che «non ha dove posare il capo», solidale con tutti gli Altri delle Korogocho di questa terra.
Tale riflessione, o forse è meglio chiamarla “contemplazione”, va fatta in primo luogo celebrando il “memoriale” di quella Pasqua, contemplando il gesto rituale che ne simbolizza l’intenzionalità. Ci si è troppo soffermati sulla dimensione ontologica che quel gesto non ha, essendo accompagnato da un imperativo etico: «fate»! Si son voluti distinguere sostanza e accidenti di una presenza che trova solo in noi il suo telos e compimento, perché quel corpo spezzato e quel sangue versato vanno a identificarsi con i nostri corpi dati, spezzati e il nostro sangue versato per tutti, per Altri potremmo tradurre col lessico di Levinas. Il sacrificio pasquale di Cristo di cui la cena eucaristica è anamnesis, cioè ricordo e presenza, memoria attualizzante, addita alla presenza reale del corpo dei poveri che sono il corpo di Cristo, il sangue versato dei martiri, dei perseguitati, dei giustiziati dal Sistema, degli stuprati dal potere che ha crocifisso Gesù di Nazareth «fuori dalle porte della città» (cfr. Gv 19,41 e Eb 13,12. Scartato in vita e in morte.
Corpo spezzato «per Altri», sangue versato «per Altri», «per voi e per le moltitudini» disse ai suoi discepoli: «Fate questo in memoria di me». Il segno dello “spezzare il pane”, che diede il nome all’eucaristia della Chiesa primitiva ( κλάσιV τοῦ ἄρτου in At 2,42) era il segno per eccellenza per riconoscere Gesù, il Signore; era koinonia con il suo corpo che “si dona”. Koinonia è un concetto polisemico che vuol significare unione, compagnia, vincolo, comunicazione, simpatia, compassione, solidarietà. Dono “per Altri” della sua “carne”, vocabolo usato verosimilmente da Gesù (bashar-bishra), che da buon semita lo usa per il parallelismo con il sangue; secondo l’espressione ebraica dam beriti, o aramaica adam keyami “sangue della mia alleanza” [17].
Ed è nel teologumeno Alleanza che si esplicita il concetto di Solidarietà di Dio con l’umanità. Tutte le alleanze stipulate da Dio con il genere umano di cui parlano i libri dell’Antico Testamento, a partire da quella stipulata con Noè, erano state tutte infrante. L’unica giunta a buon fine è quella nel sangue del Figlio che liberamente lo versa “per tutti”. Il binomio “pane-vino” diventa nel rituale celebrato da Gesù metafora dell’altro, “corpo-sangue”, che ha alle spalle una lunga tradizione antropologica semitica: in ebraico bashar (carne-corpo) si riferisce alla persona come essere vivente, e dam (sangue) esprime la vita, e in forma di sineddoche (metafora), l’essere umano. Entrambi i termini permettono di stabilire una stretta relazione con quelli del primo binomio: il corpo-carne con il pane, il sangue con il vino. Il sangue, inoltre, assume nella Torah un valore espiatorio:
«La vita della carne è nel sangue. Perciò vi ho concesso di porlo sull’altare in espiazione per le vostre vite, perché il sangue espia, in quanto è la vita» (Lv 17, 11) [18].
Il vino era per il popolo d’Israele segno della prosperità e della vita, segno dell’amore di Dio, ma soprattutto, nel contesto rituale, era segno delle promesse messianiche e del loro compimento alla fine dei tempi (cfr. Am 9,14; Os2,24; Is25,6), la realizzazione del “sogno di Dio”. Ma se il vino nel calice era segno della festa messianica, nello stesso tempo era anche segno dell’amarezza della vita; amarezza che deve essere bevuta fino all’ultima goccia: «Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?» (Gv 18,11); «Padre, se vuoi, allontana da me questo Calice» (Lc 22,42). In questa ambivalenza del segno deve essere interpretata la presenza del calice nella celebrazione della Pasqua ebraica, come nella celebrazione dell’eucaristia cristiana, dove si fa memoria di un dono esistenziale che passa però attraverso un esodo faticoso, attraverso la croce: «Ogni volta che bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore, finché egli venga» dice Paolo (1 Cor 11,26). La morte di Gesù è dono per la vita: «Per questo sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10) e il pane e il vino nella simbolica rituale riportano nel presente le significazioni pasquali di quella cena che fu la cena della “sua Pasqua”, della sua immolazione pasquale necessaria per restare fedele al patto di alleanza stipulato con Dio, ciò che era il contenuto programmatico della sua missione:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 4, 18-19).
Ma è proprio questo programma a procurargli la morte, perché lo estende all’umanità intera, a cominciare dai pagani (cf. Lc 4, 22-27) e la sua gente, i suoi se ne scandalizzano; allora «all’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù» (Lc 4, 28-30). La morte era assolutamente prevista nella sua missione, assumendo il senso del sigillo di quella dei profeti che avevano dato la vita per gli altri, fiduciosi del fatto che Dio non poteva abbandonarli in potere del male (cf. Lc 11, 47-51; 13, 33s.). La croce di Gesù perciò non può essere separata da ciò che lui ha detto, fatto, insegnato e vissuto in favore di Altri, poiché è proprio per questo che viene condannato a morte; bisogna guardare non tanto alla morte in sé come causa di salvezza, ma alla causa di quella morte che ne è radice salvifica: la sua fedeltà e la sua obbedienza al progetto salvifico di Dio che è semplice: «vuole che tutti gli uomini siano salvati, e che vengano alla conoscenza della verità» (1Tim 2,3-4).
La morte di Gesù sulla croce non è soltanto un evento di espiazione del peccato degli uomini, ma la rivelazione di chi sia veramente Dio. Solo nell’amore che si dona Dio è conosciuto e solo per questa strada lo si può raggiungere. È questa la Verità che si mostra come carne visibile, che non ha nulla a che vedere con la tradizione dei filosofi dell’Occidente che l’hanno idolatrata nell’ontologia e ridotta a concetto della mente che si trasmette con la parola: concetto-parola-concetto-parola-concetto… Siamo talmente abituati all’elaborazione concettuale che ci sembra troppo banale la verità come “fatto” e nonostante duemila anni di cultura “cristiana” non sappiamo coniugare logos e carne, dal momento che ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο (Gv 1, 14).
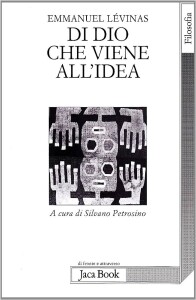 Nella vita di Gesù non c’è stata separazione tra parola e fatto, e il suo annuncio era proteso a divenire corpo reale, concretezza del progetto di Dio, del suo “sogno”. Nel Regno di Dio da lui annunciato è necessario che le cose siano segno d’amore dell’uno per l’altro in maniera che nessuno sia bisognoso (cfr. At 4, 32-35). L’abolizione del bisogno, della povertà, fa parte della fede cristiana, altrimenti anche la liberazione diventa un concetto e il culto a Dio una superstizione, perché non c’è culto senza liberazione, non c’è pasqua senza ingresso nella terra promessa. La via a Dio non comporta macerazione ascetica; fare a meno delle cose è ascetica pagana, mentre l’imperativo biblico è la crescita della creazione, il moltiplicarsi dei beni come mezzo di comunione e di benessere degli uomini, e l’abbondanza della vita affermata da Gesù di Nazaret è il sigillo di quell’imperativo, per cui è divenuto Cristo.
Nella vita di Gesù non c’è stata separazione tra parola e fatto, e il suo annuncio era proteso a divenire corpo reale, concretezza del progetto di Dio, del suo “sogno”. Nel Regno di Dio da lui annunciato è necessario che le cose siano segno d’amore dell’uno per l’altro in maniera che nessuno sia bisognoso (cfr. At 4, 32-35). L’abolizione del bisogno, della povertà, fa parte della fede cristiana, altrimenti anche la liberazione diventa un concetto e il culto a Dio una superstizione, perché non c’è culto senza liberazione, non c’è pasqua senza ingresso nella terra promessa. La via a Dio non comporta macerazione ascetica; fare a meno delle cose è ascetica pagana, mentre l’imperativo biblico è la crescita della creazione, il moltiplicarsi dei beni come mezzo di comunione e di benessere degli uomini, e l’abbondanza della vita affermata da Gesù di Nazaret è il sigillo di quell’imperativo, per cui è divenuto Cristo.
«Nella prossimità si ode un comandamento venuto da un passato immemorabile: che non è presente, che non è cominciato in alcuna libertà» afferma Levinas in quella che è la sua opera definitiva circa il primato dell’etica sull’ontologia: Altrimenti che essere o al di là dell’essenza [19]. Tutto l’itinerario terreno di Gesù, dei suoi detti, atti e fatti, può essere descritto nella parabola fenomenologica levinasiana che considera l’uomo non come un essere che crea idealisticamente se stesso, ma un essere che si trova originariamente «assegnato» all’alterità e alla responsabilità, dove la soggettività non è originariamente un per sé ma per altro: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda» (Gen 2, 18). La prossimità non è uno stato di quiete, ma inquietudine, in quanto io sono responsabile dell’altro indipendentemente che l’altro lo sia nei miei confronti, e tale responsabilità «arriva sino alla sostituzione», in una ipseità completamente dedita al prossimo: «La parola “Io” significa eccomi (Me voici), rispondente di tutto e di tutti» [20]. Quando questo non accade si entra nel mondo di Caino: «Caino, dov’è Abele tuo fratello? Egli rispose: “Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?”» (Gen 4, 9).
È l’evento stesso della soggettività l’apertura primordiale verso il prossimo: la responsabilità precede la libertà e risulta anteriore ad ogni soggetto; è il trascendimento dell’essere egoistico e conflittuale dove l’esse si realizza nell’interesse «degli egoismi in lotta gli uni con gli altri»; trascendimento in direzione dell’alterità e della fraternità: «L’umanità […] è l’essere che si disfa della sua condizione d’essere: il dis-interesse» [21]. Così l’etica di Levinas, nel capovolgimento di tutti i principi ontologici, si configura come etica della santità. «Santità difficile, perché naturalmente siamo tutti portati a passare prima degli altri. Ma santità possibile, ideale d’eccellenza che abita ogni uomo» [22] e che schiude le porte alla dimensione del divino. «Non può esserci nessuna “conoscenza” di Dio a prescindere dalla relazione con gli uomini» [23]; «l’idea dell’infinito in me – o la mia relazione a Dio – mi accade nella concretezza della mia relazione all’altro uomo, nella socialità che è la mia responsabilità per il prossimo» [24].
Sono pregne di esistenza le considerazioni di Emmanuel Levinas; in esse traspare una umanità pura e sincera, il senso di una ricerca metafisica nel concreto della vita. Ma quanto serve una tale riflessione all’uomo d’oggi? Siamo poi tanto sicuri che questa contemporaneità voglia cercare Dio? Incontrarlo? Non è l’uomo contemporaneo più che appagato del suo essere inter-essato alla cura di sé, e per sé, senz’altra relazione con l’altro che non sia di interessi grezzi? Korogocho non compare tra le mete turistiche di nessuna seria agenzia di divertissement, che è lemma filosofico utilizzato da Blaise Pascal con il quale il pensatore francese ha indicato il complesso di occupazioni, relazioni, intrattenimenti quotidiani e sociali con cui l’uomo rifugge dalla propria infelicità e dalle questioni più annose. Di-vertimento come di-vergere dall’essenziale, dai nodi dell’esserci. Senza la ricerca di una con-versione all’Altro. Il mondo contemporaneo dis-tratto dal divertissement approntatogli dal Sistema – un Sistema che gettata la maschera rivela il volto del mysterium iniquitatis – è costretto a guardare il mondo come nella caverna platonica e coglie le immagini accattivanti e artificiali che passano sugli schermi dei media come una realtà in cui integrarsi, un paradiso da raggiungere. Uomini e donne, giovani e meno giovani vanno ormai in giro con sotto il naso questi schermi che schermano il reale e impediscono la contemplazione di volti, di volti d’Altri.
Korogocho è l’emblema dei ghetti della storia contemporanea dove si rinchiudono, si ammassano e si escludono i volti della prossimità. Volti che diventano numeri anonimi, pratiche burocratiche, nelle “case di accoglienza”, nelle “case di riposo per anziani”, nei luoghi di detenzione dei “diversamente abili” prima che delle carceri; in tutti i luoghi in cui gli “ospiti” sono accolti con grande “interesse”, per un redditizio interesse. Eppure è lì, in questi luoghi che Dio abita, in questi tabernacoli impreziositi dalla sofferenza umana intrisa ancora dal sangue di Cristo.
Da lì, abbiamo detto, bisogna partire per riscrivere la teologia cristiana, per de-ontologizzarla del tutto. Troppo pesante nella teologia “ufficiale” è l’influsso dell’ontologizzazione sulla riflessione sul mistero di Dio e di Gesù Cristo; la concezione di sant’Anselmo d’Aosta, inventore della prova ontologica dell’esistenza di Dio, che intendeva la sofferenza di Gesù come espiazione per la rabbia legittima di Dio contro l’umiliazione che la nostra esistenza peccaminosa significa per Lui, non ha riscontro negli scritti del Nuovo Testamento, e non viene espressa in alcun modo da Gesù. Eppure tale concezione fondamentalmente errata ha influenzato fortemente la teologia e l’etica della Chiesa, almeno fino al presente. È solo dal postconcilio in avanti che altre teologie sono venute alla ribalta, ispirate dal dato biblico che Dio in Gesù di Nazaret abbia condiviso e ancora condivida la nostra storia. La teologia dev’essere esplorazione continua dello spazio che la prossimità liberante di Dio mette a nostra disposizione; riscoperta dei termini concreti della sua solidarietà con il genere umano. La solidarietà di Dio ha nome Gesù di Nazaret, nella cui vita e nella cui storia pienamente umana è venuto in luce qualcosa di assoluto in sé, e che deve essere accolto, messo in atto per la salvezza dell’umanità.
 Tra queste nuove teologie “non allineate” c’è indubbiamente, e adesso non per ultima, quella di papa Francesco; una teologia venuta con lui “da un altro mondo”, da quell’America Latina da cui, già dagli anni Settanta del secolo scorso, emersero movimenti di stampo messianico e sociologico che reinterpretarono la parola di Dio e misero in campo una nuova cristologia, una nuova ecclesiologia e una diversa antropologia [25]. Da qui presero le mosse, in tutti i Paesi non europei e non occidentali, quelle che si possono chiamare le “teologie post-coloniali”, impegnate a riflettere sull’impatto del colonialismo eurocentrico sulle strutture socio-economiche, sull’interpretazione culturale, sulla teologia e i suoi luoghi teologici dei Paesi colonizzati. Ci si rese conto, tra i teologi del Terzo Mondo, di esser prigionieri di un modello di cristianesimo creato per loro da altri, gli euro-occidentali, definitivamente strutturato all’esterno in tutti i suoi aspetti: dottrinale, liturgico, giuridico e disciplinare; ma tutto ciò non ha consentito ai popoli oppressi del Terzo Mondo di uscire fuori dalla miseria, dalle malattie e dalla morte per fame. L’annuncio cristiano non ha sortito l’effetto della liberazione, del riscatto, di ciò che nel lessico cattolico del postconcilio si denominò «promozione umana».
Tra queste nuove teologie “non allineate” c’è indubbiamente, e adesso non per ultima, quella di papa Francesco; una teologia venuta con lui “da un altro mondo”, da quell’America Latina da cui, già dagli anni Settanta del secolo scorso, emersero movimenti di stampo messianico e sociologico che reinterpretarono la parola di Dio e misero in campo una nuova cristologia, una nuova ecclesiologia e una diversa antropologia [25]. Da qui presero le mosse, in tutti i Paesi non europei e non occidentali, quelle che si possono chiamare le “teologie post-coloniali”, impegnate a riflettere sull’impatto del colonialismo eurocentrico sulle strutture socio-economiche, sull’interpretazione culturale, sulla teologia e i suoi luoghi teologici dei Paesi colonizzati. Ci si rese conto, tra i teologi del Terzo Mondo, di esser prigionieri di un modello di cristianesimo creato per loro da altri, gli euro-occidentali, definitivamente strutturato all’esterno in tutti i suoi aspetti: dottrinale, liturgico, giuridico e disciplinare; ma tutto ciò non ha consentito ai popoli oppressi del Terzo Mondo di uscire fuori dalla miseria, dalle malattie e dalla morte per fame. L’annuncio cristiano non ha sortito l’effetto della liberazione, del riscatto, di ciò che nel lessico cattolico del postconcilio si denominò «promozione umana».
Come promuovere la teologia della solidarietà, della prossimità con l’Altro? Una teologia che interpreti l’unica professione di fede possibile nel Dio di Gesù Cristo che si è manifestato sin dagli inizi della storia come colui che libera? Quello della liberazione non è un attributo accessorio di Dio, marginale, ma qualificante. Si deve diffondere tra i cristiani, di tutte le confessioni, una nuova coscienza della fede che parta dalla Responsabilità di cui parlava filosoficamente Levinas. Responsabilità del volto dell’Altro come Solidarietà del Volto di Dio che si è manifestato nel Volto sfigurato del suo Cristo, il Messia sofferente di Isaia che prende su di sé il peso delle ingiustizie umane. Perché questo è il «peccato del mondo»: l’ingiustizia che provoca povertà, miseria, odio, guerra in questo mondo che si ritiene “civilizzato” e si vanta della sua tecnologia e dei suoi progressi scientifici. Che si vanta della democrazia e della giustizia, mentre tutto è già detto, tutto è già scritto, tutto è già fatto, tutto è secondo la tradizione; perché questo pare il senso della giustizia: ripetere all’infinito ciò che si è già sperimentato, di escludere la novità, perché ogni novità nasce sempre “fuori legge”; come Gesù che nacque “fuori legge”, e per questo fu condannato “secondo la legge”.
Responsabilità, Solidarietà, Liberazione devono essere nuove virtù da affiancare alle virtù teologali della teologia cristiana, perché conducano Fede Speranza e Carità a rintracciare sotto le coltri delle dogmatiche, delle ontologie e delle metafisiche, esplicite ed implicite, il Dio primordiale della liberazione e della giustizia. Si potrebbe riproporre la provocatoria proposta di Dietrich Bonhoeffer, il grande martire cristiano ucciso dai nazisti nel 1945: fare il patto di non parlare più di Dio per trenta o quarant’anni, e mettere in atto soltanto le opere che sono il luogo in cui Dio parla. L’Occidente ha fatto di Dio il garante di tutti i poteri, avendolo qualificato ontologicamente onnipotente, mentre il Dio della Bibbia, il Dio di Gesù Cristo prende posizione contro coloro che opprimono il popolo, contro tutti i Faraoni della storia. Per questo alla teologia ufficiale, dogmaticamente immobile, suonano stonate le note di una teologia che con papa Francesco viene “dall’altro mondo”. Maurice Bellet afferma con studiata ironia: «Giungiamo a chiederci se, nel pensiero occidentale così come lo percepiamo col senno di poi e qui, il Vangelo come Vangelo abbia mai raggiunto il pensiero; cioè, se si sia davvero dispiegato un pensiero in cui il Vangelo pensa, e non che si applica al Vangelo per farlo pensare» [26].
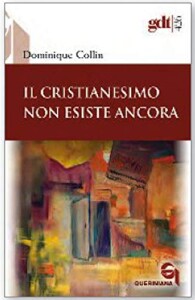 E sono guai quando il Vangelo pensa al posto dei pensatori per tradizione di un pensiero fotocopia, dei garanti della legge e della morale farisaica; guai perché rompe ogni tradizione di irrigidita ontologia che si regge per l’ordine interno che s’è data e non certo in coerenza con l’etica del Vangelo. Tremano i troni dei potenti quando Papa Francesco grida con forza che bisogna smetterla col colonialismo e che l’Africa non è una terra da sfruttare e saccheggiare per arricchire i potentati internazionali buttando poi a mare i suoi figli che fuggono la povertà, la guerra, la morte e per seppellirli nel cimitero del Mediterraneo.
E sono guai quando il Vangelo pensa al posto dei pensatori per tradizione di un pensiero fotocopia, dei garanti della legge e della morale farisaica; guai perché rompe ogni tradizione di irrigidita ontologia che si regge per l’ordine interno che s’è data e non certo in coerenza con l’etica del Vangelo. Tremano i troni dei potenti quando Papa Francesco grida con forza che bisogna smetterla col colonialismo e che l’Africa non è una terra da sfruttare e saccheggiare per arricchire i potentati internazionali buttando poi a mare i suoi figli che fuggono la povertà, la guerra, la morte e per seppellirli nel cimitero del Mediterraneo.
La vera causa delle migrazioni di massa, di questo epocale esodo africano in cammino verso terra promessa, è da ricercare nell’avidità del neo colonialismo economico ancora più schiavizzante dei precedenti. Lo sfruttamento dell’Africa è un dramma davanti al quale il mondo economicamente più progredito chiude gli occhi, le orecchie e la bocca. «Il veleno dell’avidità ha reso i suoi diamanti insanguinati» mentre «il terrorismo al servizio degli stranieri si consuma nel silenzio della comunità internazionale». Chi ascolterà veramente il grido di papa Francesco che ha parlato a nome di tutte le Korogocho disseminate sul nostro pianeta? Quanti tra i potenti che governano il nostro mondo assumeranno l’habitus della Responsabilità verso Altri?
Chi vuole trovare Dio, comunque, deve andare ancora a Korogocho! Solo i puri di cuore vedranno Dio, coloro che vanno a Korogocho con un cuore senza macchia, senza pregiudizi, senza attendersi ricompensa ma solo per il bene d’Altri, solo per tergere il volto sporco e deturpato di Dio. Come papa Francesco che non teme le critiche dei potenti e dei benpensanti e trova Dio nel grido dei poveri e nelle loro danze liturgiche. Come Alex Zanotelli che nel suo libro di testimonianza e denuncia, La solidarietà di Dio, paragona Korogocho alla «Galilea delle genti» frequentata da Gesù, terra di impoveriti ed emarginati sotto la pressione dell’imperialismo politico, militare ed economico romano; lì Gesù evoca l’immagine apocalittica del «Figlio dell’uomo» che compare nella visione del profeta Daniele e la applica a sé. Questo è il suo titolo ufficiale nei Vangeli: «Figlio dell’Uomo». L’auspicio di Daniele era che dopo tante Bestie (gli Imperi) arrivasse finalmente un Uomo [27]. E giunse Gesù di Nazaret, la solidarietà di Dio.
Di fronte alle enormi ingiustizie e ai crimini che ancora impunemente si perpetrano in questo nostro mondo è fondamentale che i cristiani, le chiese, rilancino la dimensione messianica del cristianesimo, cioè la potenza di trasformazione della storia che l’annuncio in parole e opere del Regno di Dio predicato da Gesù implica e le cui qualità sono la giustizia e la pace. L’opzione preferenziale per i poveri proclamata dalle chiese dell’America Latina deve diventare l’opzione di tutte le chiese, in Africa, in Asia e in Europa. Il magistero di papa Francesco sta diffondendo autorevolmente la coscienza di tale esigenza con quella Responsabilità che è spinta esistenziale in favore d’Altri. Questo è il compito per i cristiani del terzo millennio: ogni volta che noi mettiamo in atto la prassi di Gesù come prassi di liberazione e di umanizzazione noi diamo un volto umano alla storia e incarniamo la Solidarietà di Dio realizzando il suo “sogno”, il suo Regno in questo mondo. Se i due miliardi e duecento milioni di cristiani nel mondo tenessero alto il valore messianico e liberante del cristianesimo, invitando anche le altre religioni di “buona volontà” ad impegnarsi per il riscatto dei poveri e degli oppressi, allora si potrebbe davvero scrivere qualche pagina nuova della storia e inaugurare un’altra era dell’umanità.
Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2023
Note
[1] A. Zanotelli, La solidarietà di Dio, Editrice Missionaria Italiana, Bologna 2003.
[2] Ibid: 13.
[3] Ibid.: 9-11.
[4] J. Ratzinger, L’angoscia di una assenza. Meditazioni sul Sabato Santo, in «30 Giorni», 03-2006.
[5] A. Zanotelli, La solidarietà di Dio, cit.: 7.
[6] Ibid: 17-18.
[7] Cfr. Platone, Repubblica VII, 514a-517.
[8] E. Levinas, Tra noi. Saggi sul pensare all’Altro, Jaca Book, Milano 2016: 86.
[9] G. De Gennaro, Emmanuel Levinas profeta della modernità, Edizioni Lavoro, Roma 2001: 118.
[10] Intervista dello «Spiegel», Ormai solo un Dio ci può salvare, 23 settembre 1966. Il filosofo rispose all’accusa di nazismo chiedendo che il testo – ora in Scritti Politici (1933-1966), Piemme, Casale Monferrato 1998: 263-96 – fosse pubblicato solo dopo la sua morte.
[11] A. Zanotelli, La solidarietà di Dio, cit.: 8.
[12] E. Levinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano 1980: 19.
[13] Ibid.: 41.
[14] πρός in greco significa “verso”. Non rende la traduzione italiana di Gv 1,1 che traduce πρός con “presso”: Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. “Verso” esprime in maniera più pregnante la relazione, l’orientamento delle persone, l’una “di fronte” all’altra.
[15] Come attesta il suo uso in Omero. Per le analisi dei passi omerici si veda lo studio di M. Fattal, Ricerche sul logos da Omero a Plotino, Vita e Pensiero, Milano 2005: 24 e 42 sg.
[16] E. Levinas, Tra noi. Saggi sul pensare all’Altro, cit.: 87.
[17] Cfr. L. Bouyer, Eucaristia. Teologia e spiritualità della preghiera eucaristica, Elle Di Ci, Torino 1983: 112.
[18] Cfr. J. A. Sobrado, Dayenù. Haggadàh di Pésach. Le origini dell’Eucaristia, Grafite ed., Napoli 1998: 150-151.
[19] E. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, Jaca Book, Milano 1983:110.
[20] Ibid.: 143.
[21] E. Levinas, Etica e infinito, Città Nuova, Roma 1984: 114.
[22] «La Stampa», 6 maggio 1992: 15.
[23] E. Levinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, cit.: 76-77.
[24] E. Levinas, Di Dio che viene all’idea, Jaca Book, Milano 1985: 12.
[25] Cfr. G. La Bella, L’America Latina e il laboratorio argentino, in A. Riccardi (a cura di), Il cristianesimoal tempo di papa Francesco¸Laterza, Bari-Roma 2018: 34-60.
[26] Cit. in D. Collin, Il cristianesimo non esiste ancora, Queriniana, Brescia 2020: 85.
[27] A. Zanotelli, La solidarietà di Dio, cit.: 48.
______________________________________________________________
Leo Di Simone, teologo, scrittore, esperto di musica liturgica e di arte sacra, ha insegnato Antropologia culturale e Liturgia presso la Facoltà Teologica di Sicilia (Palermo), l’Istituto di Scienze Religiose di Mazara del Vallo e l’Istituto Teologico di Scutari (Albania). È presbitero della Diocesi di Mazara del Vallo e docente stabile di teologia presso la Scuola Diocesana di Teologia. Nella stessa Diocesi coordina il progetto “Operatori di pace” e dirige l’Ufficio Diocesano per i Migranti. Attualmente è Referente diocesano per il Sinodo dei Vescovi. Tra le sue pubblicazioni, si segnalano i seguenti volumi, editi da Feeria (Panzano in Chianti – Firenze): Liturgia secondo Gesù. Originalità e specificità del culto cristiano. Per il ritorno a una liturgia più evangelica (2003); Vexilla Regis. La croce dipinta di Mazara del Vallo. Icona pasquale della liturgia (2004); Beato Angelico. L’estetica del Verbo incarnato (2004); Le rotte dei Misteri. La cultura mediterranea da Dioniso al Crocifisso (2008); Liturgia medievale per la Chiesa postmoderna? La questione del “rito antico” nel racconto del “rito romano” (2013). Ha curato, per i tipi de Il Colombre, il volume Trasfigurazione. La Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo. Culto Arte e Storia (2006). L’ultimo suo volume è un saggio biografico su Thomas Merton: Il romanzo di Thomas Merton. Un umanista cristiano nell’era postcristiana, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani (2018).
______________________________________________________________










