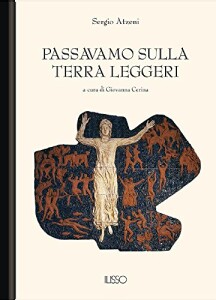Non sapevo nulla della vita, esordirà. La frase ha il sapore di un manifesto programmatico, a fine corsa, dell’afflato intellettuale di Sergio Atzeni, le cui opere sembrano respirare. Un senso nobile, catartico nella sua passione, permea la sua scrittura protesa alla comprensione dello spirito e delle meccaniche della sua terra d’origine, così bisognosa di curiosità.
Quando nel 1996 si dà alle stampe, postumo, Passavamo sulla terra leggeri [1], oggi ristampato per i tipi di Sellerio (2023) si avanza così di cento passi nel percorso di definizione di una letteratura che insegni a pensare o ripensare la Sardegna [2]. L’ultimo romanzo dello scrittore di Capoterra, mancato l’anno prima, è un’opera che guarda alla complessità di un’Isola, quella dei nuraghi, da tanti percepita come “maledetta” nella sua bellezza, mai veramente afferrabile, disponibile a ricevere amore ma maldisposta a schiudersi per davvero; una terra in cui ciò che vale e può esprimere risulta sempre e comunque sottomesso all’esigenza di chiamarla in causa per investirla dei più gratificanti ma vuoti titoli, lontani dai suoi intrecci reali.
Atzeni, invece, dimostra di avere capito bene la sua Sardegna, e vi riesce nel più mirabile dei modi: cantandone l’intimità, come già aveva saputo fare; condensando, in un ritmo vivace, ironico e mai eccessivo, contraddizioni, vicende, archetipi e stereotipi su un popolo che della varietà culturale e dell’unione è metafora storica e geografica.
 Onere e onore si bilanciano: il solco tracciato è quello, illustre, di Giulio Angioni, Grazia Deledda o Salvatore Satta, per dire solo alcuni fra i tanti eccezionali cantori della densità e della varietà sarde, dal primo declinate e tradotte anche nei linguaggi dell’antropologia. Come l’Angioni antropologo e poi scrittore e romanziere di fatti di Sardegna, anche Atzeni ama parlare di verità sociale e mancanze e non già rifacendosi a quanto plasticamente evidente e che, nella sua carica seduttiva, conduce a contentarsi dell’apparenza. Questa, infatti, che rende facilmente satolli, della comprensione è nemica giurata, poiché capace di contraffazione. Sergio Atzeni va invece a fondo, ossequioso verso una volontà dichiarata, quella di raccontare tutto il possibile della sua terra:
Onere e onore si bilanciano: il solco tracciato è quello, illustre, di Giulio Angioni, Grazia Deledda o Salvatore Satta, per dire solo alcuni fra i tanti eccezionali cantori della densità e della varietà sarde, dal primo declinate e tradotte anche nei linguaggi dell’antropologia. Come l’Angioni antropologo e poi scrittore e romanziere di fatti di Sardegna, anche Atzeni ama parlare di verità sociale e mancanze e non già rifacendosi a quanto plasticamente evidente e che, nella sua carica seduttiva, conduce a contentarsi dell’apparenza. Questa, infatti, che rende facilmente satolli, della comprensione è nemica giurata, poiché capace di contraffazione. Sergio Atzeni va invece a fondo, ossequioso verso una volontà dichiarata, quella di raccontare tutto il possibile della sua terra:
«Io credo che la Sardegna vada raccontata tutta … se avrò vita cercherò di raccontare i paesi, uno per uno, e tutte le persone, una per una. Non credo che avrò vita per fare questo, ma cercherò di farlo perché tutto merita di essere narrato. Credo che le vite di tutti gli uomini meritino di essere in qualche modo ricordate, trasmesse» [3].
Per il suo sforzo di celebrazione dell’alterità e la sua fisionomia di sunto (anche temporalmente) della poetica dell’autore, Passavamo sulla terra leggeri assurge allora a testamento spirituale di Sergio Atzeni, che consegna ai posteri un’opera piacevole, vitale e attuale, di un senso sospeso tra il bisogno di sentirsi parte della storia, la propria, e quello di viverla assieme all’Altro, agli altri che quotidianamente incrociano il nostro cammino. La concluderà sei giorni prima di morire, tragicamente, nel mare di Carloforte.
Comunemente noto e classificato come romanzo ma di fatto svincolato dalla rigidità delle categorie, il testo riunisce più “microstorie” i cui singoli sviluppi avanzano sulla densa diacronia che ha costruito i paesaggi, la società, l’immaginario e l’idea di identità dei sardi, qui chiamati ad un costante lavoro di introspezione critica. Il viaggio comincia in un indefinito frangente della preistoria – quando accadimenti senz’altro decisivi hanno cominciato a dirigere i modi umani di vivere sull’isola di Sardegna – e si conclude, invece, in un momento meglio precisato: quella della fine (de facto) del giudicato di Arborea, nel 1409, data de Sa Batalla (“la battaglia”, in sardo), scontro decisivo che oppose le truppe aragonesi a quelle arborensi, con queste che – sconfitte – consegnarono di fatto l’isola agli iberici.
«Esplorammo un tratto d’isola e scegliemmo per vivere un luogo che riuniva molte buone cose: era esposto a oriente sulla costa d’occidente: accanto alla montagna, dove avremmo potuto rifugiarci e difenderci in caso di nemici».
 La costante che permea l’intreccio è la forma della restituzione orale – e quindi mnemonica – delle diverse storie, che il custode del tempo Antonio Setzu di Morgongiori si preoccupa di raccontare al giovane auditore-narratore che, a sua volta, potrà fregiarsi del ruolo di depositario delle antiche memorie. Il controllo del tempo, infatti, è il primo dei topoi che Sergio Atzeni sembra onorare nel suo impianto storico-mitico, e che si concreta nell’uso personificato della memoria orale, specificamente in Sardegna avvertita come veicolo primo di conoscenze e saperi finalizzati al mantenimento di un intimo rapporto con gli antenati (e quindi la parentela), la terra, le stagioni, la tecnica, la prassi, la produzione sostenibile, i mestieri. Anche le date, però, sono importanti. È il 12 agosto del 1960, «fra le tre del pomeriggio e il dodicesimo rintocco di mezzanotte», ch’egli accoglie e assimila un passato da custodire e tramandare a sua volta.
La costante che permea l’intreccio è la forma della restituzione orale – e quindi mnemonica – delle diverse storie, che il custode del tempo Antonio Setzu di Morgongiori si preoccupa di raccontare al giovane auditore-narratore che, a sua volta, potrà fregiarsi del ruolo di depositario delle antiche memorie. Il controllo del tempo, infatti, è il primo dei topoi che Sergio Atzeni sembra onorare nel suo impianto storico-mitico, e che si concreta nell’uso personificato della memoria orale, specificamente in Sardegna avvertita come veicolo primo di conoscenze e saperi finalizzati al mantenimento di un intimo rapporto con gli antenati (e quindi la parentela), la terra, le stagioni, la tecnica, la prassi, la produzione sostenibile, i mestieri. Anche le date, però, sono importanti. È il 12 agosto del 1960, «fra le tre del pomeriggio e il dodicesimo rintocco di mezzanotte», ch’egli accoglie e assimila un passato da custodire e tramandare a sua volta.
Nella cucina di Antonio Setzu, suo confidente, Sergio Atzeni meglio fa suo il mestiere di etnografo ascoltando, osservando e partecipando col piglio dello studioso accorto, che non butta via niente, e con la passione dell’apprendista. Di Setzu non sappiamo troppo, ma quanto basta: «basso, rubusto, forse un po’ grasso», allevava cavalli ed era solito rivolgervisi «chiunque in paese avesse bisogno di un consiglio assennato». Di sua moglie conosciamo altrettanto: «piccola, avvolta di nero antico, aveva occhi grigi e buoni». A lei è demandato il governo dei periodi di stallo tra un episodio e l’altro del racconto, che in casa Setzu si susseguono intervallati dai momenti del desinare con i prodotti che lo spazio domestico, interno ed esterno, può regalare, ed è impossibile non cogliere una connessione che, quasi intrinseca, sembra implicitamente concretarsi delineando figure, ruoli, gesti e ambienti cari alla Deledda, dove anche ogni riposo ed ogni attesa si incastrano perfettamente nello spartito del fare quotidiano in quanto salubre impiego rigenerativo del proprio tempo avulso dalle incombenze della stagionalità agraria.
«Erano le dieci. Mi accorsi che la moglie di Antonio era sparita. Antonio si levò e mi fece cenno di seguirlo. Trovammo la moglie che arrostiva cervelli d’agnello nel giardino chiuso della casa. Nel giardino limoni, uva prensile, due cotogni, mandorli, decine d’erbe diverse, pietre, un pozzo, uccelli a centinaia, tre cani, otto gatti, un cavallo in un angolo che brucava tranquillo. Tutto attorno a alberi e animali la casa di struttura semicircolare e il muro che la separava dalla strada, col portale al centro. Ogni stanza della casa aveva una finestra che dava sul giardino».
La casa in cui il narratore immagina di trovarsi quando ascolta le sue storie è descritta come il modello abitativo della Sardegna tradizionale, decoroso e misurato surrogato produttivo di orto e animali domestici, dove ogni centimetro è funzionale all’autosufficienza, almeno in epoca precapitalistica (fino, all’incirca, alla metà dello scorso secolo). Nelle immaginarie osservazioni di Atzeni, tese in questo caso alla ricostruzione fedele del contesto di vita, non manca l’attenzione alla superstizione, come si conviene ai racconti “del focolare” così bene descritti già da Deledda o Angioni, e ne traccia anche più scientifici disegni.
«La donna prese dal camino spento un rametto secco, lo accese, lo lasciò bruciare, soffiò spegnendo la fiamma, tracciò in aria una croce con la punta rossa di carbone e disse: “Non sai quel che dici, ti benedico, non ti uccidano ferro, piombo o veleno”».
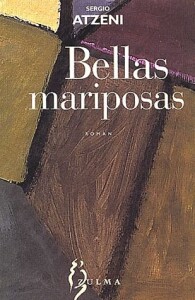 Soffermarsi sulla statura di Sergio Atzeni quale attento osservatore partecipante dei paesaggi sociali, anche nei suoi intenti simulatori, non è banale ai fini della comprensione della sua opera e del suo lascito, che sembra gravitare fra più mondi letterari e stilistici con esiti di notevole trasparenza narrativa e comunicativa. Mi sembra il caso di Bellas Mariposas, altra opera postuma (1996) in cui lo scrittore racconta le vicende vissute da due ragazzine cagliaritane che, in una giornata d’agosto (nuovamente), animate dal disincanto giovanile, esplorano sé stesse cercando di trascorrere diversamente il loro tempo nel mondo e nelle difficoltà dell’insidioso quartiere in cui abitano, menomato da droga e delinquenza [4]. Grazie a sforzi critico-descrittivi come questo possiamo comprendere come ogni opera di Sergio Atzeni venga prima amorevolmente coltivata e vegliata, e solo dopo una lunga gestazione veda la luce; lotta titanica, la sua, per favorirne il miglior concepimento. Sergio Atzeni sembra vivere nei suoi romanzi e per essi, librandosi in volo fra le strade, sui paesaggi e, mano nella mano, coi personaggi delle sue storie. Ebbe a dire:
Soffermarsi sulla statura di Sergio Atzeni quale attento osservatore partecipante dei paesaggi sociali, anche nei suoi intenti simulatori, non è banale ai fini della comprensione della sua opera e del suo lascito, che sembra gravitare fra più mondi letterari e stilistici con esiti di notevole trasparenza narrativa e comunicativa. Mi sembra il caso di Bellas Mariposas, altra opera postuma (1996) in cui lo scrittore racconta le vicende vissute da due ragazzine cagliaritane che, in una giornata d’agosto (nuovamente), animate dal disincanto giovanile, esplorano sé stesse cercando di trascorrere diversamente il loro tempo nel mondo e nelle difficoltà dell’insidioso quartiere in cui abitano, menomato da droga e delinquenza [4]. Grazie a sforzi critico-descrittivi come questo possiamo comprendere come ogni opera di Sergio Atzeni venga prima amorevolmente coltivata e vegliata, e solo dopo una lunga gestazione veda la luce; lotta titanica, la sua, per favorirne il miglior concepimento. Sergio Atzeni sembra vivere nei suoi romanzi e per essi, librandosi in volo fra le strade, sui paesaggi e, mano nella mano, coi personaggi delle sue storie. Ebbe a dire:
«Lavoro di notte, scrivo di notte, con grande fatica e con una lentezza che ha qualcosa di spaventoso. George Simenon scriveva un romanzo di quattrocento pagine in due mesi, poi una settimana di sesso folle con la cameriera, poi in altri due mesi un nuovo romanzo. Ne scriveva tre all’anno e su tre uno era un capolavoro e gli altri di media qualità. Io ho impiegato due anni per fare un racconto di cento pagine ed è stato il mio record di velocità»[5].
In una più ampia prospettiva etnologica, Passavamo sulla terra leggeri ottiene di manifestare un’aperta ribellione al tempo che scorre infrangendo i canoni stessi della storia in senso epistemologico, dal cui spartito di disciplina attenta a rendere giustizia ai grandi fatti che l’hanno determinata l’autore strappa delicatamente uomini e donne nella loro imprecisa e difettosa singolarità – ricchi/e, poveri/e, buoni/e, cattivi/e. L’umano, che la storia sembra convintamente abbracciare solo dalle Annales in poi, con le nuove prospettive introdotte da Marc Bloch e Lucien Febvre [6], è la sostanza della ricostruzione di Atzeni, nella quale il passato si fa incontro, relazione, unione, e definisce la misura della sua grandezza di scrittore: quella di ripercorrere, con appassionata profondità, la complessità del divenire, fissato soltanto dall’irripetibilità delle culture che, a partire dal neolitico, hanno potuto definire il nostro moderno essere abitanti del mondo.
 Il filo e le tracce, la storia ed il mito: pensarsi sardi
Il filo e le tracce, la storia ed il mito: pensarsi sardi
Travalicando i suoi stessi confini, l’opera getta ponti e suggerisce linee di continuità, come anche brusche interruzioni ed espedienti risolutivi. Sergio Atzeni non ha alcuna pretesa di veridicità storica, eppure la lunga parabola umana ch’egli descrive riesce ad addensare, in un appassionante avvicendarsi di racconti, quegli stilemi e quegli stigmi che l’immaginario collettivo dei sardi – attingendo ora alla storia ufficiale, ora al mito e all’oralità – conserva gelosamente pensandosi popolo.
«Mir fece per primo gli ometti di bronzo con le corna, molti occhi e molte braccia. Li metteva negli approdi e sui massi lungo i sentieri. Se mai qualcuno fosse sbarcato sfuggendo la sorveglianza, trovandoli avrebbe saputo d’essere capitato nella terra degli uomini cornuti danzanti delle scogliere.
Mir disse: Le stelle sono sillabe del creatore, Is è parola intera. L’acqua feconda la terra dei danzatori. Cercheremo l’acqua nei monti di Is scavando pozzi. La invocheremo al principio della stagione del risveglio, nel mese del vento che piega le querce, con la festa».
Questo breve passo concentra, ad esempio, alcune suggestioni che tentano di spiegare, anzitutto, più o meno fantasiosamente, la nascita della piccola statuaria bronzea nuragica (i cosiddetti “bronzetti”) [7] o, se non altro, di alcuni suoi esemplari [8]. Sergio Atzeni suppone, allora, una volontà intimidatoria (e di autodifesa) per giustificare l’esistenza di alcuni fra i prodotti plastici più famosi del panorama archeologico nuragico, e sottolinea (involontariamente?) un ordine di dinamiche in cui l’antropologia, prima di altre discipline, ha saputo riconoscere uno dei motivi in grado di determinare l’evoluzione: quello dell’eventualità e dell’opportunità che, spesso confuso col più popolare concetto di caso, dà modo ad una cultura di implementare le sue capacità di avanzamento e miglioramento. In questo senso, portatore di questa introduzione sarebbe stato il capo nuragico Mir.
Oltre alle statuine bronzee, l’autore riferisce poi dell’origine delle architetture dell’acqua, note in Sardegna come pozzi sacri o templi a pozzo [9] e sulle cui motivazioni all’origine ancora si dibatte, sebbene quella della penuria idrica sia, effettivamente, la tesi generalmente riconosciuta.
«Non lasciavamo altre tracce che i nuraghe, le navi di bronzo di Urel di Mu e i piccoli uomini cornuti, guardiani dell’isola, che molti fecero imitando Mir. Nessuno sapeva leggere e scrivere. Passavamo sulla terra leggeri come acqua» .
La garbata sapienza della reinterpretazione accorta e plausibile del fatto storico rende questo libro speciale oltre, mi sembra, i suoi stessi confini letterari, e accorda a Sergio Atzeni quella sensibilità concreta, spesso cristianamente tradotta, che dalle epoche più recenti riconosce l’essere sardi. L’attenzione alla mescolanza, alla connessione e all’alterità come generatrici di cultura si rinnova anche nell’allusione all’arrivo dei fenici nell’isola, fase storiograficamente delicata soprattutto in considerazione del senso comune moderno dei sardi, che tende a collocarsi in maniera piuttosto guardinga e scettica verso il ruolo reale ricoperto da queste genti nei processi culturali del I millennio a.C., dallo scrittore di Capoterra così in parte risolti (forse anche provocatoriamente): «Il mercato di Lo, l’intero villaggio di Lo, si mescolò al villaggio fenicio facendo nascere la prima città dell’isola».
Se l’indulgenza verso questi irresistibili (e pacifici, per quanto ne sappiamo) mercanti è evidente, nelle pagine di Passavamo sulla terra leggeri non può riscontrarsi lo stesso per i romani, la cui ingerenza è documentata in Sardegna a partire dal III secolo a.C. e a cui il custode del tempo Antonio Setzu imputa, iperbolicamente, mille anni di guerra per l’isola: « Itzor di Ar disse: «I romani sono erba maligna, riempie tutto il pascolo uccidendo l’erba buona e se tenti di strapparla ti avvelena».
La ricchezza dell’opera non rende certo agevole, come si vede, tentare una scelta dei principi che la governano, ma tempo, memoria e oralità hanno certamente un ruolo trainante dell’economia dei racconti e del filo che li unisce. Tutti e tre, a loro volta, sembrano controllati e in certo modo riassunti dal leitmotiv dell’incontro, unità costitutiva fondamentale dell’impalcatura narrativa e rappresentante, probabilmente, quelle tracce alle quali alludo nel titolo del paragrafo e che rimanda ad una raccolta di saggi di Carlo Ginzburg [10] in cui lo storico si occupa di riflettere sul suo mestiere e sul rapporto tra verità storica, finzione e menzogna, di cui Sergio Atzeni fornisce, con quest’opera, una versione inedita e convincente.
Il motivo dell’incontro, degli incontri scandisce la parabola tracciata dallo scrittore di Capoterra, che ripercorre e rielabora, alla luce delle loro plurime forme, le vicende che hanno declinato la presenza umana nell’Isola fin dal neolitico. Ed è col linguaggio degli incontri che Atzeni tesse le sue trame cosmogoniche. Da quello pacifico e abbondante, sulla costa, delle genti fenicie giunte in Sardegna cariche di ogni bene fra tappeti, spezie, oggetti di pregio e animali da scambiare, è salvifica l’epifania di Amsicora, che subentra d’improvviso nell’intreccio manifestandosi alle genti sarde come capo dei rivoltosi anti-romani, nel III sec. a.C., e così consegnandosi alla storia come simbolo della resistenza autoctona contro l’invasore in ogni epoca, compresa quella sabauda.
Decisivo, per la struttura, risulta poi l’incontro fra il «bambino figlio di schiavi» e il «vecchio vagabondo che passò per Siurgus», in età già romana, e che, rifocillato con acqua a e pane, si accinge a raccontare la storia di Iesus: «Era figlio di Dio». Da questo momento, il lungo tracciato del cristianesimo segnerà, oltreché i modi di vita e pensiero delle popolazioni isolane, indelebilmente le pagine dell’Atzeni, bravo a rendere educatamente l’intersezione delle confessioni allora vigenti senza stravolgere la fenomenologia storica, per larghi tratti brutale nei secoli della presenza di Roma; altresì insegnando, con passi quasi pedagogici, che ogni fede o convinzione ha valore solo in quanto applicata al suo spazio di vita e millenaria costruzione e ricezione di saperi socio-ambientali e consuetudini inapplicabili e insensate oltre appena un confine marino.
La riluttanza degli autoctoni verso l’istituzione ecclesiastica, comprovata da una storiografia che ne ha saputo mettere in luce gli aspetti più indelicati, emerge nel più esemplare degli incontri in tal senso: quello tra Barisone, fiero giudice d’Arbaré [11], e l’episcopo di Karale (Cagliari), mandato al cospetto del regnante arborense perché questi riconosca la sovranità del pontefice di Roma, il papa. Figura ricorrente delle dispute giudicali, e qui importante per il vescovo che ne richiede il possesso, risulta essere il “libro di Lucifero”, immaginato e descritto da Sergio Atzeni come testo eretico (per la Chiesa) e «diabolico vangelo» che raccoglie le interpretazioni dottrinali di Lucifero, nella realtà vescovo di Cagliari vissuto nel IV secolo e scagliatosi contro l’arianesimo. Dal dialogo oppositivo tra queste due figure istituzionali si giunge all’incontro, fortuito e fecondo, tra il giudice Mariano, nipote di Barisone, e «Annicca, contadina di Siurgus», che gli darà una figlia: Eleonora, giudicessa d’Arborea. Quando la corona impose a Mariano di sposarsi per favorire la nascita, con urgenza, di un suo successore per la guida del giudicato, questi, al trentanovesimo anno di un regno devastato dalla penuria e dalla «locusta di Persia», concluse di prendere in sposa la prima nubile che avesse trovato uscendo dal palazzo. Fu Annicca.
La pluridimensionalità dell’incontro è declinata da Sergio Atzeni nella varietà delle forme dei sensi e degli accadimenti. Incontro è, a tal proposito, quello di Martina, misteriosa figura-ombra di Mariano, coi falchi che la accompagnano ovunque, contribuendo a ravvivarne la veste enigmatica; gli stessi che seguiranno il feretro del giudice alla sua morte, simbolici dell’ultimo frangente di vita dello stesso giudicato, il più longevo dei quattro, e quasi presagendone la fine, di lì a poco, per mano aragonese. Incontro è, ancora, quello della stessa Martina, volontariamente spirata, che va a ricongiungersi con Mariano, asceso al cielo da poche ore.
«Mangiammo le teste d’agnello in silenzio ascoltando una donna, invisibile nel giardino accanto, che cantava la canzone antica di un bandito ucciso e della madre che lo piange, la cantava a anninnia, forse aveva un bimbo e lo addormentava».
La donna cantante, incontro sonoro del narratore-auditore, squarcia con la sua voce la stasi della calura d’agosto e l’inerzia del racconto di Antonio Setzu, e un’analogia illustre sembra sorgere dalle righe di Sergio Atzeni, prendendo la forma della celebre scultura di Francesco Ciusa La madre dell’ucciso, oggi conservata nella Galleria Comunale d’Arte di Cagliari [12]. Una suggestione, questa, il cui sfondo – la morte di un bandito – sembra trovare riscontri nel ruolo centrale ricoperto in Passavamo sulla terra leggeri dalle bardanas, cui Atzeni fa molto spesso ricorso nelle trame delle sue storie e che consistevano in vere e proprie spedizioni armate di uomini a cavallo che, di notte, convergevano su un villaggio o uno stazzo per rapinare una o più case di ricchi possidenti. Si tratta di uno degli aspetti più truci e noti del banditismo sardo, che in questa forma infiammava la Sardegna centrale e settentrionale soprattutto negli ultimi decenni dell’Ottocento. Protagonista vero, in questi confronti, è il lettore, chiamato ad interrogare questi personaggi ed interagire direttamente con loro.
La misura del mondo
Johan Huizinga definì la storia come la forma dello spirito in cui una civiltà si rende conto del suo passato; in essa, ricerca la propria posizione nel mondo, vede la propria auto-rappresentazione: vi si proietta secondo dei crismi riconosciuti come familiari nel corso del suo lungo tempo culturale. Fallacia della storia? Non era certo il senso delle parole dello storico olandese, ma mi sembra che un più pacifico rapporto col concetto di identità possa enormemente giovare sia alla storiografia – oggi brava a gestirlo – che, generalmente, a chiunque si guardi alle spalle.
Passavamo sulla terra leggeri, dal canto suo, sembra aggrapparsi ad un bisogno di identità nel suo senso più profondo. Sergio Atzeni, però, non casca nella sua stessa trappola: l’autore padroneggia dalla prima all’ultima riga la sua opera, molto ben consapevole che il ritmo uniforme delle sue descrizioni e delle vicende che senza velleità storiografiche restituisce sia teso, soprattutto, ad esorcizzare quello stesso bisogno di auto-identificazione resistenziale in cui gli abitanti della Sardegna sembrano spesso fatalmente imprigionati a causa di una mitizzazione malgovernata di istanze politiche e velleità istituzionali.
Ma cos’è l’identità se non la propria intima rappresentazione del reale che, divenendo, offre dei porti sicuri in cui riconoscersi e a cui anelare nella difficoltà? Cos’è se non un luogo – personale o collettivo, fisico o figurato – in cui recarsi attraverso un percorso che reca la potenza dell’ignoto? Sergio Atzeni gioca in maniera magistrale con la nostra, la sua e l’altrui identità, ora elevandola al più alto e socialmente sublime dei gesti compiuti nella storia ed ora richiamandone l’origine all’immediatezza del caso, del bisogno fisico o del meno nobile fare per la sopravvivenza.
Passavamo sulla terra leggeri, come il suo titolo, come chi legge, si chiede chi siamo e forse addirittura lo racconta ma non dà alcuna risposta, comunque dicendo abbastanza e invitando, io credo, a non prendere troppo sul serio il proprio senso nel mondo, perché siamo in misura maggiore ciò che capita e che incontriamo rispetto a quanto determiniamo fissando le nostre condizioni; siamo l’esito di un incontro infinito fra le nostre e le altrui intenzioni e volontà, e siamo esseri identitari in quanto riconosciamo l’altro come simile e avendo l’intelligenza di farne nostre le istanze e i problemi, perché solo allora si saprà riconoscere quanto ci definisce come peculiari e quanto ogni cultura, e tutte assieme, sia al suo posto nel pianeta che abitiamo.
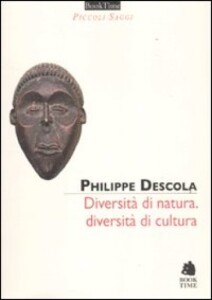 Credo che il titolo di questo libro, meglio delle mie parole, serbi già questi nessi e queste possibilità analitiche, raccogliendoli in un monito. Almeno, questo si profila mentre scrivo, quando alacremente i canali di produzione mediatica ci raccontano l’indicibile tragedia del terremoto che in questi giorni ha devastato la Turchia causando migliaia di morti e feriti, e ricordandoci del nostro tempo incerto e sospeso nel mondo. Quando qualcuno è in grado di riconoscersi in essa, insomma, l’opera è riuscita, e leggendo il capolavoro di Sergio Atzeni si ha la sensazione di sapere bene cosa significhi la Sardegna per un sardo, di averlo sempre saputo, pur non avendo certezza alcuna e quindi consci di un bisogno di riscoperta. Si ha la sensazione, alla fin fine, di sapere quale sia il proprio posto. Di passaggio, con leggerezza, nel mondo.
Credo che il titolo di questo libro, meglio delle mie parole, serbi già questi nessi e queste possibilità analitiche, raccogliendoli in un monito. Almeno, questo si profila mentre scrivo, quando alacremente i canali di produzione mediatica ci raccontano l’indicibile tragedia del terremoto che in questi giorni ha devastato la Turchia causando migliaia di morti e feriti, e ricordandoci del nostro tempo incerto e sospeso nel mondo. Quando qualcuno è in grado di riconoscersi in essa, insomma, l’opera è riuscita, e leggendo il capolavoro di Sergio Atzeni si ha la sensazione di sapere bene cosa significhi la Sardegna per un sardo, di averlo sempre saputo, pur non avendo certezza alcuna e quindi consci di un bisogno di riscoperta. Si ha la sensazione, alla fin fine, di sapere quale sia il proprio posto. Di passaggio, con leggerezza, nel mondo.
«Così, anche se la soluzione che noi vorremmo per l’avvenire, un’alternativa valida di vivere insieme certo tra umani, ma anche tra umani e non umani, non esiste ancora, noi abbiamo almeno la speranza, poiché altri l’hanno fatto prima di noi in altre civilizzazioni e altre società, di poter inventare dei modi originali di abitare la terra» [13].
Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2023
Note
[1] L’edizione utilizzata per questo testo è Atzeni S. Cerina G. (a cura di), Passavamo sulla terra leggeri, ILISSO, Nuoro, 2000
[2] Senza velleità alcuna, il presente contributo intende suggerire spunti, avanzare considerazioni e semplicemente invitare alla lettura dell’opera in oggetto, poiché solo chi si immerga davvero in Passavamo sulla terra leggeri potrà percepire simili impressioni.
[3] Atzeni S., Il mestiere dello scrittore in Atzeni S., Si…otto!, Condaghes, Cagliari, 1996: 79
[4] Dall’opera è nato, nel 2012, un bellissimo film del regista Salvatore Mereu, al cui trailer rimando: https://www.youtube.com/watch?v=O7935FnCxjo
[5] Atzeni S., Sì…otto!, cit.: 81
[6] Cfr. Le Goff J. (a cura di), La nuova storia, Mondadori, Milano, 1980
[7] Qui un agile e valido riassunto: https://www.sardegnacultura.it/documenti/7_26_20060401123630.pdf
[8] Ad ispirare l’autore, infatti, sembra essere il cosiddetto “eroe cornuto” con quattro occhi e quattro braccia dall’insediamento nuragico di Abini, a Teti (SS): https://it.wikipedia.org/wiki/Bronzetto_nuragico#/media/File:Civilt%C3%A0_nuragica,_prima_et%C3%A0_del_ferro,_bronzetti_dal_santuario_di_albinieti_(NU),_grande_demone_a_quattro_occhi,_quattro_braccia_e_due_scudi_02.jpg
[9] Fadda M. A., L’architettura dedicata al culto dell’acqua in Moravetti A., Alba E., Foddai L. (a cura di), La Sardegna nuragica. Storia e materiali, Corpora delle Antichità della Sardegna, Carlo Delfino Editore, Sassari, 2014: 79-92
[10] Ginzburg C., Il filo e le tracce. Vero, falso, finto, Feltrinelli, Milano, 2015
[11] Si allude al giudicato d’Arborea, uno delle quattro conformazioni statuali indipendenti in cui l’isola risulta divisa almeno fino dal X secolo d.C.
[12] https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/2000245057
[13] Descola P., Diversità di natura, diversità di cultura, Book Time Ed., Milano, 2011: 31.
______________________________________________________________
Nicolò Atzori, consegue una laurea triennale in Beni Culturali (indirizzo storico-artistico) con una tesi in Geografia e Cartografia IGM e una magistrale in Storia e Società (ind. medievistico) con una tesi in Antropologia culturale, presso l’Università di Cagliari, ottenendo in entrambe il massimo dei voti. Altresì, è diplomato presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Cagliari. Dal 2017 lavora, per conto di CoopCulture, come operatore museale e guida turistica presso il Museo Villa Abbas e il sito archeologico di Santa Anastasia di Sardara (SU), luoghi dei quali, fra le altre cose, cura la comunicazione e, nel primo caso, gli aspetti museografici. Sta frequentando il master di Antropologia Museale e dell’Arte della Bicocca.
______________________________________________________________