 per la cittadinanza
per la cittadinanza
di Antonello Ciccozzi
I dintorni dei concetti giuridici di cittadinanza
Parlare di cittadinanza significa parlare di migranti. Oggi è in gran parte così in quanto in Occidente la questione epocale dell’inclusione (o esclusione) dei migranti si realizza, da un punto di vista istituzionale, attraverso il conferimento (o la negazione) della cittadinanza.
Si tratta di un gesto insieme altamente simbolico e concreto; inteso, quale atto amministrativo di riconoscimento dei diritti della persona, come traguardo e momento di attualizzazione politica delle pratiche di accoglienza e delle poetiche sull’integrazione entro cui si gioca la linea di separazione tra coloro che hanno accesso a un pacchetto di diritti di base che consentirebbero una «buona vita» (Butler 2013) e coloro che restano disprezzati in quanto ridotti essenzialmente a «non-persone» (Dal Lago 2012) dalla mancanza di questo riconoscimento.
Se questo traguardo ha una valenza rituale che sancisce il passaggio dalla parola/status ‘migrante’ a quella ‘residente’, il percorso che lo riguarda è segnato dalla tensione tra due attitudini governamentali distinte che in questo caso si concretizzano, soprattutto nel dibattito italiano, nella formula dello ius soli (cittadinanza per nascita) opposta a quella dello ius sanguinis (cittadinanza per discendenza).
In queste righe – dove continuo e concludo un discorso che ho iniziato qui su Dialoghi Mediterranei nel numero 50 e proseguito nel numero 51 – non tratterò della discussione sulle suddette declinazioni giuridiche della cittadinanza ma mi soffermerò sui dettagli epistemologici e le implicazioni ideologiche inerenti al campo oppositivo che esse delineano dal momento in cui si transcodificano culturalmente nei termini di una “cittadinanza facile” versus una “cittadinanza difficile”, ovvero di una pulsione di apertura versus una di chiusura. Questa è una delle modalità in cui si manifesta una tendenziale polarizzazione dell’ethos occidentale tra due culture, una dell’accoglienza e una della sicurezza, intese come forme attuali della tensione schismogenetica (Bateson 1977) inquadrabile nella faglia politico-antropologica tra la cultura di sinistra e quella di destra, la struttura archetipica del sistema di metà che caratterizza la modernità politica occidentale.
Preliminarmente riprendo in merito il discorso in cui, in altre occasioni (Ciccozzi 2014, 2016) ho inteso sottolineare come l’attuale politicizzazione della rappresentazione dei fenomeni migratori produce due semiosfere tendenti a contenuti opposti e complementari che si manifestano nella forma di due Weltanschauung antropologiche in tensione reciproca.
Nella semiosfera della cultura dell’accoglienza le migrazioni non sono affatto un fenomeno pericoloso, travolgente e in aumento, come pensa erroneamente la maggior parte della gente che crede al mito dell’“invasione”: in realtà i migranti sono pochi e sono vittime sofferenti che fuggono da guerre causate da noi e da nostre colpe coloniali passate e presenti; colpe che dobbiamo espiare con l’accoglienza. Da questa prospettiva i migranti non sono mai mossi dagli intenti violenti, aggressivi o predatori che immaginano gli xenofobi: non sono un problema ma sono una risorsa in quanto svolgono i lavori che gli occidentali non vogliono più fare, pagano loro le pensioni e compensano il calo di natalità del Nord del mondo, arricchendolo con la vitale diversità colorata che donano all’Occidente triste e vecchio; tutto nel quadro naturale dei processi migratori che riguarda l’essenza migrante dell’umano, pensato come homo migrans.
La generalizzazione del buon-migrante-vittima-risorsa è propedeutica all’idea che si debba accogliere il più possibile, accogliere tutti e riconoscere a tutti e il prima possibile la cittadinanza, nel rispetto multiculturalista del loro orizzonte culturale. L’accoglienza non solo è un dovere ma un vantaggio morale ed economico, prima per noi che per gli altri; per questo si configura come un imperativo categorico netto che non prevede sfumature, tanto più che nel discorso pubblico l’accogliere e l’integrare si con-fondono sistematicamente con l’onere umanitario del salvare vite dall’annegamento nel mar Mediterraneo. Date simili premesse si arriva alla conclusione logica per cui qualsiasi disallineamento da questo massimalismo dell’accoglienza, codificato come unica opzione umana eticamente possibile, è inteso come espressione di razzismo. A questo punto la cultura dell’accoglienza si fa immigrazionismo, ovvero ideologia fondata su una visione assiomatica e generalizzante delle migrazioni, intese come un fenomeno nient’altro che moralmente positivo, economicamente auspicabile ed ecologicamente inevitabile.
Così, da quella che per molti versi appare come un’attualizzazione contemporanea del mito rousseauiano del bon sauvage, nella sacralizzazione del migrante si manifesta un sentimento di xenofilia dato da un’assiomatizzazione della sua alterità che viene generalizzata nello stereotipo positivo della risorsa e della vittima da salvare dal male da cui fugge e da quello che trova; male che è sempre prodotto da un’alterità interna all’Occidente, inquadrabile nella sua parte colonialista, sovranista, suprematista, fascista. Si delinea in questo modo un triangolo drammatico vittima-carnefice-salvatore in cui nell’immigrazionista occidentale si intravede il profilo del white saviour, l’archetipo del salvatore bianco, il donatore di aiuto umanitario che salva il migrante vittima dal carnefice coloniale razzista, fascista, sovranista, suprematista; lo salva ricevendo in cambio il contro-dono dell’arricchimento culturale proveniente dalla diversità dell’altro, e quello della redenzione dai peccati coloniali come compensazione espiatoria per l’accoglienza.
Se la cultura dell’accoglienza si basa sull’ideale netto dell’«accogliamoli tutti» – spesso implicito in forma di metafisica latente, a volte maggiormente esplicitato (Manconi, Brinis 2013) – nella semiosfera della cultura della sicurezza si assiste a una gradazione, a un continuum in cui al limite di sinistra ci sono posizioni più moderate, contraddistinte da un ponderato scetticismo verso il multiculturalismo assoluto e il radicalismo dell’immigrazionismo xenofilo; mentre, andando verso destra, si passa a posizioni di rifiuto più marcato in una postura nazionalista e sovranista, per arrivare infine alla destra estrema xenofoba, al suprematismo, e alle degenerazioni verso il razzismo che, di fronte alla questione migratoria, arriva a compiacersi di riesumare riferimenti fascisti e nazisti.
Più ci si sposta dal massimalismo della cultura dell’accoglienza a quello della cultura della sicurezza più la dogmatica xenofila della diversità del migrante che arricchisce e basta si incrina e si sgretola, e subentra una cristallizzazione invertita verso la convinzione opposta per cui sarebbe in atto un processo di lenta ma inesorabile sostituzione etnica e di islamizzazione dei popoli europei da parte di una moltitudine migrante più propensa ad approfittare economicamente dell’Occidente che a integrarsi culturalmente. Questa eventualità, sempre a seconda del posizionamento politico-ideologico, può essere intesa come rischio inerente a una parte dei migranti o generalizzata come certezza catastrofica e cifra unica del processo migratorio. Quanto più si va verso la declinazione estremistica di questa visione sovranista tanto più gli stranieri sono generalizzati come invasori violenti, come clandestini mascherati da rifugiati: lupi travestiti da agnelli che nella maggior parte dei casi non fuggono da guerre ma le portano in Occidente, rubando lavoro, risorse e identità ai residenti.
Se per gli scettici verso l’immigrazionismo le migrazioni non sono un fenomeno esclusivamente positivo ma possono implicare anche dei problemi, per i sovranisti radicalizzati in senso suprematista le migrazioni sono solo un fenomeno negativo; da arginare il più possibile combattendo, nella veste di salvatori della patria, quello che viene immaginato come di un folle progetto sostituzionista della sinistra. La concezione del cattivo-clandestino-carnefice-problema caratterizza con rilevanza crescente l’opposizione alla cultura dell’accoglienza, in un aumento del peso specifico del sovranismo che va dalle posizioni moderate a quelle estremiste, in funzione del livello di diffidenza e di chiusura con cui si applica. Questa visione è, a seconda dell’intensità, propedeutica all’idea che si debba accogliere di meno, il meno possibile, o per nulla. All’estremo sovranista il valore dell’accoglienza viene annullato e invertito a disvalore assoluto dal momento in cui la negatività dell’altro non corrisponde all’effettiva percezione dell’eventuale ostilità di qualche migrante e non viene circostanziata a posteriori dal resoconto di esperienze reali, ma assume la forma di generalizzazione xenofoba, rivolta aprioristicamente verso i migranti tutti, visti come nemici semplicemente in quanto stranieri.
A questo è correlata l’idea che si debba riconoscere il diritto alla cittadinanza o in modo più misurato e prudente, o limitandolo solo a chi dimostra di essere integrato in uno schema variamente assimilazionista che prescrive l’abdicare dall’orizzonte culturale di provenienza e il riconoscere quello di approdo, fino al desiderio e alla volontà di negare totalmente tale diritto alla cittadinanza. Anche qui l’itinerario iniziatico di spoliazione dell’identità migrante al fine dell’approdo in quella nazionale è immaginato con vari gradi d’intensità, che partono da richieste di mediazioni rispetto al laissez faire multiculturalista, per arrivare alla chiusura assoluta in nome del proposito percepito come sacro della difesa dell’identità nazionale; ciò legittima una concezione xenofoba dell’alterità entro la pretesa di un diritto assoluto alla difesa del “noi” che eleva il rifiuto della diversità culturale a valore non negoziabile. Basti pensare, a titolo di esempio, a come si rivela divisiva la questione delle moschee (“aprire moschee ovunque e come vogliono loro”, “aprire moschee e chiedere prediche nelle lingue nazionali di approdo”, “non aprire assolutamente moschee”) o del velo islamico (“lasciare i migranti decidere in piena autonomia sul velo in base alla loro cultura”, “normare il velo in base ai valori nazionali”, “vietare il velo per difendere la nostra cultura”).
 Difensori dell’alterità migrante versus difensori dell’identità nazionale
Difensori dell’alterità migrante versus difensori dell’identità nazionale
Il punto è che i sentimenti collettivi di apertura e chiusura e le disposizioni ideologiche all’accoglienza o alla sicurezza tendono e polarizzarsi e a configurare dei rispettivi orizzonti culturali di appartenenza: le immagini di positività o negatività delle migrazioni sono presentate senza sfumature e nella veste di una verità unica ed esclusiva, per necessità mediatico-comunicative di riduzione della complessità di questi fenomeni e anche allo scopo politico di una reciproca delegittimazione della credibilità della controparte. In questo modo dall’universo reificato dei saperi esperti, dei politici e dei media si definisce l’universo consensuale del senso comune; ciò avviene in una pedagogia di massa entro regimi di verità dati dalla percezione selettiva delle sole manifestazioni della questione migratorie compatibili con i bias di conferma delle convinzioni acquisite, assunte come principi culturali insindacabili sulla generale positività o negatività dei fenomeni migratori.
Questo sdoppia la popolazione in due meta-tribù, quella dell’accoglienza versus quella della sicurezza, dove quello che si pensa della questione migratoria diventa un tratto che retroagisce sull’antropologia della persona stessa, definendone l’identità politica e l’essenza umana; e lo fa in un modo che prevede sempre meno disposizioni critico-problematizzanti ma si inquadra in una dinamica di appartenenza tribale che non consente ibridazioni e meticciamenti concettuali con la controparte politica ma prescrive posizionamenti in forma di aut-aut morale tra difensori dell’alterità migrante e difensori dell’identità nazionale. Ogni postura è presentata da chi la sostiene come empiricamente e moralmente fondata, ma sottende un posizionamento ideologico inteso nei termini di una visione parziale della realtà (Eco 1994), basata sulla sineddoche, sulla rimozione dei dati distonici rispetto alla rappresentazione che si vuole sostenere; ciò avviene in base a una disposizione ispirata a un finalismo interpretativo interessato a tutelare gli assiomi di appartenenza da evidenze che potrebbero intaccarne la pretesa di totale veridicità.
Se il filtro cognitivo degli immigrazionisti lascia vedere solo eventi come la tragedia dei bambini che affogano in mare, o la quotidianità di braccianti ridotti alla schiavitù per raccogliere i pomodori, quello dei sovranisti volge lo sguardo solo alla tragedia degli irregolari che violentano e uccidono, o alla quotidianità dell’accattonaggio molesto fuori dai supermercati. Ciascuna di queste due prospettive parziali produce il cono d’ombra della controparte, aiutata dalle reti mediatiche di riferimento politico, che regolarmente notiziano solo gli eventi compatibili con il proprio orizzonte ideologico, censurando invece quelli distonici rispetto alla rappresentazione stereotipata che fonda la loro visione del fenomeno migratorio. In tal modo si delinea un orizzonte di alterità interna alle società occidentali in cui ciascuna controparte è percepita reciprocamente come bugiarda, folle, egoista, disonesta, interessata, disumana: per gl’immigrazionisti i sovranisti sono il male, e viceversa.
L’ontologica ambivalenza della categoria generale del migrante – dell’altro che come “noi” non può che essere, in quanto essere umano, sia in parte positivo sia in parte negativo – viene scissa in due generalizzazioni disumanizzanti, una per eccesso e l’altra per difetto: una sacralizzante e l’altra demonizzante. Questo atto ideologico di riduzione della complessità dello straniero produce un piano assiologico che diventa spazio meta-tribale di appartenenza interna esclusiva tra xenofili e xenofili, in adorazione dell’emblema dell’alterità migrante versus quello dell’identità nazionale, del ponte versus quello del muro, dell’erranza versus quello della stanzialità, dell’inclusione attraverso la cittadinanza “facile” versus l’esclusione attraverso la cittadinanza “difficile”. In questa maniera il valore della cittadinanza si delinea come punta dell’iceberg di due opposte concezioni del mondo e della vita reciprocamente escludenti, dove per ciascuna ad essere tabù è il totem della controparte.
Il punto che qui ci riguarda è che l’apertura o la chiusura appaiono espressioni di una polarizzazione verso un substrato di ideali di communitas o immunitas (Esposito 1998, 2002, 2018), che definiscono l’altro come opportunità a cui donare il noi o come rischio da tenere separato da noi; che rimandano a un’oscillazione tra inclusione ed esclusione inscritta come paradosso generativo nella storia dei processi democratici, in cui ciascuna parte stempera nell’altra l’eccesso osceno dato dall’irrealizzabilità in assoluto del proprio progetto interno di annullamento delle ragioni e dei condizionamenti della controparte. Così si configura una situazione di formale conflitto ma di sostanziale collaborazione: i fondamentalisti dell’apertura hanno in qualche misura bisogno dei fondamentalisti della chiusura e viceversa. Perché – venendo al piano concreto del caso qui in esame – un po’ di migranti sono necessari anche a chi li rifiuta in toto ma si avvantaggia del loro lavoro servile; viceversa troppi sarebbero insostenibili anche per chi li invita tutti nella promessa di un benessere già perlopiù illusorio e poco moltiplicabile. Si tratta di un equilibrio in apparenza paradossale, che svela una costitutiva tensione in divenire; dove l’elemento chiave è proprio il mantenimento della tensione nel reciproco e mutuamente esclusivo proposito-progetto di risolvere tale tensione esclusivamente dal proprio lato.
È il caso di precisare che questo non vuol dire che la chiusura e l’apertura siano valori relativi o moralmente equivalenti: il superamento, il rifiuto dell’immunitas, l’emancipazione dalla pulsione alla chiusura all’altro sono valori umani non negoziabili, come non negoziabile è il rifiuto della xenofobia e del fascismo. Il problema nasce nel momento in cui questo rifiuto della xenofobia si converte nell’illusione xenofila dell’apertura incondizionata tutta e subito, e fomenta una visione politica radicale, che può essere ingenua e pericolosa. Non vuol dire che non si può aspirare a un mondo senza confini, di communitas universale; vuol dire che questo valore dovrebbe essere pensato non come uno stato che può essere subito raggiunto, al solo costo di liberarsi dalla xenofobia, dai razzisti, dai fascisti; ma andrebbe compreso come obiettivo storico al quale avvicinarsi in modo graduale, nel divenire di un processo perennemente in fieri, inquadrabile in un telos asintotico che sa aspettare e costruire le condizioni materiali per la sua crescente realizzazione.
Viceversa, gli ideali immigrazionisti no border di accogliere tutti, abbattere tutte le frontiere, dare a tutti la cittadinanza universale – in una postura presentista che non ammette processualità ma vuole darsi tutta e subito nell’estetica di una rivoluzione senza compromessi intesa come eredità marxista da riattualizzare – rischiano di scontrarsi con i limiti materiali del mondo e le istanze immunitarie dell’altro. Così il sensato rifiuto della paranoia xenofoba che vede nello straniero solo e sempre una minaccia rischia di condurre all’ingenuità xenofila che assiomatizza l’alterità migrante sempre e solo come una risorsa, e rifiuta qualsiasi problematizzazione e dubbio rivolto all’ideologia immigrazionista dell’accoglienza assoluta.
 Accoglienza e appartenenza, persone e luoghi
Accoglienza e appartenenza, persone e luoghi
A questo punto vorrei richiamare una massima di Italo Svevo: “è la gente triste che fa tristi i luoghi”. Lo faccio perché credo che si tratti di una considerazione rilevante nell’economia di questo discorso, almeno nella misura in cui, d’altra parte, è vero anche che “sono i luoghi tristi che fanno triste la gente”. Sostituendo il concetto di tristezza con quelli di bontà, intendo dire che nel caso del rapporto tra residenti e migranti – e posto che i luoghi sono spazi culturalizzati in quanto storici, identitari e relazionali (Augé 1993) – i luoghi per mantenersi bene hanno bisogno di essere voluti bene dalle persone che li abitano; allo stesso modo le persone, per vivere bene, hanno bisogno di essere ben volute nei luoghi dove abitano. Questo rapporto è particolarmente delicato nel caso dei migranti, le persone che nei luoghi sono gli ultimi arrivati; e se nella prima circostanza siamo di fronte alla richiesta assimilazionista di lealtà dei migranti ai luoghi, la seconda si configura come richiesta multiculturalista di apertura dei luoghi ai migranti.
Si delinea così una dimensione contrattuale caratterizzata da una dialettica tra accoglienza (delle persone) e appartenenza (ai luoghi), dialettica che rimanda a una reciprocità come scambio tra lealtà (come dono di rispetto verso il luogo dove si vive, in segno di riconoscimento del suo valore culturale) e possibilità (come dono alla persona che approda nel luogo per abitarlo, in segno di riconoscimento del suo valore umano). Se l’assimilazionismo punta prima di tutto a tutelare i luoghi di approdo dei migranti a partire da un conferimento di cittadinanza “difficile”, il multiculturalismo punta prima di tutto a tutelare i migranti nei luoghi di approdo a partire da un conferimento di cittadinanza “facile”.
Si tratta di posizioni non agevolmente conciliabili in un equilibrio inclusivo, che rimandano spesso a realtà paradossali: dietro quest’astrazione ci sono casi del tutto concreti, inquadrabili ad esempio in situazioni come quelle di giovani figli di migranti, cresciuti o nati in Italia, che non conoscono altri luoghi o altra lingua che quella della nazione che attende lunghi anni prima di concedere ad essi la cittadinanza; spesso troppi perché la loro adolescenza non sia esposta a varie forme di discriminazione. Allo speculare opposto ci sono similmente numerosi casi di persone che acquisiscono la cittadinanza in virtù della sola presenza continuativa sul suolo italiano per dieci anni o attraverso sanatorie, e lo fanno pur in assenza di alcuna volontà di appartenenza culturale, di riconoscimento di valore; pur nutrendo un sentimento di estraneità, testimoniato spesso da una padronanza bassissima o nulla della lingua italiana; pur perseguendo strategie di vita che possono prevedere l’ottenimento della cittadinanza per lasciare l’Italia godendo dei benefici del riconoscimento istituzionale di appartenenza alla nazione; in una postura di lontananza e a volte ostilità culturale rispetto alla nazione che gli ha dato la cittadinanza.
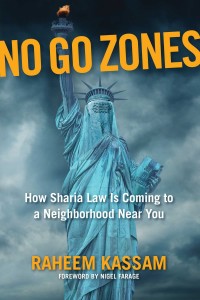 Così si capisce che, mentre l’accoglienza senza cittadinanza tende a degradare le persone migranti a non-persone come effetto dell’esclusione dall’ordine giuridico-politico nazionale, la cittadinanza senza volontà di appartenenza tende a degradare in non-luoghi quelli che per i residenti sono i luoghi d’origine o di vita; questo non solo per cause di marginalizzazione istituzionale, ma anche come effetto della presenza di persone che non riconoscono valore culturale allo spazio dei quartieri che abitano solo in funzione utilitaristica; e che tendono nel tempo a trasformare in un luogo altro, in base a loro istanze culturali incompatibili con quelle presenti al momento della loro venuta. Mi pare che su questo secondo aspetto si rifletta molto meno che sul primo, ma un raro esempio di analisi su questo tema viene da Paul Collier, il quale, sulla scorta di uno studio di Robert D. Putnam, ha recentemente notato in merito che i flussi migratori numerosi costituiti da persone con bassi livelli di fiducia verso i luoghi di approdo e una consistente distanza culturale rispetto alla popolazione autoctona tendono a deteriorare il capitale sociale e la qualità della vita di comunità di questi ultimi, producendo un «effetto tartaruga» che si traduce nella rinuncia dei residenti agli spazi pubblici e nel ripiegarsi in una dimensione privata (Collier 2015, Putnam 2007). È proprio in questo modo che l’ambiente storico di vita delle persone perde i caratteri relazionali e identitari, tendendo a scadere in un non-luogo.
Così si capisce che, mentre l’accoglienza senza cittadinanza tende a degradare le persone migranti a non-persone come effetto dell’esclusione dall’ordine giuridico-politico nazionale, la cittadinanza senza volontà di appartenenza tende a degradare in non-luoghi quelli che per i residenti sono i luoghi d’origine o di vita; questo non solo per cause di marginalizzazione istituzionale, ma anche come effetto della presenza di persone che non riconoscono valore culturale allo spazio dei quartieri che abitano solo in funzione utilitaristica; e che tendono nel tempo a trasformare in un luogo altro, in base a loro istanze culturali incompatibili con quelle presenti al momento della loro venuta. Mi pare che su questo secondo aspetto si rifletta molto meno che sul primo, ma un raro esempio di analisi su questo tema viene da Paul Collier, il quale, sulla scorta di uno studio di Robert D. Putnam, ha recentemente notato in merito che i flussi migratori numerosi costituiti da persone con bassi livelli di fiducia verso i luoghi di approdo e una consistente distanza culturale rispetto alla popolazione autoctona tendono a deteriorare il capitale sociale e la qualità della vita di comunità di questi ultimi, producendo un «effetto tartaruga» che si traduce nella rinuncia dei residenti agli spazi pubblici e nel ripiegarsi in una dimensione privata (Collier 2015, Putnam 2007). È proprio in questo modo che l’ambiente storico di vita delle persone perde i caratteri relazionali e identitari, tendendo a scadere in un non-luogo.
Lo stesso Putnam si è dichiarato imbarazzato dai risultati della sua ricerca, precisando che ha scelto di pubblicarla perché «occorre scongiurare che, in nome di un progressismo politicamente corretto, si neghi la realtà della sfida che la diversità pone nei confronti della solidarietà sociale». Il problema è che, dal momento in cui si afferma una concezione immigrazionista e xenofila radicale che vede nella diversità migrante nient’altro che ricchezza, inducendo qualsiasi dubbio all’autocensura attraverso la minaccia dello stigma di razzismo nei confronti degli scettici, sarà inibita la possibilità di ragionare sul rischio che i fenomeni migratori producano diffusi fenomeni di banlieueizzazione e di terzomondizzazione nelle società europee e occidentali, o di proliferazione di no go zones in cui si afferma una giurisprudenza che non riconosce il diritto positivo delle Costituzioni occidentali ma quello religioso della Sharia (Kassam 2017).
In tutti i modi l’esternazione di Putnam ci suggerisce che di fronte a quartieri in cui l’integrazione dei migranti è per molti versi fallita, producendo situazioni di disagio insediativo e culturale difficilmente eludibili, non ci si dovrebbe accontentare della rimozione omertosa del far finta di nulla, del blaming verso le istituzioni ritenute le sole responsabili con l’accusa di non integrare; o, peggio, di quello rivolto alla popolazione autoctona, tacciandola genericamente di razzismo per stigmatizzarne il malcontento riducendolo a generalizzata e immotivata xenofobia.
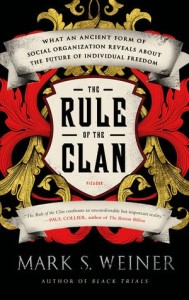 Quanto riconoscimento possiamo permetterci?
Quanto riconoscimento possiamo permetterci?
Se si esce tanto dall’idealismo immigrazionista della cittadinanza a tutti e subito quanto dall’etnocentrismo sovranista che vorrebbe sostanzialmente negare questo conferimento a tutti i migranti, si pone il problema di quanta cittadinanza possiamo permetterci di donare, e di quali sono i limiti culturali ed economici immanenti a questo atto di riconoscimento.
Da un punto di vista dei limiti culturali, se il progetto del multiculturalismo è quello di un mondo senza confini e senza vincoli localizzativi all’esistenza in cui tutti possano essere erranti e stranieri, il rischio è che se il disarmo degli elementi culturali identitari (regionali, nazionali, etnici, religiosi) che risultano etnocentrici, escludenti e aggressivi non avviene in modo multilaterale e generalizzato, l’apertura delle società di approdo del Nord del mondo possa diventare occasione per l’affermazione di identitarismi altrui di cui sono portatori quei migranti che si rivelano meno come persone che si lasciano alle spalle il loro mondo che come «coloni» che «portano con sé la loro società di origine» (Collier); e che il tutto avvenga importando configurazioni culturali spesso più basate sul mantenimento di codici tribali che sul loro superamento (Weiner 2011).
In tal senso bisognerebbe passare da una generalizzazione assiomaticamente positiva della diversità che arricchisce a una visione problematizzante capace di distinguere tra le diversità culturali che si presentano come risorsa (in quanto si pongono in una prospettiva di apertura e sufficiente compatibilità con la società in cui approdano) e quelle che si manifestano come problema (in quanto rivelano vari tratti di incompatibilità radicale e sottendono esclusivismi e chiusure tradizionaliste poco disposte all’ibridazione, al mutamento e più orientate a sostituirsi ai valori occidentali che a riconoscerli). In questo senso penso che il concetto di Ius culturae possa essere recuperabile, senza screditarlo nell’idea che esso fomenterebbe una visione essenzialista della cultura nazionale cristallizzandola come identitarismo, per coniugarlo invece come onere di riconoscimento di una serie elementare e aperta di valori non negoziabili, radi ma fondamentali, al fine dell’ottenimento della cittadinanza.
Riguardo i limiti economici è il caso di notare che il tema dell’accoglienza dei migranti è diventato il topos principale in cui si esprime la questione cruciale della lotta alle diseguaglianze umane su un piano globale; ciò proprio nell’idea che una fondamentale soluzione ai mali del nostro tempo sarebbe data dall’inclusione delle persone migranti attraverso il conferimento della cittadinanza. Sarebbe bello se si potesse risolvere la povertà del mondo facendo diventare i quattro e più miliardi di poveri del mondo tutti cittadini dei Paesi ricchi, e dando a tutti un reddito universale di cittadinanza; ma non è così, poiché la ricchezza complessiva non sarebbe sufficiente ai fini di tale redistribuzione; non potrebbe tradursi in risorse sufficienti a portare tutti a un livello di eguaglianza immaginato a partire da standard occidentali di benessere medio.
E se le migrazioni non possono risolvere i problemi di povertà del Sud del mondo, c’è anche la possibilità che flussi migratori incontrollati peggiorino le condizioni economiche del Nord del mondo. Visto che l’ottenimento (o il rifiuto) della cittadinanza significa accesso a (o negazione di) diritti che permettono la possibilità individuale del godimento di risorse materiali, dato che queste risorse sono limitate, dato che derivano da tecnologie ecologicamente poco sostenibili, e che da decenni il pianeta sopporta un aumento demografico medio di ottanta milioni di persone ogni anno prevalentemente dai Paesi del Sud del mondo, andrebbe chiarito che il proposito etico e umanitario espresso dallo slogan “più migranti e più diritti, più accoglienza e più cittadinanza” risulta poco realizzabile da un punto di vista economico e ecologico; e che, al contrario, spesso nella realtà “più migranti” può significare comprovatamente “meno diritti” (Ruhs 2015).
Questo vuol dire che ad oggi gl’ideali di cittadinanza universale hic et nunc sottendono trasfigurazioni di un mito della disponibilità illimitata di risorse, un archetipo edenico di benessere universale che nella storia ha assunto varie forme chimeriche, spesso rivelatesi rischiose oltre che illusorie se immaginate al di là degli stimoli asintotici di emancipazione che incarnano. Se non si curano le fonti della diseguaglianza, comprendendo che non dipendono solo dall’esclusivismo e dalla predazione coloniale dei Paesi ricchi ma anche da problemi di arretratezza, corruzione e crescita demografica dei Paesi poveri, non resta che accontentarci a breve termine con l’esercizio intellettuale dato dal blaming dell’incolpare i sovranisti, le destre, i fascisti per l’impossibilità di approdare a un mondo migliore.
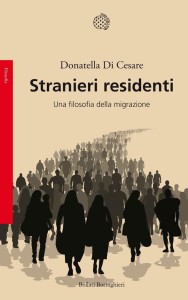 Logiche e dialettiche del coabitare
Logiche e dialettiche del coabitare
Torno, infine, alla questione del nesso tra persone e luoghi, al punto cardinale che riguarda proprio il rapporto, l’equilibrio tra il tutelare i luoghi dall’ostilità delle persone versus il tutelare le persone dall’ostilità dei luoghi. Specifico da subito che, a mio parere, si tratta di princìpi che dovrebbero in qualche modo convivere; questo anche nell’idea di una priorità della vita delle persone rispetto alla qualità dei luoghi ma nella consapevolezza che tale priorità non può essere assoluta, senza che degeneri nel rischio retroattivo di autoannullare i propositi etici con cui si presenta.
Sappiamo oggi che, in ultima analisi, l’aver messo unidirezionalmente il luogo prima delle persone è stata la condizione ideologica essenziale che ha storicamente portato al nazismo. Vale a dire che il nazismo è stato il punto di arrivo di una concezione del politico affermatasi come cifra della modernità, incardinata all’idea centrale della negatività dello straniero rispetto alla immaginata omogeneità della nazione. Questo ha legittimato un diritto di ostilità nei confronti dello straniero che veniva generalizzato come minaccia, delineando così un percorso tanatopolitico che ha portato la Germania, l’Europa e l’umanità di fronte all’inferno dei campi di sterminio. In merito Donatella Di Cesare identifica la xenofobia e il razzismo proprio con la pretesa incondizionata di ritenere «legittimo decidere con chi coabitare», inquadrando come gesto discriminatorio di derivazione nazista la richiesta identitaria di rivendicare il luogo esclusivamente per sé (Di Cesare 2017).
A questo punto, l’antirazzismo, la condizione imprescindibile per poter dirci umani, si delinea per antitesi nella sola possibilità di accettare genericamente e assolutamente l’altro; si definisce nell’accogliere tutti e nel rinunciare completamente a qualsiasi diritto sul suolo. Ricorrendo ai termini di Roberto Esposito, si può dire che l’assolutizzazione nazista dell’immunitas totale dall’altro viene rovesciata nel contrario della communitas totale con l’altro, ci dice ancora Di Cesare, in un dovere incondizionato di «far posto agli altri» che si configura pertanto come severa conditio sine qua non dell’antirazzismo. Il tutto in una posizione immigrazionista di rovesciamento postmoderno dei valori politici sovranisti che sono stati predominanti nella modernità: una rivoluzione nel pieno senso etimologico del termine, la quale, in piena linea con il canone della critica postcoloniale, inverte il valore assoluto della difesa dei confini nel valore assoluto del loro abbattimento, e sostituisce al valore assoluto dell’identità nazionale quello dell’alterità migrante e della diversità globale. Questo sancisce un dovere assoluto di accoglienza nei confronti del migrante, nell’implicazione della sua generalizzazione come risorsa, come diversità che non fa altro che arricchire.
A mio parere il problema di questo rovesciamento è che l’inversione tra le parti suggerisce di lasciare intatta una relazione di fondo inscritta in un’assiologia che resta manichea; in tal senso il rischio è quello di passare dalla demonizzazione (di matrice nazista) del nomadismo, della migrazione, dell’erranza, dell’alterità alla demonizzazione (di matrice immigrazionista) della stanzialità, dell’appartenenza, della permanenza, dell’identità. Si invertono i poli di una visione che seguita a essere incentrata su un dualismo tra bene e male, che non esce dalla tentazione del cercare un nemico assoluto e seguita a consegnare alla morale un capro espiatorio, limitandosi a presentarlo capovolgendo le posizioni. Inoltre, una simile impostazione assolutista sottende che l’altro debba essere sempre e necessariamente positivo, escludendo in linea di principio l’eventualità dell’estraneità ostile del migrante: se per i nazisti l’altro era sempre e solo nemico (hostis) questo dispositivo d’inversione suppone che l’altro sia sempre e solo ospite (hospes). Questa imposizione binaria generalizzante vieta di distinguere nemici da amici, rovescia il “tutti nemici (da eliminare)” in “tutti amici (da accogliere)”; e così facendo espone, in ultima analisi, al rischio del nazismo dell’altro (Ciccozzi 2021). Il nazismo, il fascismo, l’autoritarismo dell’altro si manifestano sotto forma di sentimenti e progetti diffusi in modo sfocato in vari luoghi del mondo; sentimenti di odio antioccidentale e razzismo antibianco, progetti di dominio in una stagione in cui il vecchio e cadente imperialismo occidentale pare non accorgersi di essere circondato da imperialismi emergenti. Sarebbe paranoico temere che questi sentimenti e progetti riguardino tutti i migranti ma sarebbe altrettanto ingenuo non accorgersi che di essi alcuni migranti sono sostenitori più o meno passivi o addirittura portatori attivi, anche attraverso pratiche eliminazionistiche di tipo terroristico apertamente dichiarate come tali, che troppo spesso da una prospettiva progressista ci ostiniamo a non inquadrare come espressioni particolari di un progetto implicito generale.
Esplicitando la questione in termini di logica aristotelica, penso che, per evitare il rischio paradossale di nazismi di ritorno, l’opposizione al nazismo non dovrebbe riguardare solo la qualità del giudizio (passando da un giudizio negativo a uno positivo) ma anche la quantità del giudizio (passando da un giudizio universale a uno particolare). L’universale negativa di matrice nazista (nessuno può essere accettato) dovrebbe essere sostituita non da una universale positiva (tutti dovrebbero essere accettati) ma da una particolare positiva (qualcuno può essere accettato). Questo in quanto il miglior modo per opporsi all’universale negativa dei nazisti non credo che derivi dall’adottare il giudizio contrario al loro giudizio universale negativo (l’universale positiva dell’accettare tutti, tipica dell’immigrazionismo); ma venga dall’adottare il giudizio contraddittorio, ossia la particolare positiva dell’accettare qualcuno, rifiutando di conseguenza qualcun altro.
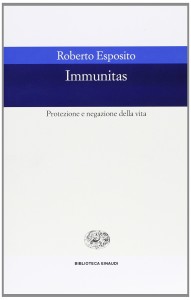 Guardando la questione da un punto di vista diacronico in termini di dialettica hegeliana tutto ciò vuol dire che il rovesciamento della tesi moderna della difesa assoluta del noi nell’antitesi postmoderna della difesa assoluta dell’altro dovrebbe condurre a una sintesi in cui ci si fa carico di una dialettica tra identità e alterità che sappia negoziare tra una difesa circostanziata dell’altro (dal noi ostile all’altro) in relazione alla possibilità di una difesa circostanziata del noi (dall’altro ostile al noi); il tutto eventualmente fino alla dissoluzione di queste opposizioni in sfumature sempre più flebili, ma non prima che tale dissoluzione abbia portato all’insignificanza l’altrui ostilità insieme alla nostra.
Guardando la questione da un punto di vista diacronico in termini di dialettica hegeliana tutto ciò vuol dire che il rovesciamento della tesi moderna della difesa assoluta del noi nell’antitesi postmoderna della difesa assoluta dell’altro dovrebbe condurre a una sintesi in cui ci si fa carico di una dialettica tra identità e alterità che sappia negoziare tra una difesa circostanziata dell’altro (dal noi ostile all’altro) in relazione alla possibilità di una difesa circostanziata del noi (dall’altro ostile al noi); il tutto eventualmente fino alla dissoluzione di queste opposizioni in sfumature sempre più flebili, ma non prima che tale dissoluzione abbia portato all’insignificanza l’altrui ostilità insieme alla nostra.
Prima che questo ideale momento di avvicinamento asintotico verso un piano di communitas universale arrivi al punto di poterci far abbracciare tutti ecumenicamente in quanto umani a ragione liberi dalla paura di istinti immunitari, la preferibilità di logiche particolari in luogo di generalizzazioni universali riflette la ragionevole assunzione che, in quanto umano come noi, l’altro è ambivalentemente sia positivo che negativo (come possibile portatore di una sua xenofobia verso la società in cui approda). Da ciò le posizioni che implicano i due universali del rifiuto assoluto dell’altro (il nazismo) o al contrario della sua assoluta accettazione (l’immigrazionismo) risultano entrambe logicamente poco solide, rivelando viceversa la consistenza delle posizioni contraddittorie in cui l’universale particolare dell’apertura o chiusura all’altro si risolve pragmaticamente proprio in funzione dell’ambivalenza dell’altro, ossia del suo poter essere positivo o negativo, hospes o hostis.
Questo riconoscimento dell’eventualità dell’estraneità ostile dello straniero non va inteso come pretesto per rimettersi a costruire muri, ma come precauzione propedeutica ad un’accoglienza senza ingenuità, che non si accorge che sui ponti possono passare costruttori di muri altrui che andrebbero fermati. Va inteso come consapevolezza che consenta la possibilità di negoziare un disarmo delle incrostazioni identitariste, che sia non solo orientato unilateralmente allo smantellamento dei fascismi e della xenofobia occidentale ma multilateralmente aperto anche a riconoscere e combattere i fascismi e la xenofobia altrui, quelli rivolti contro l’Occidente. Il rischio è quello di uno scenario per cui, se il nazismo era annientamento dell’altro, questo antinazismo immigrazionista ottenuto per rovesciamento polare diventi una forma di nazismo paradossale, di annientamento del noi: come autoannientamento generale del noi per l’altro o come annientamento particolare del nostro noi da parte dell’altro, per il suo noi. Il tutto in un effetto perverso in cui la nostra rinuncia al possesso esclusivo del luogo rischia di essere propedeutica a processi di impossessamento esclusivo da parte di altri. D’altronde, anche lo straniero che impone la sua presenza senza negoziarla con il residente a ben vedere rivendica la legittimità di decidere con chi coabitare in totale autonomia dal suo altro, il residente ( e in questo modo rivela allora un suo razzismo orientato al non riconoscimento dei residenti). Se si decidesse di guardare seriamente e senza bias politico-ideologici alle varie no go zones che nascono in Occidente, si capirebbe che il rischio in questione non è solo teorico.
Il problema è che il rassicurazionismo immigrazionista, rappresentando l’alterità migrante solo e unicamente come diversità che arricchisce, inibisce dalla possibilità di considerare la questione migratoria anche come orizzonte di rischio; e lo fa per riflesso pavloviano di opposizione all’allarmismo sovranista che ha ereditato dal nazismo il vizio di vedere nel migrante null’altro che un oggetto di rischio. In tal modo il posizionamento in antonimia rispetto all’alterità interna (il fascista, razzista sovranista) va a dominare le modalità di attribuzione di senso alla questione migratoria. Tutto in un dispositivo di proiezione dove, per non correre il rischio di contaminazione culturale dato da qualsiasi associabilità parziale ai razzisti, non si è mai disposti a ritenere concepibile che il negativo possa venire dalle migrazioni: in questi casi scatta la profilassi della cultural blindness e il migrante che porta violenza smette di essere migrante, ma viene trasformato in folle, marginalizzato e la causa della violenza è attribuita alle destre che impediscono l’integrazione.
Non è contemplata l’eventualità che la violenza che esprimono alcuni migranti possa essere non solo una reazione difensiva alla violenza che subiscono ma anche una azione aggressiva culturalmente connotata, e possa essere a volte anche espressione di una loro xenofobia rivolta a noi, di un loro razzismo, di un loro odio antioccidentale, di un loro imperialismo, per quanto più o meno spontaneo, informale, rizomatico. Dovrebbe essere chiaro che il fascismo non è solo una caratteristica storica esclusiva di parte dell’Occidente ma, come «ur-fascismo» (Eco 2016), è essenza politica generale che si manifesta in forme plurali, che può emergere a macchia di leopardo in ogni epoca storica e in ogni luogo del pianeta. In questo senso penso che, almeno in linea di principio, il limite del riconoscimento della cittadinanza stia nel fascismo, anche in quello altrui; vale a dire che se i fascisti non riconoscono in generale il diritto della cittadinanza all’altro, in particolare bisognerebbe riconoscere il diritto di cittadinanza fermandosi al limite dell’alterità fascista, interna ed esterna. Questo sempre nell’idea che, se i confini vanno abbattuti, è poco prudente pensare di abbatterli tutti e subito.
Dialoghi Mediterranei, n. 52, novembre 2021
Riferimenti bibliografici
Augé, M., 1993, Nonluoghi, Milano, Eleuthera.
Bateson, G., 1977, Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi.
Butler, J., 2013, A chi spetta una buona vita?, Roma, Nottetempo.
Ciccozzi, A., 2014, “Interculturalità, critica postcoloniale, immigrazionismo”, Humanitas, n°4-5, a cura di, D’Anna, G. – Santasilia, S., Brescia, Morcelliana.
Ciccozzi, A., 2016 “Dislivelli di cultura e razzismi a Castel Volturno”, Migranti africani di Castel Volturno, a cura di Petrarca V., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
Ciccozzi, A., 2021, “Il rischio dei muri degli altri. Cirese, dislivelli di cultura e rimossi antropologici”, Dialoghi Mediterranei, n. 50, luglio, Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo, https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-rischio-dei-muri-degli-altri-cirese-dislivelli-di-cultura-e-rimossi-antropologici/.
Collier, P., 2015, Exodus. I tabù dell’immigrazione, Roma-Bari, Laterza.
Dal Lago, A., 2012, Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Milano, Feltrinelli.
Di Cesare, D., 2017, Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione, Torino, Bollati Boringhieri.
Eco, U., 1994, Trattato di semiotica generale, Milano, Bompiani.
Eco, U., 2016, Cinque scritti morali, Milano, Rizzoli.
Esposito, R., 1998, Communitas: Origine e destino della comunità, Torino, Einaudi.
Esposito, R., 2002, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Torino, Einaudi.
Esposito, R., 2018, Termini della Politica. I. Comunità, immunità, biopolitica, Milano-Udine, Mimesis.
Kassam, K., 2017, No Go Zones: How Sharia Law Is Coming to a Neighborhood Near You, Washington, RegneryPublishing.
Manconi, L., Brinis, V., 2013, Accogliamoli tutti. Una ragionevole proposta per salvare l’Italia, gli italiani e gli immigrati, Prefazione di Cécile Kyenge, Milano, Il Saggiatore.
Putnam, R., 2007, “E Pluribus Unum: diversity and community in the 21st century”, in Scandinavian Political Sudies, 30(2): 137-174.
Ruhs, M., 2015, The Price of Rights: Regulating International Labor Migration, Princeton, Princeton University Press.
Weiner, M.S., 2011, The rule of the clan, New York, Farrar, Straus and Giroux.
_____________________________________________________________
Antonello Ciccozzi, è professore associato di Antropologia culturale presso Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila. Si è laureato con una tesi sulla teoria ciresiana dei dislivelli di cultura. S’interessa dei processi di rappresentazione sociale della diversità culturale, di causalità culturale in ambito giuridico, di antropologia del rischio, dell’abitare, delle istituzioni, della scienza, delle migrazioni. Ha svolto ricerche etnografiche nell’Appennino rurale, in contesti di marginalità giovanile urbana, in ambito post-sismico, in luoghi di lavoro precario dei migranti.
______________________________________________________________









