dialoghi intorno al virus
di Antonino Cusumano
28 marzo
Scrivo mentre fuori dalla finestra infuria la tempesta del virus e quanti sono costretti a restare in casa si interrogano se stiamo vivendo un’esperienza – unica, epocale e drammatica – o piuttosto un esperimento distopico, il durissimo banco di prova che sfida, con l’irruzione del più piccolo essere dell’universo, il mondo ordinato e organizzato delle nostre consuetudini, dei nostri paradigmi, dei nostri progetti. Tutto quel che pensavamo fosse l’ordine naturale delle cose. Non sappiamo se le città, improvvisamente precipitate nella infinita notte del coronavirus, svuotate di voci e di presenze umane, di corpi e di anime vive, trasformate in immensi onirici ‘non luoghi’, siano parte di uno scenario futuribile che prepara catastrofi e apocalissi ovvero rinascimenti e rifondazioni. Certe letture biopolitiche si spingono a ipotizzare improbabili disegni cospiratori, occulti e paranoici complotti, millenarismi postmoderni, escatologie metastoriche o metafisiche.
A guardar bene, però, la potenza virale dell’invisibile e dell’imprevedibile ha messo in crisi la nostra onnipotenza tecnologica, le dittature del Pil e del consumo, la nostra vita sociale, il calendario quotidiano del tempo. Un tempo sospeso, come quello dell’infanzia, senza più la misura segnata sul quadrante dell’orologio, senza più la cesura tra feriale e festivo. Ma un tempo forse anche ritrovato, nel rallentamento dei ritmi, nella dilatazione delle ore e delle giornate in cui non occorrono più – ricordando i versi di Montale – «le coincidenze, le prenotazioni, /le trappole, gli scorni di chi crede/ che la realtà sia quella che si vede». Un beffardo contrappasso sembra volere arrestare le nostre corse affannose, rimuovendo abitudini strutturate, gli habitus dei nostri gesti irriflessi, cancellando in un sol colpo le mille scadenze delle nostre agende affollate.
Mi ritrovo a gestire l’illusione di aver guadagnato tempo per leggere, studiare, scrivere. Ma è tempo non dato bensì obbligato e nel grande vuoto della vertigine che si spalanca inaspettato e inquietante mi accorgo che qualcosa si è inceppato anche nei meccanismi dei bioritmi della mente, nella capacità di concentrazione, negli equilibri tra veglia e sonno. Si può forse sfuggire alle cronache che incalzano, ai reiterati bollettini di guerra che ogni giorno producono drammatiche statistiche, macabri rosari di contagiati, di deceduti, di percentuali? Di salvati e di sommersi? Si può restare estranei all’ansiogena e kafkiana attesa dell’inimmaginabile e dell’imponderabile? E in questo innaturale contesto si possono leggere le pagine di un libro, si può organizzare il pensiero in un testo, senza alzare la testa e guardare fuori dalla finestra, senza restare paralizzati dall’immobilità dell’aria, dalla maestà del raggelante silenzio? L’impotenza prodotta dalla forma anomica dell’epidemia è forse il segno che identifica con qualche approssimazione la condizione di spaesamento e di smarrimento nelle secche della quarantena in cui siamo stati gettati.
Tramortito dai numeri e dalle curve dei contagi, dallo sciame di grafici e tabelle che oscurano le vite e le identità degli uomini e delle donne trafitti dal virus, leggo dei morti senza funerali, della solitudine dei defunti e dei loro cari che non possono avvicinarli e salutarli. Non c’è ingiustizia più profonda che si possa consumare del lutto negato e mortificato, sottratto alla pietà dell’ultimo rito, quello del congedo e del compianto. La civiltà di tutte le culture è fondata su quel culto che tiene insieme i vivi e i morti ma rischia di tradire le sue origini nella crescente tendenza a nascondere la morte, a obliterare il cordoglio, a dimenticare i morti, che oggi lo stato d’eccezione riduce a numeri, a salme da contabilizzare nel bilancio e da smaltire nel forno crematorio più vicino. Un destino assimilabile per certi aspetti a quello dei migranti spariti senza nome e senza storia nelle foibe e nell’ecatombe del Mediterraneo. Le vite nude inghiottite dalla nuda morte.
Se davanti alle necessità di ordine politico e sanitario sono travolti o rimossi i codici valoriali e simbolici costitutivi del nostro sistema di convivenza civile e culturale, se sono soffocate o minacciate le stesse ragioni fondanti dell’animale sociale da cui muove la filogenesi della specie umana fino alla militarizzazione delle relazioni e delle azioni, c’è da interrogarsi sulla profondità e irreversibilità della crisi culturale, sugli effetti di lunga durata che produrrà questo fenomeno solo apparentemente emergenziale e in realtà connesso e incistato al modello di sviluppo e agli stili di vita contemporanea, alla dissennata entropia che divora spazi e risorse, agli “ecocidi” di cui ha scritto Jeremy Rifkin, al nostro modo di vivere, di declinare e di abitare la globalizzazione. Globale è il virus che non conosce frontiere geografiche né differenze di genere o di classe, di lingua o di religione. Planetaria è la pandemia, non soltanto un blow up che riguarda la salute pubblica, un evento traumatico che sconvolge le vite e i destini individuali, ma piuttosto una hybris antropologica, sindrome della vulnerabilità dell’antropocentrismo, della fragilità dei primati produttivistici, delle insufficienze del potere scientifico, della parzialità dell’ordine economico che abbiamo pensato universale.
Dai limiti delle risorse e dei mezzi sanitari sull’orlo del collasso, dalla destabilizzazione di ogni forma di sicurezza e garanzia esistenziale, dalla paralisi di tutte le attività e mobilità si aprono tuttavia epifaniche vie alla immaginazione di nuovi scenari, di inedite prospettive, di altri mondi possibili. Si può ripensare ai prezzi che abbiamo pagato per qualche comodità in più o per qualche fatica in meno. Nella dimensione domestica a cui siamo costretti si possono riscoprire le bellezze del quotidiano, la nostalgia dell’abbraccio proibito, della carezza non data, le parole perdute della cura degli altri, i luoghi abbandonati e le piccole cose dimenticate. L’amico poeta Sebastiano Burgaretta mi ha mandato pochi giorni fa questi versi: «Flebile la luce dei giorni/ accesi per un dono di natura. /Ora sappiamo quanto poco/basta a spegnerla del tutto./ L’avevamo dimenticato nel tempo/andato dell’imbelle sarabanda». Mi sembra che diano un orizzonte di senso a questi nostri giorni insensati.
La letteratura – si sa – è invenzione più vera della verità fattuale, lo sguardo spesso più alto e profetico sui gesti e le azioni degli uomini in carne ossa, sulle loro più intime storie di vita. Della trama dei fatti storici rende visibili, come per effetto di una lente di ingrandimento, i fili sottili dell’ordito invisibile e impercettibile. A rileggere le pagine degli scrittori le narrazioni di pestilenze – reali o metaforiche – ritroviamo gli affanni e le arcaiche paure che viviamo oggi, le reciproche sorveglianze che rendono sospetti il fratello al fratello, il fantasma immunitario che esalta le primordiali fobie del contatto e del conseguente contagio, le credenze visionarie e superstiziose e le rovinose pratiche della caccia all’untore, le speculazioni degli sciacalli di turno e l’assalto ai “forni”, le ingegnose forme di resistenza e le creative invenzioni di solidarietà, i reiterati decreti e i diversi tentativi di esorcizzare il nemico, di addomesticare l’ignoto.
Il racconto dell’Italia afflitta dalla peste, da Boccaccio a Manzoni, restituisce qualcosa del confuso evolversi della cronaca degli avvenimenti attuali: le brigate e il diletto del novellare tra le mura familiari, al riparo dall’assalto della malattia e della morte, «l’idea del venefizio e del malefizio» secondo i disegni divini – «la crudeltà del cielo e forse in parte quella degli uomini», «i molti infermi mal serviti o abbandonati ne’ loro bisogni per la paura c’aveono i sani» –, i lazzaretti e la loro tragica espansione, i lanzichenecchi quali capri espiatori, le contraddittorie “grida” delle autorità, hanno oggi altri nomi, altri soggetti, altri contesti, ma sono ancora tra di noi, nelle nostre giornate di quarantena, e la letteratura ci aiuta a riconoscerli. Sappiamo che «l’itala gente dalle molte vite» di carducciana memoria rivela nelle calamità più drammatiche i diversi profili della sua plurima identità, l’indole complessa e i molteplici costumi. Così, nelle settimane in cui scriviamo, alle canzoni ai balconi e ai balli sulle terrazze per “stringere a coorte” gli animi degli italiani si sono accompagnate la borsa nera delle mascherine e le speculazioni dei profittatori di guerra; alla generosa corsa dei medici e degli infermieri volontari che hanno risposto in massa agli appelli lanciati dal governo si è alternata l’occhiuta ricerca degli untori identificati prima nei cinesi insediati nel nostro Paese e poi nei giovani fuggitivi che dal nord tornano al sud, immaginato – nonostante tutto – come asilo e rifugio destinato ad accogliere i figli della diaspora.
Quale Italia raccontano quei flash-mob ai balconi, i tricolori sventolati, le torce accese, i cori improvvisati, gli applausi agli operatori sanitari? Il fragore che rompe il silenzio, il canto che sconfigge l’afasia della solitudine, l’appuntamento fissato sui social che surroga la socialità perduta, che invoca la comunità ritrovata, la ricerca di figure eroiche e salvifiche da celebrare sull’altare di un rinnovato sentimento dell’italianità. L’Italia – con l’enfasi della retorica o con l’afflato solidale ad una comunità forse più “immaginata” che reale – sembra riscoprire l’unità nazionale come antidoto a certo egoistico ostracismo dei Paesi d’oltralpe, ma poi torna a dividersi istituendo nuove frontiere tra regione e regione nella strenua difesa dal contagio, nella confusa mischia dei conflitti di poteri e di sovranità territoriali. Da qui le dense implicazioni di carattere antropologico: la lezione demartiniana della “crisi della presenza” attualizzata in un momento storico di estrema fragilità psicologica collettiva, gli slittamenti delle categorie puro/impuro dal piano epidemiologico a quello sociale e morale, il ritrovato “spirito del dono” incorporato negli “angeli degli ospedali” e nelle sfide di solidarietà e di vicinanza emotiva, le fantasiose forme di agency nelle tattiche popolari di uso del tempo e dello spazio.
A Palermo in preparazione della festa di san Giuseppe si sono accesi come sempre i tradizionali roghi nelle piazze e negli slarghi dei quartieri popolari, nonostante i rigorosi divieti e le restrizioni imposte dalla particolare congiuntura. Le vampe appartengono ad arcaici riti di catarsi e purificazione, sciolgono voti contratti col santo, segnano i confini spaziali e le scansioni temporali della festa, riaffermano bisogni di garanzie e di rigenerazione. Trasgressioni da sempre e inutilmente contrastate dalle forze dell’ordine e oggi, nelle drammatiche circostanze di angoscia esistenziale e di insicurezza collettiva, ostinatamente ribadite con più forza simbolica e fattuale nonostante i rischi sanitari. Intemperanze che nella violazione dei divieti in osservanza alla tradizione ripropongono la questione delle tensioni e delle conflittualità nei rapporti tra alcuni costumi e pratiche della cultura popolare e determinate prescrizioni di legge, tra usi empirici e saperi scientifici.
Una delle disposizioni restrittive imposte dal governo da alcuni contestata in Sicilia è stata pure la chiusura dei botteghini del lotto e dei centri scommesse, frequentati per lo più da quella popolazione meno abbiente che dal gioco con i numeri trae ragioni di speranza e di fiducia nel futuro. Un rito antico che risale alle arti della divinazione, una abitudine diffusa e sostenuta dall’idea di rovesciare la sorte e vagheggiare fortune e ricchezze prodigiose pur contro ogni logica matematica di probabilità di vincita. Anche in questo caso sembrano scontrarsi due ordini di realtà, due mondi: quello esemplato sulle norme delle istituzioni pubbliche e quello governato dai dispositivi mitico-simbolici della cultura folklorica. Che non siano sopravvivenze affatto residuali ma vitali testimonianze di credenze intimamente connesse al culto dei morti è dimostrato dalle difficoltà e resistenze opposte alla loro modifica e rimozione.
Nella lunga “quarantena” che coincide con una quaresima senza pasqua il coronavirus è stato causa di una sorta di ripiegamento penitenziale e di una clamorosa irreggimentazione disciplinare, con i corpi sottratti ai loro gesti naturali (toccarsi, accarezzarsi, abbracciarsi, salutarsi con una stretta di mano) e i visi coperti da una mascherina che ne modifica non solo l’aspetto ma l’espressione, la riconoscibilità. Anche la proposizione incessantemente replicata come a popolazione infantilizzata: “io resto a casa”, è stata preghiera, litania, formula magica, slogan ossessivo e conativo, che nella quotidiana iterazione in tutti i media assume la funzione di amuleto apotropaico, di scongiuro che fa leva sulla paura di restare soli per esorcizzare le paure del contagio. Propiziatorio è invece il messaggio affidato alle parole “Andrà tutto bene” dentro il disegno infantile di un arcobaleno esposto in ogni luogo come a disseminare il bisogno di protezione degli spazi e l’augurio di una speranza. Ex voto rilanciati nella rete digitale per una grazia di salvezza da ricevere.
Mai forse come in questo paesaggio frantumato e in questo passaggio critico i social media hanno avuto un ruolo essenziale e centrale di cerniera, di collante, per molti giovani di cosmos e logos in un orizzonte di intensi traffici e compulsive dinamiche. Non solo tecnicamente e concretamente sussidiario della socialità assente o limitata, ma anche umanamente e culturalmente vitale nella comunicazione tra generazioni, nella partecipazione e condivisione delle esperienze e delle percezioni, nella loro rappresentazione e rielaborazione anche ludica e creativa, nel ricorso allo smart working e alle lezioni a distanza, e perfino nella fruizione dei riti religiosi. In ogni caso, assicurare il contatto (video/audio) senza rischiare di essere contagiati offre la possibilità di essere rassicurati, di “fare comunità” nella diaspora provocata dall’isolamento forzato, di promuovere interazioni nuove, di connettere idee, energie, risorse, emozioni, immaginazioni.
Con la stessa velocità di diffusione del coronavirus, corrono sui social le informazioni ma anche le fake news, impazza il virus inestinguibile dei rancori privati e degli odi politici, delle allusioni e delle maldicenze, delle violenze verbali e razziali. Non si fermano dunque nel dibattito pubblico gli attacchi alle Ong, ai migranti, agli stranieri, le critiche a chi li soccorre. Ma circolano anche infondate tesi antiscientifiche, strampalate ideologie negazioniste e formidabili collezioni di luoghi comuni. La permanenza obbligata tra le pareti domestiche e l’immersione prolungata nella saturazione tecnologica dei media sembrano, talvolta, produrre non solo casi di depressioni e disturbi psichici ma anche un’esasperazione dei toni nelle comunicazioni, l’allentamento dei freni inibitori, l’inasprimento perverso di cinismi e discriminazioni. Prevalgono tuttavia le funzioni socializzanti e rassicuranti esercitate dai reticoli delle communities costruite online, dal momento che nell’isolamento e nel distanziamento dall’Altro la privazione delle relazioni offline ne accresce il desiderio e il bisogno.
 Tra i libri che ho letto in questi giorni di “quarantena” quello di Marco Aime, Comunità (Il Mulino 2019), dialoga in evidente consonanza con lo speciale sentimento del tempo che stiamo vivendo. Quanta più è rarefatta la socialità, quanto più avanzato e cogente il processo di costrizione alla separazione, tanto più forte appare l’investimento simbolico sui legami – materiali e immateriali – che tengono insieme l’idea di comunità, l’orgoglio di appartenenza, la dimensione collettiva dell’interdipendenza. «Le comunità – scrive Aime – sono in gran parte immaginate, e la nazione più di altre, ma tutte hanno bisogno, in qualche momento, di essere reificate, per essere percepite nella loro esistenza reale» (Aime 2019: 42). Tanto più in un tempo in cui il lavoro e la scuola – due luoghi sociali deputati alla legittimazione civile e alla formazione culturale dell’italianità – sono interdetti e sospesi, il concetto di comunità assume istanze ideali e sovrastrutturali di particolare rilevanza, essendo percepito e vissuto come presidio d’identità, baluardo di sicurezza, edenico asilo. «Un cerchio caldo» secondo l’analista svedese Göra Rosenberg. La minaccia del virus ci fa scoprire che le nostre vite sono indissolubilmente legate da relazioni di mutua dipendenza, impigliate in una rete di comuni e reciproche responsabilità. L’astrazione si fa concreta esperienza, diventa necessità, s’incarna in forme inedite di ritualità, nelle nuove possibili riarticolazioni tra locale e globale.
Tra i libri che ho letto in questi giorni di “quarantena” quello di Marco Aime, Comunità (Il Mulino 2019), dialoga in evidente consonanza con lo speciale sentimento del tempo che stiamo vivendo. Quanta più è rarefatta la socialità, quanto più avanzato e cogente il processo di costrizione alla separazione, tanto più forte appare l’investimento simbolico sui legami – materiali e immateriali – che tengono insieme l’idea di comunità, l’orgoglio di appartenenza, la dimensione collettiva dell’interdipendenza. «Le comunità – scrive Aime – sono in gran parte immaginate, e la nazione più di altre, ma tutte hanno bisogno, in qualche momento, di essere reificate, per essere percepite nella loro esistenza reale» (Aime 2019: 42). Tanto più in un tempo in cui il lavoro e la scuola – due luoghi sociali deputati alla legittimazione civile e alla formazione culturale dell’italianità – sono interdetti e sospesi, il concetto di comunità assume istanze ideali e sovrastrutturali di particolare rilevanza, essendo percepito e vissuto come presidio d’identità, baluardo di sicurezza, edenico asilo. «Un cerchio caldo» secondo l’analista svedese Göra Rosenberg. La minaccia del virus ci fa scoprire che le nostre vite sono indissolubilmente legate da relazioni di mutua dipendenza, impigliate in una rete di comuni e reciproche responsabilità. L’astrazione si fa concreta esperienza, diventa necessità, s’incarna in forme inedite di ritualità, nelle nuove possibili riarticolazioni tra locale e globale.
Mentre scrivo si moltiplicano sui social gli appelli all’orgoglio nazionale, le immagini che esaltano la bellezza del nostro Paese, la storia illustre delle nostre città, le risorse infinite del genio italico. Ma se nella rappresentazione online prevale la retorica, un po’ ingenuamente romantica, un po’ intenzionalmente patriottarda, nella prassi, fuori dalla Rete e al di là del balcone, è attiva spesso senza mostrarsi la sollecitudine per gli altri, la ricerca della prossimità, la cura di quella solidarietà che Stefano Rodotà definì: «un’utopia necessaria». È il mondo del volontariato che in un contesto di generale sgomento e di dolorose solitudini restituisce il vero significato a quella parola a lungo proscritta o confusa nella dimensione puramente caritatevole. Forse la più grande lezione ispirata dalla particolare temporanea limitazione delle libertà individuali è propria quella di sporgersi oltre la bolla dell’individualismo inteso come trincea a difesa dell’immunità dal contagio, oltre l’orizzonte dell’utilità personale, nella consapevolezza che è bene comune la responsabilità che tiene insieme la società, la relazione che ha valore per sé stessa ed è fondamento umano della comunità. Cosa sarebbe, del resto, ciò che chiamiamo cultura senza la vita associata, la prossimità, i nodi e i reticoli di gruppo, il tessuto connettivo della mobilità e della socialità?
Richiamando il valore antropologico del dono Marco Aime scrive che «ciò che spinge a donare è la volontà degli uomini di creare rapporti sociali, perché l’uomo non si accontenta di vivere nella società e di replicarla come gli altri animali sociali, ma deve produrre la società in cui vive» (Aime 2019: 82). La condivisione di una medesima condizione di rischi e di privazione dei diritti di circolazione e di contatto fisico, l’obbligazione civica e morale prima che normativa e giuridica di restare a casa in nome dell’onere della salute degli altri e in funzione del contenimento del fenomeno di diffusione del virus, descrivono la tessitura dei legami di evidente reciprocità e di stretta interdipendenza, un intreccio inestricabile che sfida i confini e le logiche della separatezza. C’è qualcosa di religioso nell’atto richiesto dalle istituzioni e compiuto dalla popolazione, qualcosa che assimila la penitenza dei corpi ristretti nel domicilio al rito di un metaforico sacrificio fondato sullo scambio tra l’offerta materiale e il bene spirituale, tra la temporanea sottrazione della libertà individuale e la salvezza della vita collettiva. Una durkheimiana affermazione del primato della società, della legge superiore della comunità. Un rito di passaggio che nella mitologia sottotraccia dovrebbe assicurarci la liberazione dal coronavirus, la purificazione immunitaria attraverso l’espiazione domiciliare.
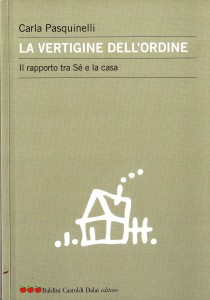 La casa in questa narrazione è il luogo centrale che salva e protegge, lo spazio liminare che custodisce l’ordine con il quale colonizziamo il mondo, il riparo materno in cui si radica la territorialità dell’esistere e dell’abitare, il confine che separa il noto dall’ignoto, il domestico dal selvatico, la vita dalla morte. Di qua il genius loci, lo spirito tutelare, di là il caos, l’irruzione del virus. In queste giornate di disordine esistenziale vale la pena riprendere in mano il libro di Carla Pasquinelli, La vertigine dell’ordine (Baldini Castoldi 2014), per ritrovare tra le pareti della casa la quotidianità sconvolta, il cosmos perduto. L’antropologa sembra invitarci a ripensare la nostra esperienza di abitante di quegli interni familiari, i gesti irriflessi che compiamo, gli oggetti che adoperiamo, le abitudini e le posture che assumiamo. Ci esorta a riorganizzare lo sguardo, a risignificare gli spazi, a ridefinire l’identità, il nostro Esserci-nel-mondo. Perché «abitare non è solo occupare un luogo, ma è riscattarne la datità tramite le azioni e le pratiche che si dispiegano al suo interno. Siamo noi i veri demiurgi, sono le nostre modalità quotidiane del fare, del prendersi cura, a trasformare una piccola porzione di spazio in un centro» (Pasquinelli 2014: 116).
La casa in questa narrazione è il luogo centrale che salva e protegge, lo spazio liminare che custodisce l’ordine con il quale colonizziamo il mondo, il riparo materno in cui si radica la territorialità dell’esistere e dell’abitare, il confine che separa il noto dall’ignoto, il domestico dal selvatico, la vita dalla morte. Di qua il genius loci, lo spirito tutelare, di là il caos, l’irruzione del virus. In queste giornate di disordine esistenziale vale la pena riprendere in mano il libro di Carla Pasquinelli, La vertigine dell’ordine (Baldini Castoldi 2014), per ritrovare tra le pareti della casa la quotidianità sconvolta, il cosmos perduto. L’antropologa sembra invitarci a ripensare la nostra esperienza di abitante di quegli interni familiari, i gesti irriflessi che compiamo, gli oggetti che adoperiamo, le abitudini e le posture che assumiamo. Ci esorta a riorganizzare lo sguardo, a risignificare gli spazi, a ridefinire l’identità, il nostro Esserci-nel-mondo. Perché «abitare non è solo occupare un luogo, ma è riscattarne la datità tramite le azioni e le pratiche che si dispiegano al suo interno. Siamo noi i veri demiurgi, sono le nostre modalità quotidiane del fare, del prendersi cura, a trasformare una piccola porzione di spazio in un centro» (Pasquinelli 2014: 116).
La casa dunque non come argine da presidiare ma come microcosmo da riordinare, un osservatorio da cui sporgersi per riappropriarci delle nostre relazioni con il mondo. Ma anche un laboratorio sperimentale dei rapporti familiari, della comunicazione tra generazioni, della tenuta e della convivenza domestica. Se ci chiedono tuttavia di restare a casa, di non uscire, di rispettare le interdizioni, se le categorie del dentro/fuori diventano vincolanti e non inclusive, se l’obbligo si associa al divieto, allora c’è il rischio che le ragioni securitarie del confinamento per motivi igienico-sanitari possano tradursi in egoismi e discriminazioni sociali contro chi è fuori e stigmatizzato come estraneo, fino a trasformare la casa in un bunker privilegiato e incontaminato. Si consideri che l’epidemia piomba eguale e indifferente in un mondo disegnale e differente, accentua le cesure tra l’emerso e il sommerso dell’umanità, tra chi è regolare e chi è clandestino, tra chi ha un tetto e chi non lo ha. Da una parte, nell’ansia di proteggersi dal contagio, la cui fonte è dappertutto, si può diffondere la postura poliziesca di quanti invocano l’esercito, pronti a segnalare, fotografare, additare gli untori che non rispettano le regole, spesso identificati nei diversi, negli stranieri, negli emarginati, per lo più destinati a occupare delle città gli spazi pubblici all’aperto, a usare le strade come luoghi di relazioni primarie. Dall’altra parte, il virus acutizza la questione delle ineguaglianze nell’accesso alla salute, all’alloggio, ai servizi sociali e ai diritti di cittadinanza, inasprisce la conflittualità, minaccia la tenuta di questa democrazia “immunitaria”. Il virus separa non solo i vivi dai morti, sepolti in solitudine senza commiato, ma anche i vivi dai vivi, i giovani dagli anziani, i cittadini domiciliati a casa dagli sfrattati, i lavoratori stanziali dagli ambulanti, i regolari dai clandestini, i prosciolti dai carcerati.
Nello stato di eccezione il prezzo del collasso economico e del disordine sociale sarà pagato dai più deboli, dai migranti, dagli invisibili dei ghetti delle campagne, da quei soggetti che rischiano di essere ostaggio delle mafie per sfuggire alla fame e alla povertà. Alle criticità del sistema sanitario si accompagna l’implosione del già fragile welfare così che il contesto segnato dalla strage quotidiana provocata dallo sciame epidemico è destinato a farsi più violento e più cupo. Se il nemico non è più al di là delle frontiere ma è tra di noi, incorporato dentro di noi, se noi stessi temiamo di diventare forestieri superata la soglia di casa, allora è più facile che lo straniero incarni il fantasma di questo microrganismo assassino, che la paura di essere contaminati induca a respingerlo piuttosto che ad accoglierlo, che lo Stato incalzato da mille priorità non si occupi di profughi e di migranti e che questi precipitino nelle spire più pericolose della clandestinità, nelle vie di fuga della criminalità e dell’usura. Unica preziosa risorsa, anche in questo momento, è quel che resta della rete di accoglienza territoriale affidata ad associazioni, gruppi di cittadini, famiglie. Una sfida tanto più ardua e difficile nel generale deficit dello stato sociale delle amministrazioni pubbliche e nell’oggettivo distanziamento fisico imposto dalle restrizioni. Restando sorda o assente la politica su questo faticoso fronte, non riuscendo a vedere gli ultimi, gli invisibili, il peso e il ruolo della sussidiarietà cadono per intero sulla società e da quest’ultima sul mondo privato e domestico.
 È quanto scrive Michel Agier nel suo libro, Lo straniero che viene, da poco pubblicato in Italia da Raffaele Cortina, che ho letto durante questi giorni. Si tratta di una riflessione sulle pratiche che si compiono in nome dell’ospitalità, sui modelli di accoglienza e sulla condizione storica e antropologica di chi è straniero o è considerato tale. L’antropologo muove da una critica all’idea di “ospitalità incondizionata” di Jacques Derrida, che giudica ideologica e impraticabile, per risalire alla corretta traduzione della xenia dell’antica Grecia che si risolveva nell’istituzione di un patto, di uno scambio, di una relazione formalizzata: «mai priva di condizioni, permette di riconoscere l’Altro, ma in maniera concreta, così come si presenta, e di assegnargli un posto in uno spazio» (Agier 2020: 46). Dal momento che lo straniero non integrato non è tollerabile occorre che nella simmetria degli obblighi e nell’asimmetria degli status sia trasformato in ospite. In un mondo in continuo movimento si può essere stranieri, sostiene Agier, per almeno tre profili: per ragioni spaziali o geografiche, per questioni giuridico-politiche, per costumi culturali. Chi arriva da fuori, chi ha altra nazionalità o cittadinanza, chi è diverso per lingua, religione o altro ha comunque diritto ad essere ospitato e, secondo il principio kantiano, a non essere chiamato ‘nemico’.
È quanto scrive Michel Agier nel suo libro, Lo straniero che viene, da poco pubblicato in Italia da Raffaele Cortina, che ho letto durante questi giorni. Si tratta di una riflessione sulle pratiche che si compiono in nome dell’ospitalità, sui modelli di accoglienza e sulla condizione storica e antropologica di chi è straniero o è considerato tale. L’antropologo muove da una critica all’idea di “ospitalità incondizionata” di Jacques Derrida, che giudica ideologica e impraticabile, per risalire alla corretta traduzione della xenia dell’antica Grecia che si risolveva nell’istituzione di un patto, di uno scambio, di una relazione formalizzata: «mai priva di condizioni, permette di riconoscere l’Altro, ma in maniera concreta, così come si presenta, e di assegnargli un posto in uno spazio» (Agier 2020: 46). Dal momento che lo straniero non integrato non è tollerabile occorre che nella simmetria degli obblighi e nell’asimmetria degli status sia trasformato in ospite. In un mondo in continuo movimento si può essere stranieri, sostiene Agier, per almeno tre profili: per ragioni spaziali o geografiche, per questioni giuridico-politiche, per costumi culturali. Chi arriva da fuori, chi ha altra nazionalità o cittadinanza, chi è diverso per lingua, religione o altro ha comunque diritto ad essere ospitato e, secondo il principio kantiano, a non essere chiamato ‘nemico’.
Agier riferisce di esperienze etnografiche e guarda con attenzione e ammirazione all’esempio di Riace, laddove ad un’accoglienza civile e generosa ma non gratuita si è accompagnata una convivenza fatta di regole, di reciprocità, di progettualità collettiva ispirata al modello di una comunità aperta. Non un approccio emergenziale, assistenziale o semplicemente umanitario, destinato a generare alienazione e subalternità, a compromettere il rapporto di fiducia tra chi arriva e chi è residente, ma piuttosto un’opera d’inclusione, di elaborazione e partecipazione ai processi decisionali, una accoglienza diffusa che si caratterizza per la creazione nello spazio di concreti legami sociali e culturali. Ospitalità è in ultima analisi sinonimo di una relazione politica che al di là del riconoscimento dei diritti d’asilo trova la sua legittimità nell’attualità del cosmopolitismo. In questa prospettiva le pagine scritte da Agier prima dell’insorgere dell’attuale epidemia sembrano essere in qualche modo profetiche:
«Si diffonde la sensazione di poter condividere uno stesso mondo, la cui ultima frontiera comune è attualmente il limite naturale del pianeta Terra. Ormai non dobbiamo più attendere per pensarci come “terrestri”. La scoperta dell’unicità ecologica della Terra, e della nostra interdipendenza e responsabilità collettiva in tale contesto, può nuovamente, e in modo diverso dall’età dell’Illuminismo, assegnare alla nostra epoca il compito di tradurla in una unicità politica, resa immaginabile dalla fine della Guerra fredda. A partire da questo problema dell’unificazione planetaria, si sono formate concezioni più o meno entusiastiche, utopiche, felici o inquiete. Gli argomenti non mancano. Il nostro pianeta è un insieme finito che ciascuno può abbracciare e anche “vedere” nella sua totalità; nessun popolo o luogo ne è escluso. Ha una superficie curva, quindi non potremo mai scappare gli uni dagli altri. E, infine, è un mondo potenzialmente comune» (Agier 2002:105).
Sono parole che irrompono con insospettata tempestività nel dibattito politico e culturale dei nostri giorni, stretti nella sospensione tra rigido isolamento e spontanei slanci solidali, tra autodisciplina e ribellismo, tra resistenza e traumi collettivi. Agier ci invita a ripensare il mondo come un progetto comune, «un mondo che è – e sarà – sempre più mobile e produrrà un numero sempre maggiore di stranieri», un pianeta in cui «avremo bisogno di inventare una cittadinanza nomade per tutti» (Agier 2020: 165). Da qui il diritto ineludibile alla mobilità, perché tutti siamo stati o saremo stranieri, così che «riconoscendo lo straniero in noi, possiamo non detestarlo in lui», per usare le parole della filosofa Julia Kristeva.
 La lezione del coronavirus, che scavalca confini e si fa beffe di ogni becero sovranismo, sta tutta qui. Nel segno del cosmopolitismo, non retorico né intellettualistico ma materialmente imprescindibile, è forse possibile guardare con più fiducia all’esperienza di questa pandemia che ancora ci angoscia, al mondo che verrà dopo, quando la tempesta sarà finita. Mentre cesso di scrivere ho davanti la straordinaria immagine del Papa, solo al centro sul sagrato di piazza San Pietro vuota sotto la pioggia, un’icona potente che segna l’oltranza dell’immaginazione e l’altezza impareggiabile della tragedia. Nel balcone la primavera ostinata si annuncia con violette e ciclamini già fioriti. Mai viste tante rondini posare sul davanzale della finestra. Leggo che l’Europa chiamata a decidere è ancora una volta divisa di fronte all’appuntamento della Storia. Nel frattempo lo spread sale. Qualcuno ha tentato un assalto ad un supermercato. Il numero dei morti per covid 19 ha superato le diecimila unità. Più di centomila i contagiati. Negli altri Paesi si contano migliaia di altre vittime.
La lezione del coronavirus, che scavalca confini e si fa beffe di ogni becero sovranismo, sta tutta qui. Nel segno del cosmopolitismo, non retorico né intellettualistico ma materialmente imprescindibile, è forse possibile guardare con più fiducia all’esperienza di questa pandemia che ancora ci angoscia, al mondo che verrà dopo, quando la tempesta sarà finita. Mentre cesso di scrivere ho davanti la straordinaria immagine del Papa, solo al centro sul sagrato di piazza San Pietro vuota sotto la pioggia, un’icona potente che segna l’oltranza dell’immaginazione e l’altezza impareggiabile della tragedia. Nel balcone la primavera ostinata si annuncia con violette e ciclamini già fioriti. Mai viste tante rondini posare sul davanzale della finestra. Leggo che l’Europa chiamata a decidere è ancora una volta divisa di fronte all’appuntamento della Storia. Nel frattempo lo spread sale. Qualcuno ha tentato un assalto ad un supermercato. Il numero dei morti per covid 19 ha superato le diecimila unità. Più di centomila i contagiati. Negli altri Paesi si contano migliaia di altre vittime.
Come nessuna cultura basta a se stessa, così nessuno si salverà da solo. Lo dice il Papa. Ce lo ricorda il coronavirus. Ce lo insegna il Poeta: «Nun mi lassari suli// Ascùtami, parru a tia stasira/e mi pari di parrari o munnu./ Ti vogghiu diri/ di non lassàrimi sulu /nta sta strata longa/chi non finisci mai/ed havi i iorna curti./ Ti vogghiu diri/ca quattr’occhi vídínu megghiu;/e ca lu pisu spartutu nte spaddi/diventa leggiu./Ti vogghiu diri/ca si t’appoji a mia/e io m’appoiu a tia/ non putemu càdiri/ mancu si li furturati n’assicùtanu a vintati».
Dialoghi Mediterranei, n. 43, maggio 2020
Nota
[1] «Non mi lasciare solo// Ascoltami, parlo a te stasera/ e mi pare di parlare al mondo./Ti voglio dire/di non lasciarmi solo/ in questa strada lunga/ che non finisce mai/ e ha i giorni corti./ Ti voglio dire/ che quattro occhi vedono meglio/ che milioni d’occhi/ vedono più lontano, /e che il peso diviso sulle spalle/ diventa leggero./ Ti voglio dire/che appoggiato a me/ e io appoggiato a te/ non possiamo cadere/ nemmeno se la bufera/ c’insegue a ventate» (da Io faccio il poeta di Ignazio Buttitta)
________________________________________________________
Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. La sua ultima pubblicazione è la cura di un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (2015).
_______________________________________________________________











