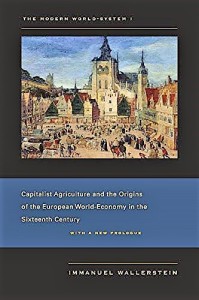di Alessandro Simonicca
Questione di termini
Negli anni Cinquanta del ‘900 Manlio Rossi Doria (Dieci anni di politica agraria nel Mezzogiorno, Bari, 1958) così sintetizzava il gap di fondo dell’economia agricola italiana del Mezzogiorno, adoperando una metafora tratta dalla pratica della macellazione delle carni: da una parte, nelle zone esterne, le estensioni agricole e la cultura arborata, generatrici di ricchezza economica, “la polpa”; dall’altra, nelle zone interne, vi sarebbe stato “l’osso” dei rilievi montani, caratterizzati da un progressivo svuotamento abitativo ed economico, che sarebbe corrisposto poi all’esodo di massa verso il triangolo industriale o verso i centri cittadini più attrattivi dal punto di vista lavorativo e sociale.
In Italia le “aree interne” rappresentano il 53% circa dei Comuni italiani (4.261), ospitano il 23 % della popolazione italiana, pari a oltre 13,54 milioni di abitanti, e occupano una porzione del territorio che supera il 60% della superficie nazionale.
Di recente, nel 2013, in pieno governo Letta, Francesco Barca, con la Strategia Nazione per le Aree Interne (SNAI), ha ripreso questa formidabile metafora per ri-pensare fortemente le ‘aree interne’ italiane, in una sorta di filosofia sociale del territorio nazionale, che si riassumeva nella bella (pur se in qualche modo irenica) dizione di “Coesione Territoriale”, sia come Ministero sia come Agenzia, entro la linea della Strategia stessa. La nozione di ‘area interna’ suscita interesse perché esprime una dinamica spaziale esocentrica, che pone in contrapposizione due registri, in cui l’esterno assume il ruolo egemone, rispetto al suo opposto che, in fondo, è equivalente a periferia ‘interna’, con dichiarato rilievo negativo.
Le coppie opposizionali, come si sa, vivono della loro interna inestinguibile tensione che non sfocia mai nella differenza pura (lo vedremo), ma hanno una propria genesi che si appalesa ogni volta che se ne indicano le proprietà costitutive. Nel nostro caso, la relazione interno-esterno si costruisce attorno a due opposizioni e ad una inversione: la primaria opposizione logica fra contrari spaziali rilegge in maniera inversiva il rapporto centro-periferia, capovolgendo il valore dei termini. L’associazione esterno/progresso e interno/tradizionale nella metafora di Rossi Doria sembra, a prima vista, realizzarsi compiutamente, in realtà pecca per sottostimare la dimensione del potere, a favore della dimensione del valore economico, pur se inteso nella più piena configurazione socio-territoriale.
L’opposizione centro-periferia in termini geografici presta inoltre il fianco a severe contestazioni. Prima di tutto, la figura logica dell’opposizione è da leggere in maniera scalare, in specie collegandola alla dimensione temporale; in secondo luogo, non è riconducibile ad una relazione fissista. Che essa sia scalare e non statica, lo mostra molta ricerca nell’antropologia del turismo, ove il termine ‘periferia’ ha un significato del tutto diverso, se non diametralmente opposto, e riguarda ciò che Louis Turner e John Ash (The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periphery, London, 1975), con riferimento ai Paesi ‘in via di sviluppo’, hanno denominato “la periferia del piacere”, che è sì in contrapposizione con il cuore del sistema mondiale, con le metropoli e con le regioni del centro intenso nel senso più ampio di territorialità dominanti nel mercato mondiale (Europa, Usa, Canada, Giappone, Australia etc.), nondimeno assume nette connotazioni positive, per la funzione svolta dal ‘turismo’ riguardo allo sviluppo locale, oltre che internazionale, pur nella varia valutazione che si può dare circa gli effetti del sistema turismo sui siti destinazione.
 Passerò a ordinare qualche concetto relativo al rapporto fra periferia ed aree interne in termini scalari, perché ciò impedisce di produrre una visione statica e permette al contempo pratiche teoriche e di azioni sociali innovative, o per lo meno interessanti. L’antropologia del turismo, a sua volta, ci aiuterà a comprendere meglio quanto tale aspetto del reale sia al contempo relativo e convenzionale.
Passerò a ordinare qualche concetto relativo al rapporto fra periferia ed aree interne in termini scalari, perché ciò impedisce di produrre una visione statica e permette al contempo pratiche teoriche e di azioni sociali innovative, o per lo meno interessanti. L’antropologia del turismo, a sua volta, ci aiuterà a comprendere meglio quanto tale aspetto del reale sia al contempo relativo e convenzionale.
Periferie e aree interne
Prima di tutto, la perifericità è definibile come “il confine o la frontiera più esterna di un’area”, il che è una interpretazione spaziale definita, infinitamente applicabile. L’essere periferico, invece, non riguarda solo una mera denotazione geografica, connota anche, per di più e in genere, una situazione di marginalizzazione, lo status che deriva dalla mancanza di potere, la continua esperienza di una esigua capacità di influire sul proprio e sull’altrui futuro, in ogni senso, dal politico all’economico al culturale. Ne è derivativo, perciò, che la situazione di ‘essere-periferico-a’ sia spesso prossimale a ‘essere-insulare-a’; centro, metropoli o continente che sia.
Con la perifericità marginale abbiamo l’immissione della dimensione storica e, con essa, l’immissione di un divenire-marginale come una connotazione dinamica, pur se di tipo negativo, che l’assetto spazio geografico di per sé non include né presuppone. Se si vuole, è una definizione ‘artificiale’, legata a un design che narra la storia e l’importanza dei territori di cui si tratta, in quanto ciò che rende periferica una zona non è la posizione/collocazione assoluta, quanto un attuale rapporto di distanza o di diseguaglianza tra punti dell’intera area e centri del potere.
L’artificiale vive, quindi, una relazione antagonista, che deve la sua presenza ad una trasformazione storica e politica. La cogenza e l’emersione del concretum è infatti di natura politologica e si collega ad una lunga storia, che riguarda la stessa nozione moderna di ‘mappa’. Sappiamo infatti che le mappe sono una squisita espressione dell’ambito del politico, sin da quando nel 500, con la stampa e con la fine dello spazio teologico, i confini e le frontiere diventano tali rispetto a un centro che governa, domina ed è legittimato (o si è autolegittimato) a difendere l’interno dall’esterno, a partire proprio dalla linea più fragile, la linea divisoria che, separando due territori, divide e oppone il Sé dall’Altro.
Se dal punto di vista della tecnologia della comunicazione è lo Stato moderno, in particolare, a codificare la periferia come luogo liminale su cui arroccare la massima forza difensiva possibile, traendo anche ragioni denominative per la conoscenza e la classificazione dei territori che sono contenuti nell’area complessiva, articolandole in qualche modo anche in unità, è la storia economica del Novecento che consacra il binomio centro-periferia, facendola assurgere a categoria fondativa dell’essere sociale globale.
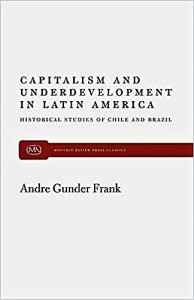 Non si può dimenticare, infatti, che il completamento classificatorio delle zone e dei territori, definiti per nome e per confini, passa attraverso i viaggi degli uomini in armi e non, ma soprattutto si deve alle strategie politiche del dominio europeo su tutte le regioni mondiali, che bene conosciamo espresse nelle dinamiche dell’imperialismo, del colonialismo e del post-colonialismo poi. La divisione del mondo in centro e periferia, più nello specifico, è stata soprattutto al centro dell’agenda, teorica e politica, di un settore degli studi sullo ‘sviluppo’, poi passato sotto la dizione di ‘teoria della dipendenza’. Si pensi ad Andre Gunder Frank (Capitalism and Underdevelopment in Latin America, MRP, 1967) o ad Immanuel Maurice Wallerstein (The Modern World-System, Berkeley, 1974-2011), che sostenevano grosso modo la tesi comune che a livello mondiale vi fosse un rapporto fra Paesi industrializzati centrali forti e Paesi agricoli deboli e con gracile infrastruttura tecnologica, tale che i primi potessero estrarre in abbondanza risorse e manodopera dai secondi, che, così subendo, avrebbero dovuto condividere un destino comune di immiserimento progressivo.
Non si può dimenticare, infatti, che il completamento classificatorio delle zone e dei territori, definiti per nome e per confini, passa attraverso i viaggi degli uomini in armi e non, ma soprattutto si deve alle strategie politiche del dominio europeo su tutte le regioni mondiali, che bene conosciamo espresse nelle dinamiche dell’imperialismo, del colonialismo e del post-colonialismo poi. La divisione del mondo in centro e periferia, più nello specifico, è stata soprattutto al centro dell’agenda, teorica e politica, di un settore degli studi sullo ‘sviluppo’, poi passato sotto la dizione di ‘teoria della dipendenza’. Si pensi ad Andre Gunder Frank (Capitalism and Underdevelopment in Latin America, MRP, 1967) o ad Immanuel Maurice Wallerstein (The Modern World-System, Berkeley, 1974-2011), che sostenevano grosso modo la tesi comune che a livello mondiale vi fosse un rapporto fra Paesi industrializzati centrali forti e Paesi agricoli deboli e con gracile infrastruttura tecnologica, tale che i primi potessero estrarre in abbondanza risorse e manodopera dai secondi, che, così subendo, avrebbero dovuto condividere un destino comune di immiserimento progressivo.
La teoria della dipendenza, in realtà, mostra diverse falle. Dimostra di non sapere dare risposta alla genesi o alla resistenza di regioni marginali entro il centro stesso, alla interdipendenza fra aree asimmetriche o al divenire attrazioni le stesse città metropolitane (che certo non sono periferia), non sa esplicare le linee di sviluppo delle società che invece riconoscono nel rapporto capitale-lavoro il vero traino dell’economia e la più profonda trasformazione sociale del tempo. Pur tuttavia, centra un indubbio asse relativo alle attuali coordinate della dislocazione del potere e del mercato a livello globale, compresa la genesi di molte aree marginali o periferiche.
In ogni caso, un’area periferica è un’area che soffre di isolamento geografico e dista dalle sfere centrali dell’attività, esperendo progressiva diminuzione di accesso da e per il mercato. Da ciò discende un’emarginazione economica, dovuta alla mancanza di risorse oppure al declino della vecchia industria o dell’agricoltura, come fattori singoli oppure accomunati.
Se volessimo enumerarne le caratteristiche fondamentali potremmo velocemente dire che le aree periferiche
- dal punto di vista del mercato, si caratterizzano per indebolimento dei canali comunicativi, scarse infrastrutture, frammentazione e debolezza dei legami economici interni,
- dal punto di vista della popolazione, sono aree generatrici di flussi migratori, in specie giovanili, con un indebolimento della scuola sul territorio che rafforza a feedback il ciclo dell’emigrazione,
- dal punto di vista tecnologico, per mancanza di innovazione, tendono ad importare nuovi prodotti, rendendo di fatto il governo nazionale (o locale) più interventista che nelle regioni centrali/metropolitane,
- dal punto di vista del business, registrano la prevalenza di un regime micro-imprenditoriale, cui sono associate basse quote di capitale umano e cognitivo,
- dal punto di vista della percepibilità, sono aree rurali scarsamente popolate, che possono elicitare un progressivo senso di ‘remotezza’ e amenità, che richiama visitatori e turisti, in specie nel settore delle risorse nature-based.
Al di là delle denotazioni o delle proprietà di tipo oggettivo, si deve sottolineare che la perifericità riguarda – in specie nel tempo attuale – ‘questioni di gusto’. Ciò significa che la condizione del ‘remoto’ si collega in genere alla connotazione della difficile accessibilità; e, al contempo, tale condizione facilita la creazione di quei presupposti necessari per fare divenire attrattive le zone interessate, favorendo la nascita e la crescita di percezioni di qualità esteticamente apprezzabili (la bellezza naturale, il senso dell’alterità, la peculiarità di un sentimento…), non disdegnando di attribuire nemmeno al ‘repellente’ il ruolo di possibile fonte di attraente diversità.
È su tali ‘percezioni’ che bisogna rivolgere lo sguardo per capire cosa succede a un territorio di area periferica, e in specie la dinamica complessiva in cui esso può essere immesso o assoggettato. Tra le novità della crisi della modernità e la genesi della post-modernità si situa proprio il mutamento della percezione dello spazio, nonché una rinnovata importanza svolta dallo ‘sguardo’.
È il possibile passaggio degli attributi della perifericità dallo svantaggio storico sociale a nuove opportunità ambientali, dall’isolamento geografico alla ricerca della pace interiore, dalla remotezza locale alla accezione della differenza e dell’esoticità, a ritmare la cadenza di molto nostro tempo attuale. Nella nuova dimensione complessiva di passato che viene a concrescere, la ruralità diviene una delle condizioni più rilevanti con cui si attua un processo di rottura rispetto al ritmo ordinario della vita e alla caduta del previo mondo del lavoro. Se il passato, qui, può significare ritorno alla ruralità, ciò non vale certo come ritorno alla ‘strumentalità’ del mondo della lavorazione dei campi o della raccolta delle risorse telluriche, quanto la tendenza a risignificare la ‘natura’ in una nuova funzione di contemplazione mentale rigenerativa del Sé, di apprezzamento estetico, oppure di desiderio di attività fisica.
Si può obiettare che del passato (prossimo) esistono anche assetti e aree lavorative in triste dismissione, ma la cessata funzione macchinica dell’industria può indurre a ragionare su coordinate di un ambiente che si sta-rinaturalizzando, se non intervengono – ovviamente – piani di recupero o rifunzionalizzazione. Sia dell’ex industria, sia delle condizioni più pianamente rurali, rimangono gli stili tradizionali trascorsi e l’insieme dell’heritage come gigantesco recupero della sicurezza del tempo che fu. In queste circostanze, il turismo è una forma di mobilità culturale può diventare un ottimo mezzo per salvaguardare modi di vita, patrimoni, ambienti.
Per situazione paradossale, è lo stesso sintomo della perifericità ad assumere la funzione di antidoto ai problemi sociali e ai costi economici che la ‘remotezza’ ha causato e continua a causare. L’antidoto, come tutti i farmaci, è però ambivalente e può diventare anche ‘tossico’, in specie se accade, come si dà sempre più il caso, che i nuovi siti non siano adeguatamente implementati e condotti per mano in maniera ferma e consapevole.
Non si necessita di molta fatica a immaginare nuovi siti severamente impegnati da sovraffollamento, eccesso di pressione sul territorio, la concorrenza fra visitatori e locali circa l’entità e la destinazione delle risorse interne, e così via. In questi casi, tutt’altro che rari, il rischio è la possibilità che venga a mancare quella stessa manchevolezza ‘ontologica’ che aveva fatto scattare il fascino del luogo e il suo susseguente processo di valorizzazione, sino a una nuova catastrofe desertificante.
In sintesi, si potrebbe parlare del passaggio da ciò che ‘deve-essere-visto’, e quindi aperto a tutti, a ciò che ‘è-troppo-visto’, e quindi destinato a non elicitare più interesse, sino al naufragio della stessa destinazione. Più che svolgere per intero questo circolo vizioso – che implica la descrizione di un’ampia fenomenologia di casi diversi – vale la pena di indicare in che maniera le aree periferiche/interne possono diventare aree appetibili per persone, gruppi, istituzioni.
Aree periferiche e turismo naturistico
Partiamo dal rapporto fra ruralità e turismo a base ambientale, che è il caso più usuale quando si parla di aree periferiche; e il nature-based tourism è probabilmente il segmento più vasto di quell’attività di tempo libero che si svolge in ambito naturale (es. il turismo di avventura), punta su elementi specifici dell’ambiente (safari, turismo marino, turismo wildlife …) oppure è finalizzato a conservare e proteggere vere e aree (ecoturismo, parchi naturali).
La prospettiva antropologica sottolinea, in genere, l’inestricabile coestensione fra paesaggio (landscape) e tradizioni ambientali (heritage), nella duplice direzione dell’analisi territoriale e, insieme, delle strategie utili a ‘vedere’ il territorio in un rapporto complesso fra futuro e passato. Raramente, insomma, in specie in questo ambito, si dà analisi antropologica dei dati, senza al tempo stesso intendere e/o indicare in che modo le risorse complessive possano essere riconsiderate e utilizzate nella ‘trasmissione’ di pratiche culturali e di modi di vita. Rimane difficile separare l’analisi documentaria dai problemi di uno sviluppo locale o regionale, e ciò significa analizzare le varie forme di ‘capitale’ che un territorio possiede.
È infatti importante notare che i temi relativi all’analisi e allo sviluppo del locale/regionale non si fermano alla conta e all’esposizione dello stock del capitale prodotto (trasporti, energia, infrastruttura, housing, produzione di beni) o di capitale naturale (wilderness, risorse naturali, parchistica, spazio verde, endemismi, specie naturali di alto valore). Risulta quanto mai necessario – e su ciò si basa la necessità di una preview etnografica per ogni tipo di sviluppo – entrare nella dimensione antropica del campo di ricerca, ossia andare a definire l’assetto del capitale umano (capacità professionali, apprendistato, conoscenze individuali, formazione) e del capitale sociale (abilità dei soggetti a coordinare le proprie azioni, logica delle scelte in vista di fini comuni, virtù sociali e così via).
Il capitale umano e il capitale sociale diventano perciò requisiti critici per lo sviluppo di un territorio basato sulla valorizzazione delle risorse naturali, e quindi precondizioni, non mera conseguenza; e qui per ‘critici’ si intende sia il momento in cui si frammenta una totalità in un sia pure precario equilibrio, sia la condizione di possibilità dell’avvio di un nuovo trend.
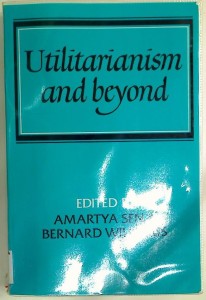 Sul capitale umano si è svolta molta discussione e, probabilmente, rispetto alle tesi classiche di Amartya Sen (Utilitarism and Beyond, Cambridge, 1982; On Ethics and Economics, Oxford, 1987), l’attuale riflessione pone in dubbio sia la sua pre-determinabilità tramite il rimando alla carriera formativa sia il supposto ruolo predittivo di creatività territoriale rappresentato dal titolo di studio, come avanzato qualche tempo fa da Richard Florida (The Rise of the Creative Class, and How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York, 2002); rimane indubbia la sua importanza come prerequisito, da indagare però con maggiore attenzione rispetto al rapporto fra saperi generali, saperi specialistici e saperi territoriali.
Sul capitale umano si è svolta molta discussione e, probabilmente, rispetto alle tesi classiche di Amartya Sen (Utilitarism and Beyond, Cambridge, 1982; On Ethics and Economics, Oxford, 1987), l’attuale riflessione pone in dubbio sia la sua pre-determinabilità tramite il rimando alla carriera formativa sia il supposto ruolo predittivo di creatività territoriale rappresentato dal titolo di studio, come avanzato qualche tempo fa da Richard Florida (The Rise of the Creative Class, and How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York, 2002); rimane indubbia la sua importanza come prerequisito, da indagare però con maggiore attenzione rispetto al rapporto fra saperi generali, saperi specialistici e saperi territoriali.
La dimensione della natura, infatti, non è solo una condizione geografico-spaziale, è anche un sapere territoriale, fornita di dimensioni biofisiche ed estetiche. È quindi una nozione relativa, quantificabile in termini di fattori (piante, animali, specie endemiche/non endemiche …) ma anche associata ad altri attributi locali, quali il grado di wilderness, l’intensità del remoteness e così via. Questi due ultimi attributi, in particolare, costituiscono un continuum bidimensionale per identificare le are remote. In tale approccio continuistico cresce la consapevolezza di fare i conti con tre dimensioni delle pratiche dei viaggiatori, ossia la qualità ambientale, l’accessibilità e la pressione dei viaggiatori. In particolare, risulta prioritario
- determinare il tipo di qualità ambientale, dato che la diversità è spesso elemento predittivo della specifica fruibilità del territorio e delle sue risorse,
- inquadrare le condizioni di accessibilità ad un’area, per indagare la dimensione sociale e fisica del supporto nello spostamento, nonché la possibilità concreta di raggiungere il sito,
- monitorare e tendere a prevedere il numero dei visitatori e delle visite, per analizzare i trend di chi viene dal centro ma anche i profili psicosociali e culturali dei visitatori.
I punti indicati rappresentano aspetti fondamentali per definire i frame necessari per la visibilità e fruibilità delle qualità naturalistiche contestuali, in quanto queste ultime dipendono dalla tipologia, dalla quantità e dalla durata dell’impatto dei visitatori, nonché dell’insediamento umano di accoglienza. Sono tre punti cardinali attorno a cui si gioca il rischio che si possa giungere a situazioni di perdita o dismissione delle connotazioni naturali attrattive, così faticosamente costituite. Il nesso triadico induce, infine, a considerare seriamente la difficoltà a bilanciare tra gli obiettivi intenzionali degli hosts e il mantenimento degli alti livelli di nicchia o valore ambientale che in qualche modo hanno trasformato l’habitat (C.M. Hall, S. Boyd, eds., Nature-base Tourism in Peripheral Areas. Development or Disaster?, Clevedon, 2005; F. Brown, D. Hall, eds., Tourism in Peripheral Areas, Clevedon, 2000).
Che ruolo hanno queste coordinate rispetto alla natura e alla costituzione dei saperi territoriali? Ciò è importante, perché circola l’errore comune di ritenere che la trasformazione dei luoghi in siti turistici salvi di per sé, tout court, da una crisi locale economica. Se trasformazione significa in senso schietto mutamento, bisogna riconoscere che è difficile darsi mutamento senza l’ipotesi di sviluppo o piano o progetto o piattaforma di lavoro – ognuno scelga la propria opzione di metodo o di prospettiva, pena il fallimento e la deriva dell’intrapresa.
Il ruolo dei decisori rappresenta un momento e una tappa importante dell’intera filiera. E, in particolare, risulta importante sapere quali sono le informazioni, quali i modelli o le ipotesi da sviluppare riguardanti le aree periferiche, e quali le strumentistiche di intervento rispetto alle aspettative, non lasciandosi fuorviare dai prevedibili stati di esaltazione della prima fase. Non è da sottacere affatto che tra i primari punti al centro della costituzione tematica e della proposta di sviluppo emerge la necessità di cercare le alternative alle o nelle aree periferiche, in una gamma di lungo tratto che va dai trasporti per visitatori, all’accesso di capitali economici, al rinvenimento dell’expertiser, al consolidamento dei legami sociali. Per capire meglio la questione, conviene passare ad affrontare l’ambito complessivo in cui i gruppi i visitatori i locali si inseriscono o abitano; in termini più comuni, l’ambito associativo o comunitario.
Cosa è che fa comunità? È il lavoro svolto, e questo è probabilmente l’assetto da cui partire per iniziare la prima attività di lavoro condiviso, il monitoraggio per individuare le unità di spazio e di senso, connotanti le specificità territoriali, ossia la zonizzazione.
Accade abbastanza di rado che un’area sia, da sola, bastante a riorganizzare un territorio circostante, a meno che non rimandi a un vero e proprio centro, un principio che sintetizzi la varietà delle risorse prossimali per diversificate caratteristiche, quali il potere (città capitale), i trasporti (polo di rete), l’attrattività culturale (centro museale), lo sport (destinazione ludica), la salute (città termale) e così via. Non esistono perciò né lavoro di ricerca analitica né tanto meno sviluppo locale/regionale che siano idonei, senza strategie, ad accorpare in qualche modo territori o, se si vuole, a formulare specifiche zonizzazioni.
Di queste ultime non esistono algoritmi di preferenza o di previsione, esistono invece incubatori di formazione, a seconda della prospettiva che si persegue. La casistica è ampia, basti qui indicare qualche traccia in tema di politiche per l’ambiente. In questo senso, non possiamo non pensare alla L. 394/1991, la (prima) legge quadro sulla protezione ambientale, da cui molto è dipartito sino ad oggi, riguardo alla conservazione ambientale, alla tutela degli endemismi, ai regimi giuridici che riguardano i parchi, le comunità rurali, le aree protette.
Pratiche come il giuspatronato locale, gli usi civici, i beni comuni, i beni collettivi, la tutela ambientale hanno avuto il destino di essere sempre collegate a normative e ad azioni fondamentalmente vincolistiche; il che significa che si è trattato di norme ed azioni che hanno istituito (assai motivate) eccezioni ai codici vigenti. Nell’oggi, non si tratta più – ritengo – di garantire senza eccessivi contraccolpi due sistemi giuridici del tutto diversificati, con evidente prevalenza della disciplina codicistica sul diritto comune; è urgente invece capire quanto del diritto comune può essere utile per mitigare o trasformare la prima.
Se gli anni Novanta si aprono con l’idea di garantire uno spazio autonomo alle aree ambientali, oggi la questione riguarda piuttosto quanto della tematica ambientale può rientrare nella giurisprudenza e nella prassi economico-sociale della vita ordinaria dei territori. E, per considerare nel loro giusto ruolo le inevitabili frizioni possibili, v’è priorità di decidere su come individuare i regimi di appartenenza dei gruppi sociali, tanto quanto l’assetto della loro attribuzione territoriale.
V’è, in effetti un interrogativo, tanto ambiguo quanto centrale, da anteporre subito: a chi appartiene una zona geografica, una località, un sito? Al di là dell’ovvio registro proprietario del diritto soggettivo e del demanio, vi sono altri dilemmi rispetto al regime di proprietà che definirei di tipo socio-morale, che riguardano la forma della (possibile) proprietà relativa ad una collettività, sia essa l’appartenenza, l’azienda di filiera rurale, gli usi civici, l’unità di produzione famigliare e così via.
In genere si definiscono stakeholders i soggetti che possono avanzare la pretesa di possedere diritti reali a rappresentare un territorio, a determinare di esso una mission e a definire gli interessi generali che garantiscano la trasmissione delle qualità precipue di un luogo, in una delineazione di orizzonte di possibile futuro.
A differenza dei soggetti che perseguono la legittima acquisizione di risorse o vantaggi da un territorio dato, gli stakeholders elaborano un’immaginazione morale del territorio, lo pensano e lo processualizzano, con allocazione della dimensione del guadagno non a fine primario e senz’altro non a calcolo diretto e immediato.
Immaginare moralmente un territorio (e qui ovviamente muto alcune suggestioni da Clifford Geertz (Found in Translation: On the Social History of the Moral Immagination, 1977), significa pensarne le possibilità, indagare le linee di azione da mettere in atto, nonché valorizzare le eccellenze, senza ritenere di potere contare su un copione prestabilito o esibire garanzie di efficacia. Di più, la complessa operazione del ripensare i territori non esclude affatto l’assai realistica evenienza che nel processo di trasformazione vengano a nascere o consolidarsi vecchi e nuovi conflitti, dissidi, contrapposizioni fra interessi, dinieghi reciproci di rappresentazione del territorio, momenti di incongruità fra visioni e azioni, e così via. È l’aspetto sociale e collettivo a porsi prepotentemente al centro dell’attenzione di contro ai limiti propri dell’interesse individuale.
Il problema era stato posto in maniera cruciale, diverso tempo fa, da Garrett Hardin (Tragedy of the commons, in Science, 1968), quando analizzando la situazione delle cosiddette ‘proprietà comuni’ in un sistema giuridico fondamentalmente privatistico, prevedeva una completa debacle delle strategie atte a contenere l’aumento della popolazione mondiale e, a seguire, la crisi della durabilità ambientale. In un fulminante saggio di economia ecologica, dimostrava che nel campo delle attività di allevamento e pastorizia le terre aperte al prelievo di risorse (proprietà comuni e usi civici, di storica e recente memora, o commons) erano destinate ad un esito tragico, perché gli utilizzatori avrebbero sempre perseguito un interesse di massima utilità, depauperando sino all’estremo il valore nutritivo delle terre stesse. Per Hardin si trattava di comprendere l’esito della dinamica, diminuire gli effetti devastanti dell’assalto ai commons e normare l’uso delle risorse.
Da questa situazione generale, le note teoriche di Hardin hanno poi costituito il punto per definire un problema ulteriore e più generale, quello dei free riders. Il tema riguarda la problematica delle persone che, agendo nel proprio interesse individuale, si appropriano di risorse di proprietà collettiva (o pubblica) senza assumersi i costi ad esse necessariamente connesse (manutenzione etc.), sì che la massimizzazione del profitto individuale metterebbe a repentaglio di necessità il bene pubblico, a meno che a ciò non si risponda con soluzioni non tecniche ma morali o normative (E. Ostrom, Governing the Commons, Cambridge, 1990).
Le soluzioni non tecniche ma morali sono quelle che le aree periferiche/interne richiedono essere messe a nudo, e ciò ha a che fare con questioni complesse, che definirò qui brevemente in termini di percorsi di produzione di un sito e strategie di partenariato.
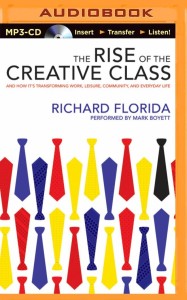 Produzione del sito e partenariato
Produzione del sito e partenariato
Le aree periferiche e le aree interne possono diventare soggetti autonomi e ‘spazi agenti’, se si riesce a fare del nesso di radicamento e appartenenza una buona alternativa al paradigma della massimizzazione dell’utile. Ciò significa attivare processi di produzione di sito, che definiscano risorse e attori interessati al problem domain e si stringano accordi, non solo formali ma sostanziali, di impegno per rappresentare e realizzare l’interesse generale per un territorio aperto a nuovi criteri (eccellenza, musei, qualità della vita…).
Si tratta, insomma, di attivare un partenariato, che scelga non la via del vantaggio concorrenziale ma del vantaggio cooperativo, collegando le relazioni di ius sanguinis con le relazioni di ius soli. Su questa linea anche il legislatore italiano ha cercato di rispondere. Mi riferisco a due eventi giuridico-sociali destinati ad avere impatto di lunga durata, che riguardano rispettivamente la natura delle ‘imprese sociali’ e la vexata quaestio dei beni comuni, recuperando un gap giuridico di lunga gittata rispetto alle normative sulla rappresentanza territoriale in ambito anglosassone (A. Simonicca, Cultura patrimonio turismo, Roma, 2014).
La legge sulle imprese sociali o di comunità riguarda enti e organizzazioni che in qualche modo rappresentano un territorio, oppure sono capaci di erogare servizi utili al soddisfacimento dei bisogni sociali di un determinato contesto. Il nodo è l’esercizio di un’attività di impresa di interesse generale, finalizzata a perseguire finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, con modalità di gestione responsabili e trasparenti, con il più ampio coinvolgimento degli operatori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle loro attività (vedi il DL 117/2017 su tali imprese e sul terzo settore, dopo la vecchia L. 381/1991 sulle cooperative sociali).
Altra finestra è data dalla tematica relativa ai diritti dei regimi dei suoli e dei domini collettivi (L. 168/2017), che apre specifiche finestre di riconoscimento e di competenze per i beni collettivi, i domini di proprietà collettiva e gli ‘usi civici’, nel regolare la complessa relazione di ordinamento giuridico fra comunità e territorio, rafforzando una pista storicamente minoritaria, quella dei ‘beni comuni’, rispetto alla versione egemone del diritto privatistico.
Il partenariato è un processo che richiede un certo tempo per costituirsi, rappresenta però un passaggio importante, perché permette di porre in moto forze e attori sociali diversi per progetti place based, strategie diversificate di finalità, attività di negoziazione, rappresentanze capillari di località, con capacità di autotrasformazione fra le generazioni, individuazione e valorizzazione del patrimonio esistente, processi di accordo, ri-modellazione delle mappe dei servizi (co-design).
Ho citato poc’anzi le strategie SNAI che, pur essendo un sistema nazionale di monitoraggio e intervento per le ‘aree interne’ italiane, lavora a livello di micro-aree territoriali. Partendo dall’idea di combattere la marginalità dell’osso appenninico italiano e renderlo – per così dire – più ‘polposo’, imposta la sua azione con immersione nelle realtà locali interne, individuando le carenze infrastrutturali delle aree marginali di attiguità, con una conseguente ‘zonizzazione’ responsiva all’esigenza di servizi territoriali allargati e alla richiesta di miglioramento della qualità della vita, al fine di garantire il passaggio da uno status di marginalità alla condizione di una nuova autosufficienza, superando il gap fra interesse particolare e interesse generale (A. De Rossi, ed., Riabitare l’Italia. Le aree interne tra abbandoni e riconquiste, parte IV, Roma, 2018).
La strategia è un evento importante, forse non adeguatamente presente all’attenzione nazionale per la difficile situazione nel post-terremoto dell’ultimo decennio che ha continuamente scomposto l’assetto territoriale in specie dell’Italia centrale, ma assai interessante perché in certo modo ha cercato di dare risposta alla questione relativa alla costituency, alla composizione dei soggetti attori sociali, all’idea di creazione di una comunità, che è stata pensata alla luce di un nuovo sistema di erogazione di servizi (sociali, sanitari, formativi, trasporti, ricreativi). Appare soprattutto rilevante e significativa l’idea che il rapporto fra la configurazione di singole località e la riaggregazione territoriale sia destinato a rimanere al centro di una politica della ‘coesione sociale, a partire da ipotesi di nuovi reticoli abitativi diffusi, che vedano soddisfatte le esigenze di una popolazione calcolabile nella misura di una città media.
La correlazione fra l’interesse degli attori locali (e non), l’individuazione dei bisogni sociali e l’azione efficace che si misura su risultati tangibili e comparabili, si indirizza verso la scoperta e la costituzione dei valori da attribuire al territorio, tramite adeguati accordi di programma, la costruzione di filiere produttive e l’attivazione dello sviluppo economicamente positivo della mobilità culturale, della nuova agricoltura e del rilancio del patrimonio storico culturale.
È una sorta di economia morale volta a combattere lo spaesamento, la fragilità, tramite la determinazione della filiera corta, le cooperative di comunità oppure le comunanze locali. Nell’insieme è una forma di antropologia politica che intende recuperare la coesione sociale, nonché superare le prospettive spettrali dell’individualismo metodologico diffuso, in maniera non dissimile dalle recenti Convenzioni internazionali sul patrimonio immateriale che, pur nella diversità di contesti e finalità, partono proprio dall’idea di volere ostacolare le tendenze ideologiche dell’individualismo moderno e del liberismo applicato anche a livello istituzionale, per liberare nuove e creative energie associative (Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, 2003/2007; Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, 2005).
Il caso SNAI è interessante e costringe a pensare su come attrezzarsi per superare le sacche dei paradossi della modernità inebriata dal calcolo economico e come reagire invertendo il processo, ai fini della ritessitura dei rapporti interindividuali e per la loro trasfigurazione in forme sociali di collaborazione.
È da aggiungere che non esistono percorsi preordinati per ritessere il legame sociale; possiamo solo ipotizzare due forme estreme di tipologia. Riprendendo gli antichi termini con cui i geologi si contrapponevano per spiegare la genesi dei vulcani, si potrebbe dire che esiste una interpretazione ‘nettunista’, per la quale uno strato della realtà si consolida tramite associazioni quantitativamente rilevanti per la stratificazione, secondo strategie che congiungono le persone intensificandone le reciproche relazioni (servizi, sistemi di aspettative, reti di alleanze); l’altra interpretazione è invece definibile ‘plutonista’, perché sostiene la possibilità di uno stato ‘fluido’ della realtà e si orienta verso la ricerca della qualità, ossia la messa in atto di processi sintetici, che trovano la loro conclusione nella condensazione di rappresentazioni e valori comuni, alla stregua di un magma da cui possa sorgere un nuovo caldo nucleo comunitario. La coesione sociale per fusione e la coesione sociale per accordo sono due modalità, forse, solo tipologicamente distinguibili, non però nella pratica della ricerca, tanto meno nella pratica della politica. Nello SNAI, in ogni caso, appare predominare una via nettunista alla coesione sociale; più ardua appare, invece, la via plutonista.
 L’identità narrativa dei luoghi
L’identità narrativa dei luoghi
L’antropologo è un intellettuale che va alla ricerca dei nessi che legano in maniera profonda le persone ai loro luoghi di appartenenza o di riferimento e sovente ritrascrive la storia di questo nesso in termini di biografia di luoghi, cose, eventi, dando loro un linguaggio il più interno possibile, il più ‘nativo’ possibile, il più possibile aderente al vissuto contestuale. In altri termini, ‘emico’, e in maniera da rappresentare il luogo nella sua irridubicile unicità, senza temere derive idiosincratiche. Quando un luogo va a morire, tendono a scomparire i legami, le persone e le sue voci, con una perdita ontologica che non concede sconto a chi rimane. È proprio vero però che i luoghi siano destinati a morire? È proprio vero che la voce loro e di chi li abita o li ha abitati debba scomparire del tutto? Dipende, dipende; bisogna essere più cauti.
È il 3 giugno 2008, a Buenos Aires, nel centro della città corre molta concitazione, traffico, palchi, stand, cibo, mercanzia, strumenti musicali, canzoni. Avevo dimenticato la data. Incuriosito, mi incammino tra le quinte del teatro di una celebrazione. È la celebrazione della Giornata dell’Immigrante Italiano in Argentina, dedicata a Manuel Belgrano, nato il 3 giugno 1770 da padre italiano, Padre fondatore della Patria, membro della Prima Giunta di Governo, avvocato e ideatore della stessa bandiera argentina.
Molti gli stand, geolocalizzati, ognuno con un’agguerrita comunità di italo-discendenti, offerta alimentare paesana, depliant narranti il legame con l’Italia, vestiti regionali, foto e dolci, in genere eseguiti dalle donne dell’oggi con le antiche ricette regionali dello ieri. Mi fermo a un grosso stand. E vedo, e leggo: Gerocarne, paese delle Serre calabre, e Gerocarnesi indaffarati. ‘Riuracàrne’ e ‘Riuracarnési’, forse-forse una volta falconieri, poi senz’altro terracottai e contadini, tra altri nomi di paesi che funzionano da emblemi e blasoni, con isotopie differenziate di umanità che si segmenta anche nel più piccolo territorio, con odi e rancori – di prossimità e di attiguità – compresi. Così ricordavo un piccolo paese, nella memoria di 60 anni or sono e oggi luogo semi-spopolato. Ho trovato, oltre Oceano, una sua metà, svanita, sparita, resa invisibile ai più; forse, finalmente deprivato del suo antico linguaggio territoriale segmentario. Le due metà (nella mia mente e di fronte a me, nel paese serrano e nella proiezione boarense, e chi sa quante altre ancora avanzano) mi sembravano in qualche modo conservare una propria tensione, dare inizio ad una inesausta dinamica di agnizione, che non sa rinunciare al desiderio espressivo di conoscersi e congiungersi di nuovo.
Continua a vivere l’identità narrativa di un paese? Continua, continua. Basta non pensare che dal torsolo, ultimo residuo di vita rinsecchita, la ‘polpa’ abbia traslato altrove in maniera meccanica e irreversibile; e rilanciare la prospettiva ermeneutica che la polpa possa essere sempre connessa tra un qui e un là. Tale monito vale anche rispetto alle derive sentimentali di chi assolutizza l’“osso”, contemplandolo e senza vedere le numerose versioni delle altre ‘metà’.
Come connettere, però? Non posso passare alla conclusione del presente ragionamento, senza riandare ad un intrigante insegnamento di Garrett Hardin. Molti, errando, e in specie nelle file degli economisti impegnati socialmente, hanno ritenuto che la sua critica ai commons derivasse da una militanza ideologica nelle file del marginalismo economico applicato alle istituzioni. L’autore, in realtà, non intendeva sostenere che si dovessero eliminare i beni comuni, assoggettandoli al regime del rapporto costi-benefici o dell’ottimo economico. Piuttosto, egli intendeva criticare in maniera impietosa la condizione a-normata dei domini collettivi, perché lesiva dell’etica umana in generale e, insieme, esempio dell’irresponsabile movimento autodistruttivo del sovra-popolamento mondiale. Il dilemma del free rider, di chi usufruisce di beni o servizi senza assumere l’onere dei relativi costi, sta tutto qui.
Al fine di uscire dall’impasse, Hardin invita a considerare due metri di giudizio per l’azione: la coscienza morale e la responsabilità. Con la prima opzione, si stigmatizza il comportamento egoistico, si rivaluta la logica del cuore e dei sentimenti, cercando di creare un sentimento di colpevolizzazione al fine di ottenere un comportamento virtuoso. Con la seconda opzione, ci collochiamo nel solco della razionalità che permette di conoscere le dinamiche del mondo reale e impone di sobbarcarsi ‘liberamente’ dei costi della scelta. A bene vedere, però, non sono due percorsi equivalenti per salvare i commons, giacché il ricorso alla coscienza non pone affatto rimedio al comportamento egoistico, se non produrre unicamente una differenza fra ‘anime belle’ e competitori economici. Il ‘corso del mondo’, però, riconosce come unica norma perseguibile il comportamento egoistico e, senza altra norma, il comportamento del free rider è indotto a ripetersi e a rafforzarsi.
Possiamo ora avviarci a concludere sulla cosiddetta via plutonica. Essa è, alla fin fine, la via della disposizione etica che, per eterogenesi dei fini, non fa che confermare contraddittoriamente lo stato del mondo criticato, salvo l’acuirsi degli spasmi soggettivi del cuore, e nonostante l’intervento del welfare state, che a modo suo rischia di incorrere anch’esso nella stessa logica antinomica; e anche questo è un insegnamento da rimeditare. Più realisticamente, salvo nuovi poco credibili paradigmi, la via nettuniana è quella che indica le regole più percorribili. E per percorribilità si intende l’azione di chi collega il qui e il là, di chi congiunge il nativo con l’acquisito, di chi rilancia relazioni fra parti dimidiate o disperse, di chi tenta rischiose nuove connessioni, e non fusioni. Supremazia della morale sull’etica.
Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020
______________________________________________________________
Alessandro Simonicca insegna Antropologia culturale presso “La Sapienza” di Roma e Antropologia del turismo e dell’ambiente presso l’Università degli Studi di Siena. Si interessa di teorie dell’antropologia e di vari temi riguardanti le società complesse, tra cui infanzia, educazione, turismo, ambiente, sostenibilità. Ha svolto lavori di ricerca in Toscana, in Sud Italia e, come direttore di una missione etnologica del Ministero degli Affari Esteri, in Sud America. Tra le sue pubblicazioni: Antropologia del turismo (1997); con Fabio Dei, Ragione e forme di vita. Razionalità e relativismo in antropologia (1990) e Simbolo e teoria nell’antropologia religiosa (1998); e, con R. Bonadei, Ripassare le acque. Chianciano Terme: storie, persone, immagini (1999); Turismo e società complesse (2004); Terzo spazio e patrimoni migranti (2015); L’Antropologo legge. Ricognizioni dell’intendere (2019); Sull’estetico etnografico (2019).
_______________________________________________________________