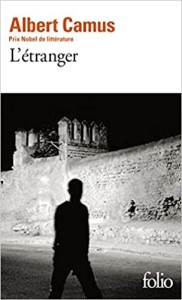di Alberto Giovanni Biuso
4526 pagine di scrittura quotidiana, fitta, pensata. E poi progettata come una serie di trattati che avrebbero dovuto, e hanno, delineato la filosofia di Giacomo Leopardi [1]. Perché Leopardi è filosofo tanto quanto è poeta. Questo è ormai chiaro ai suoi studiosi e l’auspicio è che diventi sempre più chiaro anche ai suoi lettori. La filosofia di Leopardi è espressa ed esposta certamente nel capolavoro che si intitola Operette morali; lo è nei suoi Pensieri; lo è nelle composizioni poetiche. E lo è nello Zibaldone di pensieri, che è opera dalla struttura insieme sistematica e aperta, dove la mole imponente dei testi, degli aforismi, degli appunti, dei saggi si rimanda reciprocamente e dalla quale emerge in questo modo un insieme ben definito di temi che si condensano in trattati, sei trattati esattamente. Quest’opera accompagna e fonda l’intera scrittura di Leopardi ed è per questo che tenterò di porre in dialogo lo Zibaldone con le altre opere del filosofo-poeta.
Operette antropologiche e metafisiche
Sono certamente un gran libro le Operette. Uno dei pochi libri italiani radicali, espliciti sulla natura e la storia, pervasi da una serietà di intenti e lucidità di prospettive che non appartengono certo alla tradizione nazionale. Si può accostare, in questo, al Principe e alla Storia della colonna infame. Ha, poi, una varietà di toni, una differenziazione lessicale, una ricchezza stilistica tali da non stancare mai, neppure quando i contenuti sono ripetitivi e il discorso si fa un po’ retorico.
È un gran libro di filosofia morale. Ma non solo. Alla base di ogni discorso etico deve stare infatti una ben chiara antropologia, frutto di una metafisica, implicita o esplicita che sia. L’antropologia di Leopardi è assai lucida. La natura umana è «inquieta, insaziabile, immoderata» (Storia del genere umano, OM: 21), colma di un desiderio di vivere, di una energia senza requie destinata, per il suo stesso eccesso, a rimanere sempre insoddisfatta, a produrre le illusioni, «meravigliose larve» (ivi: 17). Il vivere stesso è questa illusione, che si manifesta non nella malattia, nella solitudine o nella morte ma nell’invecchiare, in quel decadere della forza vitale, in quel dissiparsi dell’energia che «priva l’uomo di tutti i piaceri, lasciandogliene gli appetiti», recando in cambio innumerevoli dolori, e tuttavia «gli uomini temono la morte, e desiderano la vecchiezza» (PE, VI: 28).
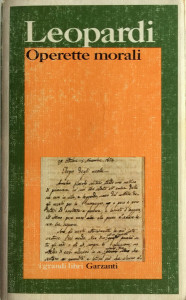 Il nostro desiderio di contentezza è tale, per Leopardi, da condizionare la stessa ontologia: non ogni essere, infatti, è desiderabile ma «il solo essere felice» (Dialogo di un fisico e di un metafisico, OM: 124). L’impossibilità della gioia sta però inscritta nella complessità del vivere sociale, nel nostro corpo, nella inevitabilità della distruzione che in un moto incessante sostituisce vite a vite, esseri a esseri senza che questo abbia un senso fuori di un eterno e gratuito avvicendamento. Il risultato è per gli uomini un continuo e assurdo oscillare fra il dolore e la noia, il cui ultimo esito è l’essere per la morte.
Il nostro desiderio di contentezza è tale, per Leopardi, da condizionare la stessa ontologia: non ogni essere, infatti, è desiderabile ma «il solo essere felice» (Dialogo di un fisico e di un metafisico, OM: 124). L’impossibilità della gioia sta però inscritta nella complessità del vivere sociale, nel nostro corpo, nella inevitabilità della distruzione che in un moto incessante sostituisce vite a vite, esseri a esseri senza che questo abbia un senso fuori di un eterno e gratuito avvicendamento. Il risultato è per gli uomini un continuo e assurdo oscillare fra il dolore e la noia, il cui ultimo esito è l’essere per la morte.
Se questa è una dinamica ontologica, e dunque universale, i più colpiti sono naturalmente gli enti consapevoli di essa: gli umani. Leopardi condivide con Byron, Schopenhauer, Cioran quel detto del Qohelet secondo cui il crescere del sapere è anche crescita del dolore. Questa idea ha tre conseguenze rilevanti. In primo luogo permette di distinguere all’interno del genere umano dei veri e propri livelli assiologici, il cui criterio di differenziazione è dato dalla coscienza del dolore. Per quanto negativa, questa rimane secondo Leopardi una prova di nobiltà rispetto alle masse stolte che forse soffrono meno degli individui consapevoli ma sono anche assolutamente incapaci di elevarsi a quella virtù, a quella dignità del vivere, che è uno dei molti valori positivi condivisi dallo scrittore. Contro la mediocrità, contro la rinuncia per debolezza ai progetti più degni, contro il conformismo delle menti, le Operette sono sempre esplicite e durissime.
Seconda rilevante conseguenza del leopardiano Sein zum Tode è l’orrore per qualunque idea di un eterno ritorno dell’Identico, prospettiva che viene rifiutata con chiarezza nel Dialogo di un venditore d’almanacchi e d’un passeggere. Piuttosto, Leopardi prende posizione per un materialismo radicale che vede nel mondo un continuo aggregarsi e sciogliersi di enti in cui ciò che rimane costante è solo la quantità di energia e di sostanza. Nel Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco leggiamo che «le cose materiali, siccome elle periscono tutte ed hanno fine, così tutte ebbero incominciamento. Ma la materia stessa niuno incominciamento ebbe, cioè a dire che ella è per sua propria forza ab eterno» (OM: 294). Così nel Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie si riascolta l’invito epicureo a non temere la morte poiché essa, quando arriva, non ci trova già più.
Terzo e più importante effetto dell’ontologia negativa di Leopardi è la lucida e costante opposizione a ogni antropocentrismo. L’infantile pretesa che il mondo sia stato fatto a esclusivo uso di una specie, che il volgere delle galassie e della materia sia finalizzato al progresso della vicenda umana; la dismisura antropocentrica, insomma, è deprecata da Leopardi con giusta ironia e a volte con ferocia. Prometeo riconosce di aver perduto la sua scommessa, di aver fatto un errore nell’esaltare le capacità dell’animale umano dato che il Sapiens è, sì, sommo ma «nell’imperfezione» (La scommessa di Prometeo, OM: 112). Il cavallo e il bue, dialogando dopo l’estinzione della specie umana, irridono alla credenza «che tutto il mondo consistesse nella loro razza» (Dialogo di un cavallo e di un bue, OM: 420) e che tutto «fosse fatto per loro» (Dialogo tra due bestie p.e. un cavallo e un toro, OM: 415). La Natura risponde, gelida, all’Islandese che «se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvederei» (Dialogo della natura e di un Islandese, OM: 155). E nella chiusa del Dialogo di un folletto e di uno gnomo quest’ultimo osserva che dopo la scomparsa degli umani «le stelle e i pianeti non mancano di nascere e di tramontare, e non hanno preso le gramaglie» (OM: 69). Leopardi si inserisce, così, in quella linea della filosofia europea che da Spinoza a Heidegger sottolinea la finitudine dell’umano, la sua natura effimera in un mondo che si muove e vive in assoluta indipendenza rispetto alle sue parti.
Nel modello antico e plurale delle Operette si condensa il coacervo e la pluralità di temi, riflessioni, domande che intrama lo Zibaldone. Opera i cui temi costanti e ricorrenti sono «la morale, la lingua o le lingue, le passioni e l’animo umano, la struttura cognitiva dell’uomo, la domanda metafisica e la memoria» (ZI, Cacciapuoti: XXVIII). Come si vede, questioni fondamentali e fondanti, che vengono affrontate da Leopardi anche come dispositivo di salvezza dal male intrinseco all’esserci. In particolare è la scrittura che salva, la scrittura limpida e densa che emerge dal manoscritto dello Zibaldone.
Un’opera, questa, che racchiude per intero Leopardi, al di là delle sterili distinzioni tra poesia, filosofia, cultura. Un’opera il cui senso ultimo è probabilmente l’indagine radicale e costante che Leopardi ha condotto, come abbiamo già visto, sull’«eternità e l’infinito di una materia che chiude le linee e i confini dell’universo: un universo finito ai confini del nulla che la stessa materia connota nella sua opacità, nel suo cieco divenire, nella sua agghiacciante indifferenza» (ZI, Cacciapuoti: LVIII). Leopardi conferma dunque che filosofia è anche guardare la Gorgone e non morire.
Le passioni
Trasformare la razionalità in una passione è il dispositivo che Spinoza indica e utilizza per cercare di essere e rimanere sereni nel caos amaro dell’esistenza. Analogo è lo sguardo che Leopardi esercita sul coacervo e sul labirinto delle passioni. Dato che la natura umana non può essere corretta e trasformata alla radice, le passioni costituiranno sempre il fondamento dei giorni. E per questo il modo migliore di viverle, se non proprio l’unico, è fare della comprensione razionale delle cose una passione profonda della vita.
Il risultato di tale esercizio è una fenomenologia delle passioni che analizza le più potenti e diffuse tra di esse a partire da quella fondamentale, che è l’amor proprio, vale a dire l’ancora una volta spinoziano conatus sese conservandi. Un amor proprio che non è un dato soltanto individuale e certamente non è questione morale ma è un elemento ontologico-materico. Il vivente umano ritiene infatti che tutto ciò che esiste ruoti in un modo o nell’altro intorno al proprio destino. Tesi analoga – ed è ulteriore conferma dei legami di Leopardi con questo filosofo – a quella discussa nell’Appendice alla I parte dell’Ethica. L’amor proprio antropocentrico diventa guerra, vendetta, compassione, invidia, pentimento.
La guerra è per Leopardi all’origine di tutti gli avvenimenti collettivi, non limitandosi essa all’umano ma essendo pervasiva di ogni vivente, con il nome di aggressività. Essa distrugge e piace, in quanto espressione di un sentimento profondamente inscritto nell’amor proprio: la vendetta. «Gli animi naturali», infatti «non provano nella vittoria altro piacere che quello della vendetta» (ZI, 3117,1; 11.8.1823: 85). Espressione di vendetta o anche della impossibilità di vendicarsi è l’invidia, passione fondamentale e fondante, «passione naturalissima, e primo vizio del primo figlio dell’uomo, secondo la S. Scrittura, è un effetto, e un indizio manifesto dell’odio naturale dell’uomo verso l’uomo, nella società, quantunque imperfettissima e piccolissima» (ZI, 1164,3; 13.6.1821: 49). Guardarsi dalla potenza e pervasività dell’invidia è per Leopardi così importante da indurlo a consigliare francamente di comportarsi in modo amabile con tutti e persino con disprezzo di sé, pur di «medicare una cagione d’odio che tu hai in te stesso e che gli altri non hanno: una cagione assoluta, che ti fa odioso per se sola, senza che tu sia nè ingiusto nè superbo nè ec.» (ZI, 197,1: 14).
Persino la compassione si genera dall’assenza di invidia, dal non poterla nutrire verso qualcuno la cui condizione è talmente miserabile e sofferente da renderlo immune da ogni gelosia. Sulla compassione la posizione di Leopardi è comunque oscillante e si muove tra da una parte il volerla ritenere l’unico slancio umano libero dall’amor proprio e dall’altra il sospetto che essa possa comunque avere «qualche fondamento nel timore di provar noi medesimi un male simile a quello che vediamo (Perché l’amor proprio è sottilissimo e s’insinua da per tutto e si trova nascosto ne’ luoghi i più reconditi del nostro cuore, e che paiono più impenetrabili a questa passione)» (ZI, 108,1: 8), sino a riconoscere – probabilmente con amarezza – che «l’atto della compassione è un atto d’orgoglio che l’uomo fa a se stesso», frutto anch’esso di amor proprio (ZI, 3107,1, 5.11.8.1823: 81).
 Più in generale, la società consiste per Leopardi in gran parte nella trasformazione della violenza originaria per la quale «naturalmente l’animale odia il suo simile» (PE, XLIX: 66), nella dissimulazione e nell’impostura che inducono ciascuno a mostrare sentimenti non reali per quieto vivere e soprattutto per ottenere dei vantaggi. Il filosofo sottolinea la necessità di tacere, di mantenere dentro di noi i nostri più reconditi pensieri; rileva la funzione del riso, il potere che deriva dalla capacità di ridere degli umani e fra gli umani; indica la necessità di una qualche forma di ‘iniziazione’ alla vita per fortificarsi, per diventare adulti. Tra queste la più diffusa e anche efficace è la passione amorosa poiché «all’uscire di un amor grande e passionato l’uomo […] conosce la natura e il temperamento proprio; sa la misura delle proprie facoltà e proprie forze» (PE, LXXXII: 92). E anche per questo gli umani così temprati riconoscono i propri limiti, esercitano la loro modestia non nei confronti di altri umani ma paragonandosi «continuamente, non cogli altri, ma con quell’idea del perfetto che hanno dinanzi allo spirito, infinitamente più chiara e maggiore di quella che ha il volgo» (PE, LXIV: 77).
Più in generale, la società consiste per Leopardi in gran parte nella trasformazione della violenza originaria per la quale «naturalmente l’animale odia il suo simile» (PE, XLIX: 66), nella dissimulazione e nell’impostura che inducono ciascuno a mostrare sentimenti non reali per quieto vivere e soprattutto per ottenere dei vantaggi. Il filosofo sottolinea la necessità di tacere, di mantenere dentro di noi i nostri più reconditi pensieri; rileva la funzione del riso, il potere che deriva dalla capacità di ridere degli umani e fra gli umani; indica la necessità di una qualche forma di ‘iniziazione’ alla vita per fortificarsi, per diventare adulti. Tra queste la più diffusa e anche efficace è la passione amorosa poiché «all’uscire di un amor grande e passionato l’uomo […] conosce la natura e il temperamento proprio; sa la misura delle proprie facoltà e proprie forze» (PE, LXXXII: 92). E anche per questo gli umani così temprati riconoscono i propri limiti, esercitano la loro modestia non nei confronti di altri umani ma paragonandosi «continuamente, non cogli altri, ma con quell’idea del perfetto che hanno dinanzi allo spirito, infinitamente più chiara e maggiore di quella che ha il volgo» (PE, LXIV: 77).
La tendenza sostanzialmente amorale dello Zibaldone viene confermata dal giudizio assai duro che viene formulato su una passione quale il pentimento. Se ogni altra sofferenza può scemare, il pentimento è un tarlo infinito, per il quale «non c’è riposo nè pace, e perciò è la maggiore o la più acerba di tutte le disgrazie» (ZI, 466,1: 25).
L’insieme di queste e di altre passioni conferma l’irrazionalità della vita, dell’esistere, del voler continuare a vivere. Conferma il disincanto per il quale «tolti i sentimenti religiosi, è una felice e naturale, ma vera e continua pazzia, il seguitar sempre a sperare e a vivere, ed è contrarissimo alla ragione, la quale ci mostra troppo chiaro che non v’è speranza nessuna per noi» (ZI, 183,3; 23.7.1820: 20).
Il naturale e tenace desiderio di felicità – che sempre ci accompagna sino a che siamo vivi – si scontra con l’ultima verità e il primo apprendimento: la morte. Dopo la quale nessuno crede in realtà che ci sia veramente qualcosa: «noi non crediamo naturalmente all’immortalità dell’animo; anzi crediamo che i morti siano morti veramente e non vivi; e che colui ch’è morto, non sia più» (ZI, 4277,1; 9.4.1827: 120).
Siamo così scettici sulla sopravvivenza di qualcosa di noi dopo la morte tanto da voler conservare a tutti i costi la vita, anche quando essa è diventata un grumo insensato di dolori e non c’è altro da attendere nel mondo. Suprema, per quanto comprensibile, forma dell’irrazionalità. Anche per questo bisogna appunto cercare di trasformare la razionalità nella passione più grande.
Non ebbe Leopardi «maggior piacere che leggere» (ZI, 4273,5; 6.4.1827: 236) ma dalla lettura e da se stesso trasse il piacere di scrivere, di pensare, di capire. E anche di disperare, e lamentarsi, e rifiutare l’esserci. Tutte forme del piacere e del bisogno umano di trovare in ogni cosa una qualche forma di gratificazione e pienezza. È vero dunque che «il fine dei pensieri e delle azioni dell’uomo è sempre e solo il piacere» (ZI, 2702,1; 20.5.1823: 223) poiché il vivente è questo che cerca, è questo che vuole, è questo che giorno dopo giorno lo induce ad accettare, desiderare, pensare di esserci ancora.
È anche in tale ‘biologismo’ che affonda il pensiero leopardiano, in una lode della ‘Natura’ che è assai più greca che roussoviana. È la stessa ragione per la quale Platone è un atleta e gli eroi greci sono i corpi dei greci: le loro statue, i loro guerrieri, i loro dèi. Anche a motivo del progressivo declino della corporeità Leopardi diventa critico della civiltà e del cristianesimo, poiché «è indubitato che la civiltà debilita il corpo umano […] i progressi della civiltà portano seco e producono inevitabilmente il successivo deterioramento del suo fisico, deterioramento sempre crescente in proporzione d’essa civiltà» (ZI, 3179,1 – 3180; 17.8.1823: 166). Per quanto riguarda il cristianesimo, esso ha distrutto la πόλις, la communitas, il vivere sociale, instillando la convinzione di un rapporto esclusivo, personale, ascetico e sostanzialmente egoistico con il proprio dio. Gli anacoreti sono un emblema della inimicizia cristiana verso l’intero. E naturalmente essi preparano e preludono alla tirannia dell’autorità nei confronti di una natura umana ridotta a individuo, soggettività, anima.
Un’anima la cui separazione dagli altri si radicalizza diventando odio di sé. Qui la forza antropologica del pensare leopardiano tocca un culmine. La tesi infatti è che non potendo più accusare il dio – gli dèi – delle proprie disgrazie e del male, gli umani rivolgano il loro risentimento verso se stessi:
«Noi che non riconosciamo nè fortuna nè destino, nè forza alcuna di necessità personificata che ci costringa, non abbiamo altra persona da rivolger l’odio e il furore (se siamo magnanimi, e costanti, e incapaci di cedere) fuori di noi stessi; e quindi concepiamo contro la nostra persona un odio veramente micidiale, come del più feroce e capitale nemico, e ci compiaciamo nell’idea della morte volontaria, dello strazio di noi stessi, della medesima infelicità che ci opprime e che arriviamo a desiderarci anche maggiore, come nell’idea della vendetta contro un oggetto di odio e di rabbia somma» (ZI, 503,1; 15.1.1821: 182).
Diversa, assai più distillata, matura e consapevole, è la solitudine nata e data dal pensare: «Ad ogni filosofo, ma più di tutto al metafisico è bisogno la solitudine. […] E se da prima egli era filosofo di società, da poi, contratto l’abito della solitudine, a lungo andare egli si volge insensibile. alla metafisica e finalm. ne fa il principale oggetto dei suoi pensieri e il più favorito e grato» (ZI, 4183, 3; 12.5.1825: 197-198). In questa solitudine il filosofo Leopardi apprende e sa che, nella condizione di gettatezza e di buio nella quale abitiamo, lo sperare è parte dell’errare, è il più tenace degli errori. E la vita fa di tutto «per riconciliarlo colle speranze, e cogli errori» (ZI, 1651,1; 8.9.1821: 201).
Vanamente però. Leopardi non cade nell’illusione. Rimane sempre consapevole che il vivere non è per nulla un fine in sé, che non è sacro, che il valere consiste nel come si vive o si cerca di vivere non nel che dell’esserci. Rimane consapevole che il nascere è un male, è il male del quale è necessario sùbito consolare colui che è venuto al dolore, tanto che
«così tosto come il bambino è nato, conviene che la madre che in quel punto lo mette al mondo, lo consoli, accheti il suo pianto, e gli alleggerisca il peso di quell’esistenza che gli dà. […] E in verità conviene che il buon padre e la buona madre studiandosi di racconsolare i loro figliuoli, emendino alla meglio ed alleggeriscano il danno che loro hanno fatto col procrearli. Per Dio! perché dunque nasce l’uomo? e perché genera? per poi racconsolar quelli che ha generati del medesimo essere stati generati? (ZI, 2607,1; 13.8.1822: 185).
Riflessioni e domande che trovano la loro espressione più compiuta in uno dei Canti fondamentali di Leopardi: «Prova pena e tormento / Per prima cosa; e in sul principio stesso / La madre e il genitore / Il prende a consolar dell’esser nato. […] Ma perché dare al sole, / Perché reggere in vita / Chi poi di quella consolar convenga? / Se la vita è sventura, / Perché da noi si dura?» (Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, CA: 135, vv. 44-47 e 52-56). In ogni caso, c’è una ragione ancora più profonda per il rifiuto della generazione, per ciò che nella filosofia contemporanea viene definito con il termine antinatalismo, e questa ragione è per Leopardi «non volere aumentare il numero dei malvagi» (PE, XIV: 33).
Tale la condizione umana, del tutto sottoposta al trionfo del tempo: «L’animo forte ed alto resiste anche alla necessità, ma non resiste al tempo, vero ed unico trionfatore di tutte le cose terrene. […] Si può ricusare la consolazione della stessa necessità, ma non quella del tempo» (ZI, 2419,2; 5.5.1822: 184). L’insignificanza della vita dentro il cosmo è confermata non soltanto dalla immensità del secondo e dalla infima piccolezza della prima ma anche dal fatto che gli enti che sono vivi esistono non per se stessi ma allo scopo di propagare la vita ad altri enti il cui obiettivo sarà di perpetuarla ancora. E così via nella nullità di ogni ente per ciò che è e per come è. I viventi sono macchine riproduttive, replicanti intrisi di contingenza. Carattere quest’ultimo che gli enti che sono vivi condividono con ogni altra modalità dell’esserci e che fa sì che ciò che è sia un lampo di essere dentro l’universale dominio del niente.
 «Tutto è relativo» (ZI, 451,1; 22.12.1820: 303) dentro «l’orribile mistero delle cose e della esistenza universale» (ZI, 4099,2; 3.6.1824: 437). Verità, queste, che dovrebbero risultare chiare alla passione del vivere e alla razionalità del pensare. E che Leopardi declina anche nel rifiuto della «ragione» rispetto alla «natura». Posizione politicamente accorta, poiché è vero che chi intende «geometrizzare tutta la vita» — come molti illuministi e francesi rivoluzionari – opera da stolto rispetto alla non raddrizzabilità della natura umana (ZI, 160,2; 8.7.1820: 258-259); ne fu consapevole anche un illuminista assai particolare come Immanuel Kant, per il quale «aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden», ‘da un legno storto quale l’uomo è fatto, non è possibile trarre nulla di perfettamente dritto’ [2]. È anche vero però che rimanere in una condizione di ignoranza ‘naturale’ serve assai «alla tirannia fondata sopra l’assoluta barbarie, superstizione, e intera bestialità de’ sudditi» (ZI, 252,1; 28.10.1820: 280). Tirannico o illuministico; naturale o razionale; contingente o necessario che sia, «tutto è male», come spiega una delle pagine più terribili e più potenti dello Zibaldone:
«Tutto è relativo» (ZI, 451,1; 22.12.1820: 303) dentro «l’orribile mistero delle cose e della esistenza universale» (ZI, 4099,2; 3.6.1824: 437). Verità, queste, che dovrebbero risultare chiare alla passione del vivere e alla razionalità del pensare. E che Leopardi declina anche nel rifiuto della «ragione» rispetto alla «natura». Posizione politicamente accorta, poiché è vero che chi intende «geometrizzare tutta la vita» — come molti illuministi e francesi rivoluzionari – opera da stolto rispetto alla non raddrizzabilità della natura umana (ZI, 160,2; 8.7.1820: 258-259); ne fu consapevole anche un illuminista assai particolare come Immanuel Kant, per il quale «aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden», ‘da un legno storto quale l’uomo è fatto, non è possibile trarre nulla di perfettamente dritto’ [2]. È anche vero però che rimanere in una condizione di ignoranza ‘naturale’ serve assai «alla tirannia fondata sopra l’assoluta barbarie, superstizione, e intera bestialità de’ sudditi» (ZI, 252,1; 28.10.1820: 280). Tirannico o illuministico; naturale o razionale; contingente o necessario che sia, «tutto è male», come spiega una delle pagine più terribili e più potenti dello Zibaldone:
«Tutto è male. Cioè tutto quello che è, è male; che ciascuna cosa esista è male; ciascuna cosa esiste per fin di male; l’esistenza è un male e ordinata al male; il fine dell’universo è il male; l’ordine e lo stato, le leggi, l’andamento naturale dell’universo non sono altro che male, nè diretti ad altro che al male. Non v’è altro bene che il non essere; non v’ha altro di buono che quel che non è; le cose che non son cose; tutte le cose sono cattive. Il tutto esistente; il complesso dei tanti mondi che esistono; l’universo; non è che un neo, un bruscolo in metafisica. L’esistenza, per sua natura ed essenza sua propria e generale, è un’imperfezione, un’irregolarità, una mostruosità. […] Il tutto esistente è infinitamente piccolo a paragone della infinità vera, p. dir così, del non esistente, del nulla» (ZI, 4174,2; 22.4.1826: 443-444).
L’umano come lingua
La riflessione metafisica di Leopardi è naturalmente inseparabile dalla sua passione per la lingua, dai suoi interessi filologici. Nei Trattati dedicati a questioni linguistico-letterarie, il filosofo si immerge dentro la scrittura, che è sempre necessaria, la ‘bella’ scrittura’, qualunque sia il tema che si analizza: «La scienza del bello scrivere è una filosofia, e profondissima e sottilissima, e tiene a tutti i rami della sapienza» (ZI, 2725,1; 28-30.5.1823: 553). Si immerge dentro la gratuità della bellezza e del significato, bellezza e significato che gli enti non hanno e che i corpimente attribuiscono, generano, plasmano: «Ogni libro ha l’obbligo di esser bello in tutto il rigore di questo termine» (ZI, 949,1; 16.4.1821: 469).
 Particolare attenzione Leopardi dedica alla canonica distinzione dei tre generi di poesia: lirico, epico e drammatico. I due modelli di potenza della lingua per Leopardi sono Omero per la letteratura universale, Dante Alighieri per quella italiana. E non soltanto per la vastità, l’ambizione, il pensiero che fonda e costruisce i loro poemi ma anche per l’assenza in essi dell’elemento sentimentale. Assenza completa nell’Iliade, marcata comunque nella Commedia. Anche su quest’assenza si basa per Leopardi la superiorità delle letterature e del vivere ‘antichi’ rispetto ai moderni. Il maggiore dei poeti romantici italiani era insomma un classicista. «Ne’ tragici greci (così negli altri poeti e scrittori antichi) non s’incontrano quelle minutezze, quella particolare e distinta descrizione e sviluppo delle passioni e de’ caratteri che è propria de’ drammi (e così degli altri poeti e componimenti) moderni» (ZI, 3428,1; 20.9.1823: 827).
Particolare attenzione Leopardi dedica alla canonica distinzione dei tre generi di poesia: lirico, epico e drammatico. I due modelli di potenza della lingua per Leopardi sono Omero per la letteratura universale, Dante Alighieri per quella italiana. E non soltanto per la vastità, l’ambizione, il pensiero che fonda e costruisce i loro poemi ma anche per l’assenza in essi dell’elemento sentimentale. Assenza completa nell’Iliade, marcata comunque nella Commedia. Anche su quest’assenza si basa per Leopardi la superiorità delle letterature e del vivere ‘antichi’ rispetto ai moderni. Il maggiore dei poeti romantici italiani era insomma un classicista. «Ne’ tragici greci (così negli altri poeti e scrittori antichi) non s’incontrano quelle minutezze, quella particolare e distinta descrizione e sviluppo delle passioni e de’ caratteri che è propria de’ drammi (e così degli altri poeti e componimenti) moderni» (ZI, 3428,1; 20.9.1823: 827).
Per Leopardi i Greci inventarono e utilizzarono una lingua pressoché perfetta, capace di accogliere ogni nuovo concetto, ente, esperienza, senza perdere nulla della propria struttura e limpidezza, come si vede ancor oggi, l’oggi di Leopardi e il nostro, per il quale valgono sempre queste riflessioni: «La lingua greca da’ suoi principii fino alla fine, non lasciò mai di arricchirsi, e acquistar sempre, massimamente nuovi vocaboli. […] Ogni scienza o disciplina nuova, comincia subito dal trarre il suo nome dal greco […] Evidente e palpabile l’onnipotenza immortale di quella lingua» (ZI, 735,1; 8-14.3.1821: 644-645).
Rispetto al greco e al latino, tutte le lingue europee moderne – tranne in parte il tedesco, che infatti a quelle lingue somiglia – «hanno bisogno d’assai più parole […] per significare una stessa cosa» (ZI, 2976,1; 16-17.7.1823: 783). Lingue dall’uso veramente flessibile e libero, non come frutto di ignoranza, superficialità e barbarie ma come esito di «perfetta scienza» (ZI, 704,1; 28.2.1821: 638).
Tutto questo e moltissimo altro sapeva Giacomo Leopardi, per il quale la lettura è stata il mondo. E anche per questo Leopardi è stato un saggio: «La lettura per l’arte dello scrivere è come l’esperienza per l’arte di vivere nel mondo, e di conoscere gli uomini e le cose. […] La lettura ha prodotto in voi lo stesso effetto dell’esperienza rispetto al mondo» (ZI, 222,2; 22.8.1820: 616-617).
Lo Zibaldone è anche una lunga riflessione rivolta a se stesso e al mondo, per fare di se stesso un luogo di lucida comprensione del mondo. Nelle sue migliaia di pagine la lucidità del filosofo si coniuga alla limpida eleganza del poeta e al dolente quotidiano della persona.
Ed emerge soprattutto la potenza emancipatrice – simile a quella di Spinoza e di Nietzsche – del pensiero leopardiano. Perché l’autore delle Operette morali e dello Zibaldone è «une figure réellement inactuelle et hérétique» [3]. Di quale eresia è eretico Leopardi? Della eresia gnostica, probabilmente. La Gnosi, infatti, si chiede « ‘D’où suis-je venu?’, ‘Où suis-je?’, ‘Où vais-je?’, c’est-à-dire: ‘Qu’étais-je?’, ‘Que suis-je?’, ‘Que serai-je?’. La ‘gnose’ est censée fournire la réponse commune à sette triple question, en dévoilant à l’individu son passé, son présent et son avenir» [4]. Queste sono le stesse domande che il filosofo Leopardi pone nelle sue opere e alle quali tenta di dare una risposta. Le stesse domande che intridono l’opera di un altro eretico, di un altro gnostico, al quale è possibile accostare il fecondo nichilismo leopardiano.
L’amoralismo di Camus è dello stesso genere infatti di quello di Leopardi. Esso sta nell’essere antinomico, étranger alla Legge, perennemente in rivolta contro di essa, una rivolta che può essere tessuta di suprema indifferenza, come quella di Mersault, la cui vicenda si svolge sotto un sole accecante che intride lo spazio, il cielo, i corpi. Un sole disumano e insostenibile, assai simile alla Natura protagonista di uno dei racconti fondamentali delle Operette morali. L’ateismo di Leopardi, di Nietzsche, di Camus è radicale, argomentato, compiuto. La morte di Dio è nelle loro pagine consumata sino in fondo e sino alla fine.
Al cappellano che vorrebbe redimerlo prima dell’esecuzione, Mersault risponde «qu’il me restait peu de temps. Je ne voulais pas le perdre avec Dieu» [5], non può perdere tempo con il dio biblico, un mauvais démiurge (Cioran), un cattivo facitore di dolore e di vuoto. Al di là della disperazione, della morte e del nulla, al di là dunque dei modi nei quali l’esistenza è gettata nel mondo, il monologo di Camus si consuma e si chiude con un grido di rivolta tipicamente gnostico, nel quale l’ultima parola – haine, odio – disegna in modo geometrico che cosa la vita sia, che cosa la vita meriti per chi intuisce l’altrove da cui proviene e il nulla nel quale si dissolve:
«Comme si cette grande colère m’avait purgé du mal, vidé d’espoir, devant cette nuite chargée de signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l’éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j’ai senti que j’avais été heureux, et qui je l’étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine» [6].
Per lo gnostico l’uomo che comprende e che in questa comprensione diventa straniero al suo mondo – come Leopardi rimase straniero a Recanati e in Italia – si può paragonare a una massa d’oro o a una perla che niente può contaminare. Lo disse anche Nietzsche in una delle sue potenti immagini: il saggio è come un mare che può accogliere ogni rifiuto senza subire alcun danno, assorbendolo e trasformandolo in luce della mente che comprende. Anche in questo consiste la filosofia di Leopardi.
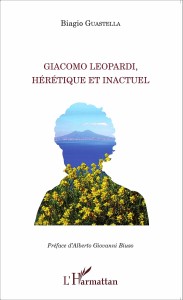 I limiti di Leopardi e il loro superamento
I limiti di Leopardi e il loro superamento
È quindi serio e consistente il contributo leopardiano alla filosofia intesa anche come riflessione antropologica ed esistenziale, non soltanto come metodo scientifico di indagine sulla natura e sulla storia. Tanto più che lo scrittore è perfettamente consapevole della propria strategia ermeneutica e dei suoi fini e rifiuta con grande lucidità la riduzione biografica che vorrebbe fare delle sue opere la mera conseguenza dei suoi malanni. A chi gli vorrebbe negare la qualità teoretica e l’oggettività dell’analisi, Leopardi così risponde: «malato o sano, calpesto la vigliaccheria degli uomini, rifiuto ogni consolazione e ogn’inganno puerile, ed ho il coraggio di sostenere la privazione di ogni speranza, mirare intrepidamente il deserto della vita, non dissimularmi nessuna parte dell’infelicità umana, ed accettare tutte le conseguenze di una filosofia dolorosa, ma vera» (Dialogo di Tristano e di un amico, OM: 377).
Poeta e filosofo è Leopardi, anche perché «il vero poeta è sommamente disposto ad esser gran filosofo, e il vero filosofo ad esser gran poeta» (ZI, 3382,2; 8.9.1823: 1064). Una filosofia che nelle sue tesi più feconde e plausibili affonda nel materialismo greco; nell’unità del corpomente; in un immanentismo che, come quello di Zarathustra, difende il riso e disprezza la rinuncia anacoretica che il cristianesimo introdusse nel pensare e nell’esistere. Lo scopo «diretto e immediato» del monachesimo, infatti, «si è d’impedire la vita. […] Macerazioni, perdite di sonno, digiuni, silenzio: tutte cose che unite insieme nocciono alla salute, cioè al ben essere, cioè alla perfezione dell’esistenza, cioè sono contrarie alla vita. […] Lo scopo dell’essenza del Cristianesimo, si è il fare che l’esistenza non s’impieghi, non serva ad altro che a premunirsi contro l’esistenza» (ZI, 2381,1; 2.2.1822: 997-998).
Quella di Leopardi è una filosofia del tutto consapevole della forza delle passioni, in particolare della passione amorosa, che quando afferra un umano fa sì che «tutto il mondo si dilegua dagli occhi suoi. […] Io non ho mai sentito tanto di vivere quanto amando, benché tutto il resto del mondo fosse per me come morto» (ZI, 59,1.2.3: 872-873).
Una passione che il filosofo sa essere (e lo dice decenni prima di Proust) inconsistente, allucinatoria, frutto del corpomente che ama e non di un oggetto d’amore reale, di una autosussitente sostanza amorosa, di una alterità che effettivamente esista: «Vagheggia / Il piagato mortal quindi la figlia / Della sua mente, l’amorosa idea» (Aspasia, CA: 155, vv. 37–39).
Una filosofia, però, che condivide anche gli aspetti più deboli del moderno quali sono l’eccesso del sentimento; un macerarsi voluto e consapevole nel negativo: «Mi diedi tutto alla gioia barbara e fremebonda della disperazione» (ZI, 107, 2: 880); il paradosso di una razionalità che, come tende a fare anche quella pascaliana (per fortuna frenandosi), ritiene che «il miglior uso ed effetto della ragione e della riflessione, è distruggere o minorare nell’uomo la ragione e la riflessione, e l’uso e gli effetti loro» (ZI, 1163,1; 13.6.1821: 934). Aspetti di decadenza, questi, che nulla hanno in comune con la sapienza e la saggezza elleniche e che rendono non poche pagine dello Zibaldone un amaro e sterile arrovellarsi sulla soggettività come dolore, dentro un narcisismo che si arrende al mondo sentito come banale e semplice negatività.
Altre pagine sanno invece andare al di là dell’individuo come presunzione e crocevia del reale e riescono ad attingere l’oggettività del nulla non come fremito psicologico dell’anima triste ma come sguardo forte e illuminato sull’intero che trascende senza misura la nullità della storia terrestre: «Tutto è nulla al mondo, anche la mia disperazione, della quale ogni uomo anche savio, ma più tranquillo, ed io stesso certamente in un’ora più quieta conoscerò la vanità e l’irragionevolezza e l’immaginario. Misero me, è vano, è un nulla anche questo mio dolore» (ZI, 72,3 [4]: 876).
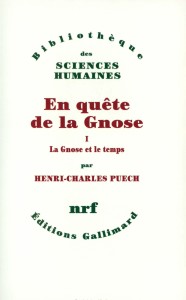 Di tale nulla oggettivo sono parte la nostalgia verso la materia inconsapevole e insensibile, che Leopardi chiama ‘sonno’, e la profonda saggezza della sottrazione di senso e valore anche negativi all’esserci umano. Il quale c’è e basta, come una delle miriadi di espressioni della materia perfetta. È quindi soltanto da una prospettiva parziale, da un punto di vista psicoantropologico, che «tutto è follia in questo mondo fuorché il folleggiare. Tutto è degno di riso fuorché il ridersi di tutto. Tutto è vanità fuorché le belle illusioni e le dilettevoli frivolezze» (ZI, 3990,2; 17.12.1823: 1110). Se il folleggiare, il ridere, l’illudersi sono risultato della ragione e del disincanto, allora diventano anch’esse luce. E conducono alla risposta che Leopardi dà alla domanda posta dal demone dell’eterno ritorno nel § 341 della Gaia scienza: «Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone» ti annunciasse il ritorno infinito di ogni evento vissuto, un ritorno ripetuto per sempre? A questa domanda Leopardi offre l’unica risposta plausibile, l’unica sincera, che non è quella di Nietzsche: «Io ho dimandato a parecchi se sarebbero stati contenti di tornare a rifare la vita passata, con patto di rifarla nè più né meno quale la prima volta. L’ho dimandato anco sovente a me stesso. Quanto al tornare indietro a vivere, ed io e tutti gli altri sarebbero stati contentissimi; ma con questo patto, nessuno. […] Vuol dire che nella vita che abbiamo sperimentata e che conosciamo con certezza, tutti abbiamo provato più male che bene» (ZI, 4283,8; 1.7.1827: 1179). Questa la solida base teoretica della risposta – identica – che il Passeggere dà al Venditore d’almanacchi che vorrebbe avere un’altra vita e non la vita esattamente vissuta sinora: «E si vede chiaro che ciascuno è d’opinione che sia stato più o di più peso il male che gli è toccato, che il bene; se, a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere» (Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere, OM: 369).
Di tale nulla oggettivo sono parte la nostalgia verso la materia inconsapevole e insensibile, che Leopardi chiama ‘sonno’, e la profonda saggezza della sottrazione di senso e valore anche negativi all’esserci umano. Il quale c’è e basta, come una delle miriadi di espressioni della materia perfetta. È quindi soltanto da una prospettiva parziale, da un punto di vista psicoantropologico, che «tutto è follia in questo mondo fuorché il folleggiare. Tutto è degno di riso fuorché il ridersi di tutto. Tutto è vanità fuorché le belle illusioni e le dilettevoli frivolezze» (ZI, 3990,2; 17.12.1823: 1110). Se il folleggiare, il ridere, l’illudersi sono risultato della ragione e del disincanto, allora diventano anch’esse luce. E conducono alla risposta che Leopardi dà alla domanda posta dal demone dell’eterno ritorno nel § 341 della Gaia scienza: «Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone» ti annunciasse il ritorno infinito di ogni evento vissuto, un ritorno ripetuto per sempre? A questa domanda Leopardi offre l’unica risposta plausibile, l’unica sincera, che non è quella di Nietzsche: «Io ho dimandato a parecchi se sarebbero stati contenti di tornare a rifare la vita passata, con patto di rifarla nè più né meno quale la prima volta. L’ho dimandato anco sovente a me stesso. Quanto al tornare indietro a vivere, ed io e tutti gli altri sarebbero stati contentissimi; ma con questo patto, nessuno. […] Vuol dire che nella vita che abbiamo sperimentata e che conosciamo con certezza, tutti abbiamo provato più male che bene» (ZI, 4283,8; 1.7.1827: 1179). Questa la solida base teoretica della risposta – identica – che il Passeggere dà al Venditore d’almanacchi che vorrebbe avere un’altra vita e non la vita esattamente vissuta sinora: «E si vede chiaro che ciascuno è d’opinione che sia stato più o di più peso il male che gli è toccato, che il bene; se, a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere» (Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere, OM: 369).
Detto in questo modo, detto giustamente in questo modo, si tratta dell’inevitabile, oggettivo, sereno risultato di un esercizio di razionalità e non di disperazione. Affinché il demone della nascita non prevalga ancora una volta, affinché sulla sua sconfitta si possa stendere la potenza del pensare, lo splendore della materia, della sua entropia, dell’«infinita vanità del tutto» (A se stesso, CA, v. 16: 153).
Dialoghi Mediterranei, n. 56, luglio 2022
Note
[1] Le opere di Giacomo Leopardi vengono citate con le seguenti sigle: CA, Canti, introduzione e note di Franco Brioschi, Rizzoli 1980; OM, Operette morali, a cura di Paolo Ruffilli, Garzanti, Milano 1982; PE, Pensieri, Mondadori, Milano 1993; ZI, Zibaldone di pensieri. Edizione tematica condotta sugli Indici leopardiani, Volume I, a cura di Fabiana Cacciapuoti, Donzelli, Roma 2018. I brani dello Zibaldone vengono citati con il numero generale, la data (dove esiste), il numero di pagina da questa edizione.
[2] I. Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico), «Berlinische Monatsschrift», novembre 1784, Sechster Satz: 398.
[3] B. Guastella, Giacomo Leopardi, hérétique et inactuel, L’Harmattan, Paris 2015: 17.
[4] H.C. Puech, En quête de la Gnose, I La Gnose et le temps, Gallimard, Paris 1978: 191.
[5] A. Camus, L’étranger, Gallimard, Paris 2011: 180.
[6] Ivi: 184.
______________________________________________________________
Alberto Giovanni Biuso, professore ordinario di Filosofia teoretica nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, dove insegna Filosofia teoretica, Filosofia delle menti artificiali e Epistemologia. È collaboratore, redattore e membro del Comitato scientifico di numerose riviste italiane ed europee. È direttore scientifico della rivista Vita pensata. Tema privilegiato della sua ricerca è il tempo, in particolare la relazione tra temporalità e metafisica. Si occupa inoltre della mente come dispositivo semantico; della vitalità delle filosofie e delle religioni pagane; delle strutture ontologiche e dei fondamenti politici di Internet; della questione animale come luogo di superamento del paradigma umanistico. Il suo libro più recente è Disvelamento. Nella luce di un virus (Algra Editore, 2022).
_____________________________________________________________