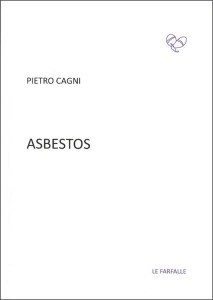di Enrico Palma
Nel panorama poetico catanese sono emerse due voci, il cui timbro e la cui coloritura si distinguono con estrema originalità. Voci comunque diverse, contraddistinte da un’indole poetica unica che renderebbe un confronto assolutamente sterile e infruttuoso. E tuttavia è dalla stessa città che esse sono germinate, Catania, piena di contraddizioni, storture, lacerazioni a stento risanabili, ma al contempo maestosa, caotica, vitale, intrisa di una saggia rassegnazione ma anche di un disilluso ottimismo, sferzata dal caldo estivo che riempie almeno per tre stagioni e raffreddata dalla coltre nevosa sul suo nume tutelare, la dea placida ma volubile, di cui avere timore e rendere grazie, la nostra montagna, idda, l’Etna.
Il loro poetare, il germinio dei loro versi, che è il venire al mondo in forma di parola del mondo stesso, nel logos che dà un senso al silenzio della carne, della memoria e del desiderio, che per i due poeti è però assordante e merita un ordine sillabico, fa capire meglio questa città, ne rende intelligibile l’abitare in essa. Catania che non è altro che metafora del vivere, di una sicilianità che nel bel mezzo del fatalismo e della luce annerita tra le rocce e sui palazzi storici sa intonare il suo canto. Cercherò allora di restituirne brevemente la partitura.
La poesia di Pietro Cagni è rarefatta, racchiusa in se stessa, metropolitana. Come il titolo della sua raccolta più recente mostra chiaramente: Asbestos (Valverde, 2022), l’amianto di Basquiat che nella denuncia sociale, e forse anche esistenziale, assurge qui a metafora dell’impuro della vita che però alcune sentinelle di oggi e di ieri riescono a diradare. Per Cagni sono Molly, la figlia, che è già stata nella fantasia di Goethe, di Bulgakov, di Joyce e dei Nirvana, e Alberto, il fratello, la cui mancanza è rinvangata con la memoria, il luogo dell’assenza in cui c’è ancora, aggettante sul presente e che reclama spazio, la consistenza di un corpo che il rimorso per le cose che si perdono in un sempre attuale – l’affetto, l’amore inestinguibile – vorrebbe ricostruire.
Una parola del corpo, fatta di braccia, mani, occhi che penetrano e che di rimando prelevano dalla carne il loro stesso desiderio che quella carne cela dentro di sé. Fatta di respiri che, evanescenti come le parole che danno loro un peso, diventano appunto materia affettiva, una fisica dell’amore. Molly, dentro sua madre, non era né Pietro né la madre, ma è «nell’aria / di tua madre che hai preso / e coagulato», nel tentativo di indovinarne la forma legando i propri occhi, nel trapassare con lo sguardo, a quella materia in cui la creatura si sta facendo da amore carne, si rende immagine del me nel te, del Dio che crea, sicché in questa Genesi mitica che sono il concepimento e la gravidanza si genera «un corpo che si muove». C’è tutto l’interrogare il mistero che soggiace all’evento della procreazione, di cui Cagni chiede «a quale nascita, a quale silenzio / dai direzione». Un fondo enigmatico a cui ogni padre consegna il suo respiro, il suo stesso essere, quell’alito di vita che dà tempo al tempo («dentro il fondo vivo il tuo respiro»).
Ci si prepara all’evento, allora, della nascita, e quegli stessi occhi che volevano sondare nel fondo del mistero ora si espandono per contenere la bellezza dell’arrivo («e si allargano le orbite per contenerti»). Ma lo sforzo non regge, poiché la meraviglia della vita-che-nasce è sempre un oltrepassamento, un tracimare di gioia, la vita che si congeda da sé nella più vita, concetto che Cagni condensa in un solo ma potente verso, riassuntivo di tutta la prima sezione: «sei oltre gli occhi, eppure dentro». È nella natura dell’eppure che la relazione padre-figlia, gioia incontenibile per cui cercare una misura, tra l’oltre e il dentro retti da un avversativo che non separa ma coniuga nella soluzione dell’affetto, restituisce il mistero della forma, del nulla che diventa essere, del fiat, della parola che crea, che si fa carne e vita. È una gioia che non ha abitudine ed eguali, perché, come chiosa Cagni, «niente sia come vederti arrivare», che è insieme monito e promessa, una festa della luce che non conosce tramonto.
Dall’assoluta presenza si va però all’assenza assoluta, quella del fratello, a cui nella dialettica della raccolta Cagni non si risparmia, ponendo se stesso, le sue presenze e le sue assenze, quelle che ripagano e quelle che trascinano nel pieno e nel vuoto, nella luce e nella notte, una toccante divaricazione che dal bagliore della nascita sprofonda nell’amianto della morte. La seconda sezione (alberto) è come un muro cittadino, graffiti, segni che a volte non si capiscono ma che pur ci sono, una parete contro un aldilà sconosciuto e insondabile e a cui la parola tenta di agganciarsi. L’essere morti per coloro che sono vivi e che piangono per loro è una saputa lontananza, ma sconosciuta, espressa dal sapere che afferma e nega a un tempo: «so che sei lontano. io non so niente». In mezzo il punto del confine, il limen mortis, una zona altrettanto misteriosa come quella da cui la vita si genera e in cui la vita anche scompare. Questo è anche asbestos, l’amianto doloroso che affanna il respiro dei vivi, di coloro su cui la morte ha lasciato un segno indelebile e che fa compiere ai lungs di Basquiat, ai polmoni, le cesure della durata esistenziale, quei salti che sono sia le incursioni nella memoria sia, purtroppo, i singulti del pianto. «dentro di me il dolore canta / come uno sguardo canta nelle ciglia», occhi che sono chiusi, che non sono più sotto le palpebre, e l’invocazione è affinché tornino nuovamente a esse («richiama gli occhi alle tue ciglia»).
C’è, inoltre, il desiderio incessante e inestinguibile di essere chiamati da chi non è più con la parola che ci definisce, il nostro segno a cui ci aggrappiamo e che è per altri, il nostro nome, che si vorrebbe sussurrato dalla voce dell’assenza nel compimento del suo ritorno. Solo un bisbiglio: «pietro (ecco la voce)», un sì «dal fondo buio del tuo respiro». Il pericolo è la fatalità del trapasso del ricordo, che anch’esso vada via, in un’amnesia protettiva o semplicemente necessaria alla vita in cui la parola poetica può trattenere, prendere posto proprio «tra le cose che non si ricordano». La parola e la vita, infatti, se unite insieme nella poesia, nel ricordo della morte e nella contemplazione dell’esserci, possono essere «corpoluce», il coagulo del tempo e il palpitare forte della vita laddove, nella notte d’amore, esso si fa finalmente udibile. Lì dove il buio, come la morte, diventa amico, in cui pronunciare, «nel fondale illuminato», il «vieni presto» del volto che salva, che è amante, fratello e figlia.
La poesia di Pietro Russo è invece avvinghiata alla terra, ma direi, più estesamente, agli elementi di quella città che ricordavo all’inizio, relazione viscerale e intima che il poeta struttura a partire dalla scelta del dialetto catanese, che è un affratellamento ancora più forte, una semantica dell’intimità, poiché quella è la lingua natìa, in cui e da cui si viene al mondo, come uomini e anche come poeti. La raccolta è un voler credere a un sogno, a un miracolo della natura e del sentimento, una dedica e anche un tributo all’immaginazione del bambino alla cui età Russo ritorna con la sapienza dell’oggi ma senza perdere la freschezza di quel tempo.
Eppuru i stiddi fanu scrusciu (Valverde 2022) eppure le stelle fanno baccano: dalla loro intoccabile lontananza, simbolo di purezza incontaminata rispetto alle tetraggini di rifiuti e di meschinità umane, giunge tuttavia il loro suono, creato più che percepito, il rumore del mondo nel quale si perdono i rivoli di luce che la poesia deve saper raccogliere e raggrumare in sé nel verso. Nel fragore della risata del figlio, in una sparizione totale del mondo spoglio di uomini, Russo chiede se essi stiano a sentire, se abbiano orecchie per udire, semplicemente se ci stanno, poiché «u munnu nascìu stamatina [il mondo è nato stamattina]». È con questa urgenza interiore, con la meraviglia d’essere che era già di Whitman e poi del Lévinas dell’epifania dell’essere nell’altro, che all’albeggiare della luce il mondo nasce ogni giorno come se fosse al suo primo giorno, un giorno ricordato ma gravido del futuro che ha ancora da essere, negli occhi ridenti di chi si è generato, nella possibilità del sé da consegnare all’altro.
È il voler essere espansione, estesi al punto da essere ogni cosa a contatto con chi si ama, con chi sta a cuore, nel mondo in cui si cade come si cade in amore «tu si n munnu e ju ci cascai ri intra [tu sei un mondo e io ci sono caduto dentro]». È un mondo particolare ma è il mondo di tutti, il mondo per me che diventa per noi e infine per tutti. Momenti in cui il giorno è più pieno, in cui la benedizione sembra arrivare ed essere alla portata del raggio di sole: «ci su uri / ca u jonnu pari chiù ranni / pari ca ora si fici [ci sono momenti / che il giorno sembra più grande / sembra appena creato]».
I versi più metafisici, quelli più filosoficamente intensificati, direi persino destinali, di una fiducia in cui credere e nell’estinzione dei quali si coglie un invito roboante e ostinato a opporsi, esprimono l’orizzonte di vita in cui il canto di magnificare le cose trova ricetto: «nuatri semu fatti p’a gioia / ccu è ca n’astutatu? / eppuru i stiddi fanu scrusciu [siamo fatti per la gioia / chi è che ci ha spento? / eppure le stelle fanno baccano]». Possiamo anche oscurarci, transitare per il buio e la tenebra, ma, suggerisce Russo, benché spenti c’è una luce che può restare non vista ma a cui non si può restare sordi, l’estremità più recondita del creato, che si mostra quando ogni fiducia sembra perduta. Anche qui, dunque, la forza dell’eppuru, dell’avversativo, è una forza che non nega ma che è positiva e benevola. Alla gente che se n’è andata, Russo preferisce allora la voce del vento, a cui consegna il suo mantra, il Leitmotiv del suo musicare, le stelle udibili in piena luce «a menzionnu [a mezzogiorno]» e soprattutto durante la notte («a notti, amici, è na cosa longa [la notte, amici, è una faccenda lunga»]. Lo sapeva già Céline che la notte è per i veri uomini, tali perché veri amatori della vita, e lo sapeva anche Thomas che la luce è un luogo ma che l’oscurità è il cammino per giungervi. Una strada, quando si era bambini, in cui c’era più luce («parìa chiù suli tannu [sembrava più sole a quel tempo]») e che adesso, nell’incontrare il tempo che passa in uno sconosciuto in cui ravvisare se stessi, è più flebile, portata via da quello stesso vento amico che però, nel turbinio degli anni, fa svanire.
Ma dove accade tutto questo? La voce poetica ha una localizzazione, è quella città-mondo di Catania che Russo descrive magnificamente. Una città divoratrice di occhi, di cuori, lo stare nella quale è difficile, tra macerie umane, rifiuti, criminalità. Una città che prosciuga i desideri e ti fa accontentare di ciò che c’è. Catania è rotta, dice Russo, e «non c’è versu r’abbissari na cosa rutta [non c’è modo di riparare una cosa rotta]», e se non esiste un verso-modo in grado di ripianare la ferita che è la città etnea, ciò vorrebbe forse dire che il verso come modo-poesia non possa farlo? È nell’aprirsi del cielo nell’ora in cui le cose si chiudono che la vera voce si alza («u cielu si rapeva ai sett’i sira / intra na casa troppu nica [il cielo si apriva alle sette di sera / dentro una casa troppo piccola]»).
Catania è torbida, nella sua decadente magnificenza attira alla vita come alla morte, e con un verso esattissimo Russo ne coglie uno dei tratti essenziali: «sta città avi niuru ca mpica [questa città ha nero che si appiccica]». Catania, la città sotto il vulcano e lavata dal sole e dal mare è la città della cenere, del nero che sgorga dalla terra, che è nella pietra delle strade cittadine, sulla malta dei palazzi, sul volto della gente nei mercati, nelle botteghe, nei quatteri, «sta città è na cosa tinta [questa città è cattiva]», poiché tinta, in siciliano, vuol dire proprio dipinta, di un nero sul nero che fa buie le cose, che strozza i giorni. L’umor nero della città te lo porti addosso, quindi, ma è il nero, come ricordato, in cui la luce può splendere più forte.
L’aria è la soluzione, la trasparenza in cui abitare, a cui attingere e verso cui dirigersi. L’aria da cui eravamo e in cui parliamo, l’aria che è la poesia per ribaltare tutto questo. E poi c’è il bacio, «l’ostia ri aria tra mia e tia [l’ostia d’aria tra me e te]». Viene in visita l’amore, o forse siamo noi a visitarlo, come i fiati e gli abbracci sotto gli alberi, nella gloria dei corpi nudi che nel buio trovano calore. Siamo fango e sangue, ma i catanesi in particolare sono cenere impastata col desiderio, e si legge nelle lavagne di scuola, come, sempre a Catania, nei muri. Quando il vento porta la cenere della montagna, essa chiede del nostro destino, e noi reagiamo, avendo lei dentro di noi, lei che ci ha fatti. Così Russo dice al ragazzo, a cui insegna chi siamo e da dove veniamo, di chiedere al vento cinereo delle genti in cui si è trovato a vivere: «ma unn’u ventu sbrizzìa ciniri / ddocu / veni a spiari ri nuatri [ma dove il vento sparge cenere / lì / vieni a chiedere di noi]». Bisogna chiedere alla cenere per strada, sui capelli, nelle scie del cielo sferzate dai venti chi noi siamo, esseri venuti dal mito e dalla caduta, da questa «matri scura [madre scura]» e «terra anniata [terra bagnata]», che è nostra, ma è anche quella di chi approda e di chi rischia per approdarvi.
La raccolta ha anche un’identità cosmica, essere terra ma anche pensiero che si avvede del suo posto nel mondo, che va oltre la città e le sue miserie, la gravità delle braccia che cadono a terra per i mali della vita che troppo e troppe volte fanno arrendere: «essere ciniri e terra / e l’universu ca fa uci intr’i vini [essere cenere e terra / e l’universo che urla dentro le vene]», essere anche gli elementi del vulcano, fuoco e cenere, e il suo boato, che per una vita si è imparato a riconoscere nell’orizzonte schiumoso in cui si incontrano cielo e terra e ove accade l’amore («sugnu n focu intra ri tia / sugnu ciniri / senti chi buddellu stamu facennu [sono un fuoco dentro di te / sono cenere / senti che bordello stiamo facendo]». La raccolta si chiude con un invito, con una consegna totale al creato, con un grazie finale che rimette le cose al loro posto, con la vita che ritorna alla terra, e da lì «nasciri chiù forti [nascere più forte]».
Dialoghi Mediterranei, n. 58, novembre 2022
____________________________________________________________________________
Enrico Palma, attualmente dottorando di ricerca in “Scienze dell’Interpretazione” presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, il suo progetto verte su un’ermeneutica filosofica della Recherche proustiana (tutor: Prof. A.G. Biuso; coordinatore: Prof. A. Sichera). Ha pubblicato saggi, articoli e recensioni per varie riviste, con contributi di filosofia ed ermeneutica («Vita pensata», «Discipline filosofiche», «InCircolo», «Il Pequod», «E|C»), letteratura («Diacritica», «SigMa», «Siculorum Gymnasium», «Oblio») e fotografia («Gente di fotografia»). Fondatore e redattore della rivista culturale «Il Pequod», le sue aree di ricerca sono la filosofia teoretica e l’ermeneutica letteraria.
_______________________________________________________________