di Emilio Milana
La prima menzione dell’odierno pesto genovese – inteso come un “battuto” di basilico, di aglio, di pinoli, di sale marino grosso con aggiunta di olio d’oliva, parmigiano e pecorino – è piuttosto recente e risale a una pubblicazione del gourmet genovese Giovanni Battista Ratto, La cuciniera genovese, edita a Genova nel 1865 dai fratelli Pagano. La ricetta così recita:
«Prendete uno spicchio d’aglio, basilico (baxaicö) o in mancanza di questo maggiorana e prezzemolo, formaggio olandese e parmigiano reggiano grattugiati e mescolati insieme e dei pignoli e pestate il tutto in mortaio con poco burro finché sia ridotto in pasta. Scioglietelo quindi con olio fine in abbondanza. Con questo battuto si condiscono le lasagne e gli gnocchi (troffie), unendovi un po’ di acqua calda senza sale per renderlo più liquido».
In Liguria, oggi, il basilico deve essere di Prà, l’aglio di Vessalico, i pinoli di Pisa e si pratica l’usanza di aggiungere alle trenette patate e fagiolini, cotti insieme alla pasta, ricercando qualità e leggerezza in tutti gli ingredienti, nel rispetto di una tendenza alimentare verso piatti meno calorici e meno cotti.
In un’epoca, caratterizzata da una voglia frenetica di internavigare e di scoprire radici e novità, molti si sono chiesti se mai il pesto possa vantare degli antenati. E così alcuni lo farebbero derivare dall’agliata (aggiadda in genovese) – una salsa europea popolare nel Medioevo, con un gusto dominante di aglio, usata per condire e conservare carni e pesci comunque cucinati e insaltate – altri lo farebbero risalire al moretum degli antichi romani – un impasto verde a base di formaggio, aglio e erbe aromatiche – la cui preparazione è bucolicamente descritta nel poemetto Moretum dell’Appendix Virgiliana, e nel De re rustica dell’agronomo romano Columella. E nel corso della ricerca non sono mancate le querelle, come quella con l’altrettanto famoso pistou provenzale, a cui i cugini marsigliesi vorrebbero dare la primogenitura.
Ne emerge l’impressione che il pesto genovese, anzi il “basilico genovese”, che i Liguri vedono felicemente sposato all’antica e diffusa “agliata”, stia diventando in questi ultimi tempi il simbolo antropologico di Genova. In realtà se scorriamo velocemente i ricettari regionali, gli scritti di cucina o altri documenti come atti notarili, rendiconti di spesa, resoconti di banchetti, dichiarazioni doganali etc, già a partire dagli inizi del secondo millennio, ci si può rendere conto che il basilico non ha mai avuto una forte valenza gastronomica nell’Italia settentrionale. Qui, nel passato, è stato utilizzato prevalentemente per i suoi valori medicinali o i suoi simbolismi religiosi. La regione invece in cui la “nobile” pianticella ha potuto essere apprezzata per le sue qualità organolettiche, mostrando una decisa connotazione mediterranea, è stata la Sicilia: la si ritrova in piatti siculo-arabi, siculo-francesi, siculo-spagnoli, tutti inventati sotto le molteplici dominazioni che si sono susseguite nell’Isola. La ritroviamo in alcune ricette del Liber de coquina, il più antico libro di cucina del Medioevo che si conosca, attribuito a Federico II che lo ha concepito e scritto alla corte di Palermo, antesignano dei “ricettari meridionali”, dei “ricettari toscani” e dei “ricettari veneti”. Nella ricetta 67, che riguarda una salsa, così si legge:
De sapore pro assaturis:
accipe basilicum et piper et tere in mortario et distempera cum agresta.
Et deficiente agresta, pone succum citranguli vel lumie [1].
 È doveroso, però, riconoscere che la sola attestazione di Giovanni Battista Ratto e l’assenza di una testimonianza scritta anteriore a La cuciniera genovese, non sono sufficienti a escludere la preesistenza di un “pesto genovese” prima dell’Ottocento. Chiariamolo con una considerazione. Nel corso del millennio passato, ingredienti come l’aglio, il basilico, e le erbe selvatiche in genere erano considerati propri di una cucina povera, non pregni di valore ostentativo come lo erano le spezie e lo zucchero. Le ricette che li coinvolgevano in primo piano non erano degne, pertanto, di essere riprese da quella letteratura gastronomica che, a partire dal Liber de coquina, si era sviluppata nel nord-Italia, fino al alla fine del 1700, attraverso la penna di Maestro Martino, di Platina, di Cristoforo da Messisbugo, di Bartolomeo Scappi e di altri.
È doveroso, però, riconoscere che la sola attestazione di Giovanni Battista Ratto e l’assenza di una testimonianza scritta anteriore a La cuciniera genovese, non sono sufficienti a escludere la preesistenza di un “pesto genovese” prima dell’Ottocento. Chiariamolo con una considerazione. Nel corso del millennio passato, ingredienti come l’aglio, il basilico, e le erbe selvatiche in genere erano considerati propri di una cucina povera, non pregni di valore ostentativo come lo erano le spezie e lo zucchero. Le ricette che li coinvolgevano in primo piano non erano degne, pertanto, di essere riprese da quella letteratura gastronomica che, a partire dal Liber de coquina, si era sviluppata nel nord-Italia, fino al alla fine del 1700, attraverso la penna di Maestro Martino, di Platina, di Cristoforo da Messisbugo, di Bartolomeo Scappi e di altri.
Questa sorta di cucina scritta, ricercata ed elegante, era risorta, agli inizi del Trecento, dopo un vuoto di secoli iniziato dal ricettario di Apicio della Roma imperiale, perché si era creata la condizione richiesta da un libro per essere scritto: quella di avere un destinatario. Che ora si identificava in una nuova classe sociale, fatta di imprenditori, di professionisti, di piccoli proprietari, di commercianti, di benestanti intellettuali, che si compiaceva di associare alla buona mensa il riconoscimento simbolico del proprio miglioramento sociale, legato al benessere delle nuove attività produttive e commerciali.
La nuova cucina scritta rispecchiava la volontà di esaltare la ricchezza o il potere del signore presso cui veniva praticata e, nello stesso tempo, la professionalità del cuoco che la realizzava. Proprio per questo tendeva a distaccarsi dalla cucina popolare – pur traendo da questa spunti e schemi – eliminando dal proprio repertorio ingredienti ritenuti non sufficientemente nobili perché inseriti nella lista quotidiana della spesa alimentare della gente plebea. Si trattava dei prodotti dell’orto, delle erbe selvatiche, delle frattaglie, della frutta secca e così via. Veniva di conseguenza a marcarsi la differenziazione tra una cucina dei ricchi e una cucina dei poveri. Solo a cominciare dall’Ottocento, con le nuove trasformazioni socio-culturali, si darà avvio, proprio come fatto dal Ratto, a una letteratura culinaria destinata anche a quelli che i prodotti dell’orto li utilizzavano tutti i giorni.
È noto che i componenti fondamentali del pesto provengono storicamente dall’area medio-orientale e che la loro diffusione lungo le coste del Mediterraneo sia avvenuta per opera dei Fenici già a partire dal XII secolo prima di Cristo. Se consideriamo che i primi empori commerciali fenici, dopo il Libano e la Siria e l’Egitto e la Grecia, furono quelli stabiliti nella Sicilia occidentale (Mozia, Palermo, Solunto), è lecito sostenere che, in questa parte della Sicilia, la cultura del basilico, dell’aglio, dell’olio d’oliva, della mandorla e del pecorino si sia ampiamente inserita e consolidata, molto prima che nella nordica costa ligure. Il sale, poi, nella fenicia Mozia è stato un punto di forza commerciale, molto sfruttato dai popoli del mare. Il passo, quindi, per arrivare al concepimento di un pesto da parte dei Siciliani è breve e, infatti, ne ritroviamo oggi uno a Trapani, molto simile al pesto genovese, con un denominatore comune formato da basilico, aglio, sale grosso marino e olio d’oliva. La diversità di quello trapanese consiste nella presenza delle mandorle al posto dei pinoli e nell’aggiunta, evidentemente postuma e consequenziale alla scoperta dell’America, del pomodoro. Quest’ultimo, oltre a conferire maggiore struttura ed effetto cromatico all’impasto, esalta e contiene nello stesso tempo, con la tendenza dolce e leggermente acidula della sua polpa, l’aromaticità del basilico e l’irruenza dell’aglio, mentre le mandorle aggiungono ancora morbidezza e completano l’opera sul fronte dei profumi con un sentore delicato e avvolgente.

Le busiati. Ricettari arabi dei secc. X e XI testimoniano la presenza in Sicilia di busiate essiccate per la lunga conservazione (L. Bolens. La cuisine andalouse, une art de vivre. XI-XIII siècle, Paris, 1990)
Questo pesto, oggi diffuso nei media sotto il nome di “pesto trapanese”, in realtà viene servito come pasta cu ll’agghia pistata (pasta con l’aglio pestato), in quanto utilizzato per condire i busiati, una sorta di pasta fresca ottenuta facendo avvolgere intorno a un ferretto (busa) un filo di impasto di farina e acqua. L’aglio è doverosamente quello rosso di Nubia; il basilico è quello siciliano a foglie piccole; l’olio d’oliva proviene dalle Valli Trapanesi DOP o dalla Valle del Belìce; le mandorle sono di Avola; il pecorino è quello siciliano DOP, non eccessivamente stagionato. Tradizionalmente il piatto è accompagnato da melanzane fritte o da pesce minuto fritto (viole, ritunni, cicirello).
A questo punto viene naturale avanzare l’ipotesi, credibile, sulla base dei dati prima ricordati: Il pesto genovese appare dopo quello trapanese! È doveroso sottolineare che non esiste ancora alcuna testimonianza scritta che comprovi questa conclusione, ma storicamente, logicamente, antropologicamente non può sostenersi il contrario. Anche perché non risulta che i Liguri, in questi due ultimi millenni di storia gastronomica, abbiano dato segni di “esportazione” dei loro stili o delle loro idee. Anzi si potrebbe dire che quando hanno potuto hanno “importato” nel loro repertorio, spacciandole poi come proprie, formule e creazioni culinarie che con la loro cultura non hanno niente da spartire.
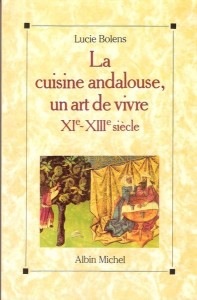 Prendiamo, per esempio, la farinata! In Liguria è un impasto di farina di ceci e acqua, ridotto in sfoglia e cotto al forno in una teglia ben unta di olio d’oliva. Si presta egregiamente come antipasto, bene abbinato a un vino bianco, fresco, frizzante e sufficientemente alcolico per contrapporsi all’unto rimasto in bocca. È comunemente riconosciuta come una preparazione “ligure”. Ma non è proprio così, perché il suo vero antenato è la “panella”, una sorta di frittella a forma piana triangolare, fatta con un impasto di farina di ceci e acqua, spolverata con sale e pepe. Venduta ancora oggi per le vie di Palermo e di Trapani, messa dentro un panino morbido, rientra in quella cultura della cucina fatta per strada, chiamata dei buffettieri dai tanto amati francesi dei Vespri Siciliani.
Prendiamo, per esempio, la farinata! In Liguria è un impasto di farina di ceci e acqua, ridotto in sfoglia e cotto al forno in una teglia ben unta di olio d’oliva. Si presta egregiamente come antipasto, bene abbinato a un vino bianco, fresco, frizzante e sufficientemente alcolico per contrapporsi all’unto rimasto in bocca. È comunemente riconosciuta come una preparazione “ligure”. Ma non è proprio così, perché il suo vero antenato è la “panella”, una sorta di frittella a forma piana triangolare, fatta con un impasto di farina di ceci e acqua, spolverata con sale e pepe. Venduta ancora oggi per le vie di Palermo e di Trapani, messa dentro un panino morbido, rientra in quella cultura della cucina fatta per strada, chiamata dei buffettieri dai tanto amati francesi dei Vespri Siciliani.
Questa cucina, in realtà, affonda le sue radici in quella Sicilia magno-greca di 2500 anni fa, quando bastava recarsi a un thermopolion per trovare pesciolini fritti in olio d’oliva punico e verdure crude o bollite, condite probabilmente con un fragrante pistu cu ll’agghia, e accompagnate da uno di quei quattordici tipi di pane che solevano prodursi nella Selinunte greca (da: I Deipnosofisti di Ateneo di Naucrati). La panella è punica e Trapani è stata punica per secoli fintantoché la potenza espansionistica di Roma non l’ha ridotta suo malgrado a provincia romana. Catone la chiama puls punica e così la descrive nel suo De agricultura, cap 85:
Pultem punicam sic coquito. Libram alicae in aquam indito, facito uti bene madeat. Id infundito in alveum purum, eo casei recentis P. III, mellis P.S., ovum unum, omnia una permisceto bene. Ita insipito in aulam novam.
La raccomandazione di cuocerla in una pentola nuova fa già pensare quanta considerazione avesse il Censore per questa farinata di ceci. Oggi la panella in Sicilia è servita anche con un buon champagne.
Veniamo poi alle trenette! Esattamente quelle condite con il pesto genovese. Questa pasta filiforme ha, con alta probabilità, i suoi natali in Sicilia, dove intorno al III secolo dopo Cristo, sotto la regia degli Ebrei, i Siciliani la ricavarono da una sfoglia di grano duro e la chiamarono tria, dal termine greco thrya, che vuol dire “giunchi filiformi”. Gli Arabi, quando arrivarono nell’ VIII secolo, adottarono il loro nome itriya, nel rispetto di una matrice lessicale tutta siciliana[2]. Non ci vuole molto a dedurre che trenetta provenga da tria. Anche i cosiddetti fidelini non sono proprio liguri, se si tiene conto che lo stesso tipo di pasta filiforme di grano duro è chiamato dagli ebrei fidaws, come attestano i trattati di gastronomia arabo-andalusi apparsi dopo il periodo di dominazione normanna in Sicilia. Ma i liguri non hanno preso dalla Sicilia solo l’idea delle “loro” trenette! Hanno preso anche l’idea di produrle, probabilmente osservandone il processo di produzione nelle industrie di Trabia, vicino Palermo, così come le aveva viste l’arabo Edrisi, geografo di corte di Re Ruggero, al tempo dei Normanni [3].
E arriviamo al cuscus! A Carloforte, fondata nel 1738 da una colonia di corallai liguri che provenivano dall’isoletta tunisina di Tabarka, dove si erano trasferiti nel XVI secolo, si fa il cascà, una variante del cuscus tunisino condito con verdure. Buona parte dell’informazione gastronomica sostiene che questo piatto abbia trovato dimora lungo le coste del Mediterraneo per opera dei Liguri. In verità è molto probabile che il viaggio del cuscus verso l’Occidente sia partito dalla Sicilia occidentale dove era approdato nel XII secolo, nella versione con carni o verdure ma non ancora col pesce. Quest’ultima versione appare a Trapani nel XVI secolo perché in questa città e in quest’epoca sono presenti nelle famiglie benestanti, come cuoche, molte schiave di colore, depositarie della cultura del cuscus delle aree sahariane e sub-sahariane. Sotto la spinta nord-africana partita dalle cucine e la regia dei signori di casa, nasce, quindi il cuscusu trapanisi. È da qui che questo piatto emigra verso l’Italia, verso la Francia e il vicino Oriente assumendo subito i connotati del simbolo, dell’icona, legata a valori dietetici, culturali, religiosi. Il caso isolato di Carloforte non può essere generalizzato e non può fare storia.
Storicamente è lecito pensare che Liguri e indigeni della Sicilia Occidentale siano venuti in contatto, probabilmente in tempi diversi. Osserviamone le motivazioni. Nel Belìce, la ridente valle che si estende tra Trapani e Palermo, più di tremila anni orsono vivevano gli Elimi, che insieme ai Sicani e ai Siculi furono i primi popoli che abitarono la Sicilia. La loro origine è ancora incerta: una versione che fa capo a Tucidide (V secolo a.C.) sostiene che gli Elimi furono un popolo nuovo formatosi per l’inserimento, nel tessuto culturale dei Sicani, di alcuni profughi troiani e focesi; un’altra versione che risale a Filisto di Siracusa (V secolo a.C.) porterebbe a considerarli Sicani, che maturarono una propria evoluzione sotto l’influenza dei Liguri, che, scacciati dalla loro terra dagli Umbri e dai Pelasgi ottant’anni prima della guerra di Troia, approdarono dal mare presso le costa trapanese. Quest’ultima versione sembrerebbe più attendibile se si tiene conto che il dato filisteo è correlabile alla straordinaria coincidenza toponomastica che lega i nomi delle tre città elime di Erice, Segesta ed Entella a quelli di tre antichi siti liguri, vicini tra di loro lungo la costa di levante: la cittadina di Lerici, il fiume Entella tra Chiavari e Lavagna, e la moderna Sestri Levante, il cui nome antico è Segesta Tigulliorum. È probabile quindi che questi contatti abbiano condotto allo scambio di consuetudini e usanze tipiche delle due genti, privilegiando magari l’influenza di quel popolo che al momento risultava più evoluto culturalmente.
 Non si vuole con questa analisi associare la paternità del pesto a una o all’altra delle due regioni. Non ha senso chiedersi chi abbia inventato il pesto, o anche l’agrodolce, o gli spaghetti … Sarebbe come chiedersi, nell’ambito filologico della nostra lingua, chi abbia creato la parola “amore” o l’espressione “ti amo”. Non c’è risposta semiologica sia dal punto di vista semantico che sintattico. Si può solo parlare, come si è fatto, di anteriorità, di comparsa anteriore o posteriore, nell’arena culinaria, di una creazione rispetto a un’altra dai contorni apparentemente simili. Di essi si può dire che sono espressioni della fantasia delle genti che li hanno diffusi e dello spirito che li accomuna. Se ne possono ricercare le originalità, le antecedenze, le peculiarità, nel segno della ricerca, della curiosità, della cultura, perché, come scriveva il grande Piero Camporesi, «non bisogna dimenticare che la cucina è arte combinatoria, di interpolazione più che di invenzione, i cui processi avvengono sotto il segno della variazione più che della creazione pura; e che la storia della cucina è fondamentalmente storia della morfologia delle pietanze di cui andranno individuati gli elementi variabili e quelli costanti» [4].
Non si vuole con questa analisi associare la paternità del pesto a una o all’altra delle due regioni. Non ha senso chiedersi chi abbia inventato il pesto, o anche l’agrodolce, o gli spaghetti … Sarebbe come chiedersi, nell’ambito filologico della nostra lingua, chi abbia creato la parola “amore” o l’espressione “ti amo”. Non c’è risposta semiologica sia dal punto di vista semantico che sintattico. Si può solo parlare, come si è fatto, di anteriorità, di comparsa anteriore o posteriore, nell’arena culinaria, di una creazione rispetto a un’altra dai contorni apparentemente simili. Di essi si può dire che sono espressioni della fantasia delle genti che li hanno diffusi e dello spirito che li accomuna. Se ne possono ricercare le originalità, le antecedenze, le peculiarità, nel segno della ricerca, della curiosità, della cultura, perché, come scriveva il grande Piero Camporesi, «non bisogna dimenticare che la cucina è arte combinatoria, di interpolazione più che di invenzione, i cui processi avvengono sotto il segno della variazione più che della creazione pura; e che la storia della cucina è fondamentalmente storia della morfologia delle pietanze di cui andranno individuati gli elementi variabili e quelli costanti» [4].
Sotto una sintesi ancora più generalista si può pensare che il “pesto”, non importa in quale delle sue forme, ligure o siciliana, o in quale del suo tempo di apparizione, rimane allocato all’interno di una famiglia gastronomica decisamente mediterranea, che possiamo definire quella delle “salse e zuppe fredde a base di aglio”, la cui base comune rimane costituita da una poltiglia di aglio crudo pestato insieme a sale, legata da olio d’oliva. L’aggiunta di determinati additivi ed eccipienti, raggruppati nelle classi degli aromatizzanti, degli acidificanti, degli addensanti (o fluidificanti) e delle verdure, conferisce poi all’impasto una connotazione precisa, con caratteristiche identitarie legate al paese di origine, alla sua storia, al suo clima, al suo stile. Parliamo della Lardiata (Sicilia), del Sarmurigghiiu (Sicilia), della Scurdalia (Sicilia), dell’Agliata (costa tirrenica italiana), del Salamureci (Trapani), dell’Aïoli (Provenza), dell’Allioli (Catalogna), del Tarator (Libano, Turchia, Egitto, Africa sett.), dello Tzatziki (Grecia, Bulgaria, Armenia, Turchia), del Gazpacho (Andalusia), del Salamorejo (Andalusia, Cordova), dell’Ajoblanco (Andalusia, Granada, Malaga). Di solito l’aggiunta dell’addensante regola la consistenza delle salse, mentre il fluidificante indirizza verso le zuppe. Il basilico e l’origano, come aromatizzanti, dominano nelle preparazioni italiane, conferendo colorazione verdastra e profumi esaltanti. Uovo e varietà di verdure si trovano nelle “freschissime” composizioni di gazpacho spagnolo, dall’aspetto delicatamente rosato. L’acidificante yogurt, al posto del sicilianissimo limone, dà una bianca consistenza allo tzatziki greco, turco, armeno. Il pomodoro farà la sua parte, dopo la scoperta dell’America, solo nei paesi che hanno avuto una lunga influenza araba: la Spagna e l’Italia. Molto probabilmente le cucine che ne sono derivate, la Ispano-araba e la Siculo-araba, avevano maturato quei presupposti di “concordanza” e di “contrapposizione” verso la solanacea americana, necessari al raggiungimento di una equilibrata sensazione organolettica. Questa raccolta di preparazioni si può sinotticamente riassumere in una tabella, in cui associando le caratteristiche degli ingredienti e curando una disposizione logica delle voci è possibile evidenziare significati e nessi, difficilmente percepibili attraverso individuali ed estemporanee degustazioni.
Proveniente dal Kirghizistan quattromila anni fa, l’aglio, malgrado la sua salda associazione all’alimentazione contadina e marinara e una pesante acredine, è riuscito a diffondersi in tutte le mense. Bistrattato, come spezia, dai raffinati, dallo stesso Maometto e da insigni voci dell’antichità come Orazio, ha finito con l’istituire, insieme ad altri ingredienti, un’equivalenza simbolica con la cultura culinaria del Mare nostrum, stabilendone di fatto un’immagine unitaria.
Sotto questa luce non sarebbe fuori luogo, in conclusione, ipotizzare una cucina franca mediterranea come “espressione di unità”, estesa a tutti i paesi che si affacciano nel bacino del Mediterraneo, così come è successo per la lingua franca mediterranea [5] in seguito alle Crociate. Entrambe devono la loro spontanea apparizione alla rete di condivisione e di reciproco scambio, che da tre millenni a questa parte si sono istituiti tra i popoli civili del Mare nostrum. Questa cucina franca, così introdotta, non condivisibile con la dieta mediterranea, di per sé evanescente e dieteticamente insignificante, ha saputo mantenere distinte le sue preparazioni con connotati chiaramente legati alle identità locali, e conservare una matrice comune di ingredienti che hanno un preciso riferimento al Mediterraneo, con la sua storia e la sua cultura.
Dialoghi Mediterranei, n. 54, marzo 2022
Note
[1] Sul sapore [da dare per migliorare] gli arrosti: aggiungi basilico e pepe, e pesta in un mortaio, e amalgama [il tutto] con agresto. Se manca l’agresto, metti del succo di limoncello o di lumie [di Sicilia].
[2] Su questa pista siculo-ebraica delle origini della pasta filiforme si veda: Emilio Milana, La scia dei tetraedri, Ravenna, Ed. Montanari, 2008: 169-172.
[3] Al Edrisi, Il libro di Re Ruggero, a cura di Michele Amari, Roma, Ed. Salviucci, 1883: 38.
[4] Piero Camporesi, Introduzione a: Pellegrino Artusi, Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, Torino, Einaudi, 2018.
[5] Per lingua franca mediterranea, detta anche sabir, si intende un idioma di servizio parlato in tutti i porti del Mediterraneo tra l’epoca delle Crociate e tutto il XIX secolo, anche se probabilmente dovettero esistere lingue franche in epoche precedenti. La più diffusa e persistente era costituita da un lessico al 65-70 % italiano, al 10% spagnolo e per la restante parte da parole di altre lingue come arabo, siciliano, catalano, sardo, greco. La parlavano i commercianti marittimi, anche gli schiavi di Malta, i corsari del Maghreb e i fuggitivi europei che trovavano riparo ad Algeri. Il primo documento in lingua franca risale al 1296: si tratta del più antico portolano relativo alla totalità del Mediterraneo, intitolato Compasso da Navegare (vd. Cifoletti Guido, La lingua franca barbaresca, Roma, Ed. Il Calamo, 2011)
_____________________________________________________________
Emilio Milana, egadiano, ingegnere optoelettronico, vive tra Bologna e Marettimo. Ha scritto opere sulla storia della cucina, dell’alimentazione e dell’archeologia dell’arcipelago. Tra le sue pubblicazioni: La scia dei tetraedri. Nel mare gastronomico delle Egadi, premiato al Premio Bancarella (Pontremoli 2009), Hiera fu cartaginese?, un’accurata analisi sui siti archeologici rinvenuti dall’autore a Marettimo, comprovante la frequentazione fenicio-punica dell’Isola come una “stazione di servizio” nel mare Mediterraneo.
______________________________________________________________









