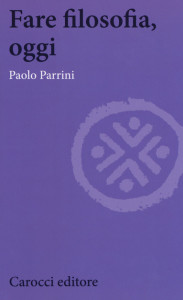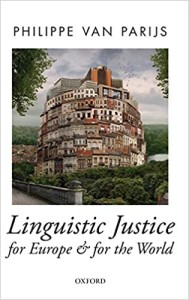di Neri Pollastri
Invadenza molesta
Recentemente, leggendo Fare filosofia, oggi, l’ultimo libro pubblicato in vita dall’epistemologo Paolo Parrini, uno dei miei maestri, mi sono imbattuto, in nota, in una considerazione sulla “americanocentrismo” della comunità accademica statunitense e sul più generale tema della centralità della lingua inglese nella ricerca filosofica contemporanea, un argomento, vi si leggeva, «che ha anch’esso a che vedere, seppure marginalmente, con il fare filosofia oggi» [1]. Sul tema Parrini rinviava a un articolo che lo trattava specificamente, a firma del filosofo tedesco Gereon Wolters [2], osservando che se l’atteggiamento degli studiosi statunitensi si poteva capire, «meno comprensibile è l’americanocentrismo o l’anglocentrismo degli analitici e filoanalitici di casa nostra» [3].
La cosa mi ha colpito, in quanto da un lato conferma ai più alti livelli ciò che osservo da tempo nel campo, un po’ di nicchia, entro il quale mi muovo sul piano internazionale – quello delle “pratiche filosofiche” – mentre da un altro è connesso al ruolo ricoperto oggi dalla lingua inglese, invadente a causa della sua (indiscutibile) utilità, ma anche occultamente influenzante una molteplicità di aspetti del mondo contemporaneo.
L’invadenza della lingua inglese la conosciamo bene tutti, visto che la incontriamo continuamente nella quotidianità, ove l’uso ricorrente di termini come spread, stakeholder, stepchild adoption, bail-in, team manager, recovery plan e mille altri ci costringono a evoluzioni mentali delle quali non si comprendono le ragioni: chi le usa non conosce la lingua italiana? Oppure si tratta di un elitario snobismo esterofilo, un po’ come nell’Ottocento l’abuso della lingua francese? In realtà, spesso si ha l’impressione che l’uso di tali espressioni sia dovuto soprattutto a una doppia intenzione mistificatoria: non far capire bene a chi ascolta ciò di cui si parla e nascondere il fatto che neppure il parlante sa bene di cosa stia parlando. Comunque sia, l’abuso degli anglicismi produce opacità e incomprensioni, le quali non sono mai una cosa positiva, anzi, alla lunga portano necessariamente a conseguenze spiacevoli per gli oggetti denotati. Da questo punto di vista è emblematica la degenerazione causata dalla lingua inglese a uno degli oggetti del campo di cui ho esperienza diretta – appunto il microsettore delle pratiche filosofiche – ovvero a ciò che in Italia viene chiamato “consulenza filosofica”.
Le pratiche filosofiche raccolgono attorno a loro una comunità internazionale di persone che, nel mondo, studiano o danno luogo ad attività quali la consulenza e il counseling filosofici, la Philosophy for Children, il “dialogo socratico”, i Cafè Philo e quant’altro si possa pensare ed esercitare per e con non filosofi, all’esterno dei tradizionali istituti di ricerca e formazione. Questa comunità si incontra più o meno ogni due anni in appositi convegni, le International Conference for Philosophical Practice, la cui sede itinerante è decisa di volta in volta – l’ultima è stata nel 2018 in Messico, la successiva, prevista a San Pietroburgo, è saltata causa covid-19 e si è svolta a distanza. Essendo autorganizzate, la partecipazione è a proprie spese e la presenza di madrelingua inglesi (NES, cioè Native English Speaker) di solito è tutt’altro che preponderante: a parte un numero quasi mai elevato di statunitensi e qualche canadese, sono rari gli inglesi e pressoché assenti gli australiani. Tuttavia, come avviene quasi ovunque – dai convegni scientifici alle fiere internazionali di attrezzi agricoli – l’inglese è sempre la lingua ufficiale dell’incontro, solo in taluni casi affiancata da quella del Paese ospite.
Le International Conference, però, non sono mere passerelle in cui si leggono alla platea articoli scritti a casa o si mostra la propria mercanzia ai possibili acquirenti: in esse perlopiù si condividono esperienze attraverso attività laboratoriali (workshop). Purtroppo, però, le esperienze da condividere sono sempre di tipo dialogico e perciò l’oggetto dei laboratori è un contenuto di pensiero espresso linguisticamente: in genere, questioni problematiche poste all’attenzione e poi sviluppate filosoficamente dai partecipanti; questo fatto ha per conseguenza che l’impiego di una “lingua franca” – qual è l’inglese – la padronanza della quale è estremamente diversificata e che alla fin fine quasi nessuno conosce veramente bene, porta a impoverire drammaticamente il lavoro che vi si svolge. Al punto che – lo dice uno che ha partecipato a quattro di queste manifestazioni, una delle quali organizzandola e coordinandola in prima persona – possono legittimamente sorgere persino dei dubbi in merito all’effettiva qualità sia di ciò che viene fatto, sia di chi lo fa: detto diversamente, si finisce col pensare che la competenza di chi propone i laboratori sia davvero modesta.
Si potrebbe obiettare che questo fenomeno dipenda in primo luogo proprio dalla scarsa competenza linguistica di chi partecipa e che ciò non accada a più alti livelli, ma non è così: al contrario di quanto spesso si pensa (e credono anche coloro che partecipano ad attività internazionali ad alti livelli), esistono autorevoli studi empirici di neurologia cognitiva in grado di dimostrare che un’elevata competenza linguistica tra i non madrelingua (NoNES) sia possibile solo quando questi abbiano appreso la seconda lingua prima dell’età di cinque anni [4]; in caso contrario, nel non madrelingua permangono lacune riguardo al lessico, alla comprensione delle strutture grammaticali complesse e alla ricchezza delle associazioni di concetti, ovvero proprio alcune delle principali competenze necessarie per svolgere adeguatamente un lavoro filosofico, specie se oralmente.
Ma non basta: anche in questo settore di nicchia vige quel che osservavamo stigmatizzare da Parrini, cioè una centralità indiscussa di quanto venga veicolato attraverso la lingua inglese. Lo dimostrano emblematicamente le vicissitudini della “pratica filosofica” che ha avuto nel mondo maggiore risonanza, la Philosophische Praxis di Gerd Achenbach. Nata in Germania e ivi denominata, nella lingua locale, con un’inusuale locuzione che significava “professione filosofica” [5], quest’attività è stata poi denominata in inglese philosophical counseling, appellativo che però l’ha fatalmente portata a legarsi con l’universo delle psicoterapie [6], in radicale critica con le quali era invece nata [7]. Tale legame è cresciuto progressivamente con il passare degli anni, in quanto coloro che si avvicinavano alla pratica, fossero o meno madrelingua inglesi, lo facevano attraverso la letteratura in “lingua franca”; ma, poiché in inglese gli scritti di Achenbach (e dei suoi principali epigoni, quasi tutti tedeschi) non sono mai stati tradotti [8], persino alcune delle personalità più in vista del “movimento” delle pratiche ha finito per mostrare nei propri scritti di non conoscerne il pensiero e, spesso, di travisarlo completamente a causa di una conoscenza lacunosa e non di prima mano. Si è in tal modo con il tempo prodotta una vera e propria frattura tra chi fa riferimento alla originaria tradizione tedesca, perché in grado di leggerla in lingua originale, e chi invece a quanto veicolato dalla letteratura in “lingua franca”, senza che a questi ultimi siano neppure ben chiare le ragioni del contendere [9].
Le conseguenze di una tale drammatica situazione sono così arrivate fino in Italia, dove la denominazione della pratica “originaria” in realtà era stata quasi subito distinta da quella anglosassone, con la scelta dell’espressione “consulenza filosofica” – fino ad allora priva di significato – proprio per tenerla lontana dal counseling, che anche qui da noi ha la sua collocazione tra le professioni di aiuto; tuttavia, la prevalenza internazionale dell’espressione counseling filosofico e la snobistica predilezione da parte dei media per l’uso di un termine esoticamente accattivante e – soprattutto! – anglofono, hanno fatto sì che anche la consulenza filosofica sia stata da noi avvicinata alle psicoterapie e alle professioni d’aiuto, fino al punto di confondere le due ben diverse pratiche e far pensare a taluni persino che siano la medesima cosa.
Del resto, lo stesso uso del termine counseling, in particolare quando accoppiato all’aggettivo “filosofico”, è emblematico del rischio che si corre abusando degli anglicismi nella lingua italiana. Nell’usarlo, infatti, i più (magari anche convinti di avere una buona conoscenza della lingua inglese) ritengono superfluo distinguerlo dall’italiano “consulenza”, del quale a loro parere nel nostro idioma sarebbe sinonimo; ma non è affatto così, visto che in inglese “consulenza” si traduce o con i generici “consultation” e “advice” o, in ambito aziendale, con “consulting”, mentre counseling anche in inglese indica specificamente la pratica psicoterapeutica messa a punto negli anni Cinquanta del Novecento da Carl Rogers e Rollo May.
L’uso che ne viene fatto in Italia, dunque, è dovuto proprio alla diffusa incompetenza riguardo alla lingua inglese: se si conoscesse il reale significato dei termini, si eviterebbe di farne uso a sproposito. Un’incompetenza che trasmette poi le proprie nefaste conseguenze all’oggetto denominato, che si trasforma indebitamente in qualcosa d’altro, nell’inconsapevolezza non solo di chi ascolta, ma persino di chi lo manipola linguisticamente in modo così maldestro.
Non saprei dire se anche nella ricerca filosofica tradizionale si verifichino fenomeni analoghi, ma l’unico esempio riportato nel suo articolo da Wolters fa purtroppo pensare di sì. L’esempio è tratto dal prestigioso The Cambridge Dictionary of Philosophy [10] e concerne la sua voce “Empirismo logico”, stilata da Richard A. Fumerton, professore emerito all’Università dell’Iowa; analizzandola, si evince che questa corrente filosofica abbia radici esclusivamente britanniche, quando chiunque sa che essa invece nacque e si sviluppò attorno a un gruppo di personalità che si riunivano nella “Ernst-Mach-Gesellschaft”, detta anche – e non per caso – “Circolo di Vienna”. Questa sconcertante falsa notizia storica, osserva Wolters, non è lì a causa di una svista, essendo sopravvissuta alla seconda edizione del Cambridge Dictionary «senza essere stata corretta dal curatore, Audi, o da nessuno dei 28 “consulenti editoriali” (…). Piuttosto, essa sembra essere un indicatore di ciò che la “globalizzazione” anglofona ha in serbo per la filosofia in generale e probabilmente per altre parti degli studi umanistici» [11]. A tali esiti è infatti inevitabile giungere se non si pongono adeguate compensazioni e rimedi alle asimmetrie prodotte dalla priorità inconsapevolmente assegnata a tutto ciò che viene veicolato dalla “lingua franca” rispetto a quanto invece redatto in una delle oltre cento lingue parlate nel mondo – due delle quali, cinese e spagnolo, con ben più madrelingua dello stesso inglese.
Tali asimmetrie – sostiene Wolters riferendosi all’ambito filosofico-scientifico, ma alludendo in generale a tutta la cultura – concernono tre ambiti: le pubblicazioni, le risorse e i gruppi. Riguardo alle prime, non solo ormai gli articoli scritti in lingue diverse dall’inglese non vengono presi in considerazione su scala internazionale, ma soprattutto le principali riviste accreditate hanno redazioni composte quasi esclusivamente da madrelingua inglesi. Questa prima asimmetria è poi causa delle altre due, in quanto comporta da un lato che i non anglofoni che vogliono far valere le proprie idee a livello internazionale siano costretti a farsi tradurre i propri lavori, con un peso economico e di tempo raramente sostenibile, dall’altro che gran parte di loro, a causa dei pochi articoli pubblicati, abbiano un modesto livello di accreditamento e che lo abbiano di conseguenza basso anche le università e gli istituti nei quali operano [12]. In proposito Wolters riporta l’impressionante elenco del prestigioso QS World University Ranking riguardo ai migliori dipartimenti di filosofia del mondo nel 2015: su 50, 36 erano in Paesi anglofoni, mentre il primo non anglofono – la Sorbona di Parigi – figurava solo al ventunesimo posto.
Queste asimmetrie originano in tal modo un vizioso processo autoriproduttivo, entro il quale un ristretto numero di studiosi, riviste ed enti, tutti rigorosamente anglofoni, finiscono per accreditarsi reciprocamente, a danno dei non anglofoni, dando vita a quello che Wolters chiama “campanilismo globalizzato”. Un fenomeno che all’indubbio vantaggio collettivo dell’avere una “lingua franca” con la quale comunicare su piano internazionale affianca una diffusa ingiustizia linguistica globale, come la chiamava già dieci anni orsono Philippe Van Parijs [13], che ne fa pagare il prezzo solo ed esclusivamente ai “non madrelingua franca”, e un impoverimento dei campi d’interesse della ricerca internazionale, che si concentra solo su ciò che interessa gli anglofoni e trascura quasi completamente ciò cui si dedicano i non anglofoni. Riguardo al primo aspetto, è emblematico e paradossale il dato, ai più ignoto, che mentre tutto il mondo coltiva le lingue straniere, ovviamente con la priorità dell’inglese, in Inghilterra dal 2004 «ai bambini britannici dell’età di quattordici anni nelle scuole statali è permesso di abbandonare del tutto le lingue straniere», apprendere le quali è evidentemente «ritenuto una perdita di tempo» [14]. Riguardo al secondo, invece, è indicativo il breve elenco proposto da Wolters di argomenti che occupano la filosofia della scienza europea nel quasi totale disinteresse delle principali riviste del settore, ovviamente anglofone [15].
Va da sé, come riconosce lo stesso Wolters, che per rimediare a questa situazione, superando le asimmetrie del “campanilismo globalizzato” e ristabilendo una “giustizia linguistica”, non è possibile avvalersi né dell’eliminazione della lingua franca, né della sostituzione in tale ruolo dell’inglese con un’altra lingua: nel primo caso, perché uno strumento comunicativo universale ci è ormai indispensabile; nel secondo, perché una sostituzione consensuale, se anche fosse accettata – cosa del tutto improbabile – sarebbe lunga e onerosa (anche a dispetto del fatto che lo spagnolo vanta comunque già oggi cento milioni di madrelingua in più e il cinese oltre il doppio dell’inglese), e comunque muterebbe solo la titolarità dei privilegi, senza eliminare il sistema sperequato. Né ha oggi gran senso riprendere ideali del passato, quale per esempio quello dell’esperanto come “neolingua universale”. Resta invece aperta la possibilità che il posto di lingua franca venga preso dal cinese, non però per consenso e convenzione, bensì più o meno attraverso la medesima causa che in passato ha permesso l’affermazione dell’inglese: la forza economica, capace di costruirsi un’egemonia anche culturale. Ma tale possibilità, oltre essere anch’essa un mero cambio di titolarità dei privilegi, solleva anche ben altre inquietudini ed è pertanto tutt’altro che auspicabile. No, un intervento correttivo, a mio parere, sembrerebbe poter passare solo da tre canali: dal “temperamento” culturale del campanilismo; dall’introduzione di contrappesi che ne riequilibrino le asimmetrie; infine, dalla sottrazione delle lingue madri a quel processo di anglicizzazione a cui tutte, quale più e quale meno, sono oggi soggette.
Il primo tipo di intervento – assai arduo da attuare perché, in una realtà in cui stili di vita e simbologia vengono sfruttati per stimolare il consumo, è connesso in modo perverso al sistema economico – non può che spettare alle istituzioni culturali non anglofone: alle università, ai ministeri della cultura e della ricerca, ma per traslato anche a tutti gli organismi rappresentativi e di governo di chi non è madrelingua inglese – dei quali, purtroppo, non si può non lamentare il ritardo, perlomeno limitandosi a osservare l’ambito europeo.
Il secondo tipo di correttivo mi pare sia perfino largamente da inventare e potrebbe prevedere delle regolamentazioni vincolanti a carico dei soggetti madrelingua inglesi e aventi di mira il supporto di chi non lo è: per esempio, finanziamenti dei Paesi anglofoni per favorire traduzioni dalle altre lingue, obbligatorietà di traduttori presenti agli eventi a carico dei partecipanti madrelingua inglesi, ampia rappresentanza di lingue nei comitati editoriali delle riviste accreditate per permettere la selezione anche di articoli inviati non in lingua franca – e qui mi fermo, essendo appunto una materia tutta da affrontare.
L’ultimo tipo di intervento, invece, riguarda tutti i cittadini e, per loro tramite, i soggetti culturali collettivi, non solo istituzionali, presenti nella società civile. Sta infatti a tutti noi riappropriarsi pienamente delle nostre lingue madri e usare le corrette espressioni che esse includono, invece di riempire le nostre frasi di parole inglesi. Una pratica, quest’ultima, che – oltre a impoverire la nostra proprietà di linguaggio e, di conseguenza, la nostra capacità di argomentare – è ben lungi dall’essere una sprovincializzazione o un’apertura cosmopolita: tutto al contrario, è un asservimento al campanilismo anglofono globalizzato e un depauperamento della diversità linguistica del mondo, che è una delle sue ricchezze in via di progressivo assottigliamento. Mi auguro che le osservazioni condivise in queste pagine possano contribuire a stimolare il senso civico dei lettori quanto basti a far sì che la prossima volta che si trovino a scrivere o pronunciare meeting, business, sharing, o anche Champions League preferiscano invece usare incontro, affare, partecipazione e Torneo dei Campioni.
Dialoghi Mediterranei, n. 49, maggio 2021
Note
[1] Paolo Parrini, Fare filosofia, oggi, Carocci, Roma 2018: 44, nota 3.
[2] Globalized Parochialism: Consequences of English as Lingua Franca in Philosophy of Science, in “International Studies in the Philosophy of Science”, Volume 29, 2015 – Issue 2 (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02698595.2015.1119420)
[3] Paolo Parrini, Fare filosofia, oggi, cit.: 44, nota 3.
[4] Cfr. Frank Rösler, Globalesisch: Fluch oder Segen? Einige Gedanken aus der Sicht der kognitiven Neurowissenschaft, in Jurgen Trabant (Ed.), Welche Sprache(n) spricht die Wissenschaft?, Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin 2011.
[5] In tedesco la Praxis indica lo studio del professionista e, nel parlato, più specificamente quello del medico; Philosophische Praxis voleva perciò alludere alla professionalizzazione del filosofare.
[6] Il counseling nasce con Carl Rogers e Rollo May come una vera e propria psicoterapia.
[7] Uno dei “motti” usati dal suo ideatore era infatti «un’alternativa alle psicoterapie, non una psicoterapia alternativa», con il quale egli alzava il vessillo del pensiero per distinguersi dagli approcci terapeutici, psicologici, di aiuto e di cura.
[8] Achenbach ha scritto sei libri e svariate decine di articoli; in inglese sono stati tradotti non più di cinque o sei articoli.
[9] Quando le ragioni non sono ben chiare, com’è noto, si tende ad addebitare la responsabilità dei conflitti alle persone e ai loro caratteri, interessi, ambizioni; in questo caso anche i filosofi non hanno fatto eccezione, i più accantonando le concrete ragioni che stavano nelle differenze di approccio celate dalle opacità linguistiche della “lingua franca”.
[10] Audi, Robert, The Cambridge Dictionary of Philosophy. II ed. Cambridge University Press, Cambridge 1999: 514.
[11] Gereon Wolters, Globalized Parochialism, cit.: 194.
[12] cfr. Op. cit.: 192.
[13] Philippe Van Parijs, Linguistic Justice for Europe and for the World, Oxford University Press, Oxford 2011.
[14] Gereon Wolters, Globalized Parochialism, cit.: 193.
[15] Cfr. Op. cit.: 195-6.
______________________________________________________________
Neri Pollastri, filosofo, è nato, vive e lavora a Firenze. Dal 2000, primo in Italia, svolge la professione di consulente filosofico, privatamente e in strutture pubbliche. Sulla materia ha pubblicato tre libri e una cinquantina di articoli, l’ha insegnata in diverse Università ed è stato relatore in convegni italiani e internazionali. Si è occupato attivamente anche del pensiero di G.W.F. Hegel, sul quale ha pubblicato un libro, di filosofia della scienza, filosofia politica e di estetica musicale. Scrive sul blog Filosopolis (filosopolis.wordpress.com), il suo sito Internet è www.neripollastri.it, quello del suo istituto di ricerca e formazione www.istitutodiconsulenzafilosofica.it.
______________________________________________________________