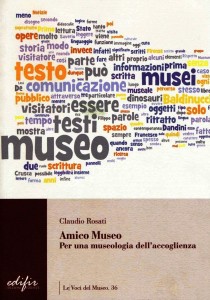A guardare le traiettorie ermeneutiche delle scienze umane nella loro evoluzione degli ultimi anni non c’è chi non constati una evidente crisi dell’oggettività e dell’oggetto e un ritorno più o meno esplicito della soggettività e del soggetto, una più avvertita e diffusa – e a volte perfino enfatica – consapevolezza dell’interazione, della negoziazione e del dialogo come condizione costitutiva del sapere e dei processi di rappresentazione delle culture. La cosiddetta antropologia dialogica muove dall’implosione dei paradigmi scientifici fondativi della tradizionale monografia a favore di una scrittura in cui la funzione autoriale si iscrive e si articola in una prospettiva empaticamente – e in alcuni casi ambiguamente – aperta all’apporto dei soggetti della realtà osservata. Tralasciando i rischi di certe retoriche connesse ad una presunta quanto improbabile elaborazione polifonica dei testi, che condurrebbe ad una grave confusione dei ruoli e delle responsabilità, non c’è dubbio che oggi per effetto della globalizzazione dobbiamo fare i conti con la complessità delle dinamiche interetniche, con il rimescolamento transnazionale delle popolazioni e delle culture. Tanto più che sempre più spesso ci troviamo in presenza di una nuova figura che ha fatto irruzione nell’orizzonte degli studi: l’etnografo nativo che nel rovesciare le posizioni e il punto di osservazione offre inediti livelli di intelligibilità delle diversità e dei differenti modi di stare nel mondo.
Che nuove soggettività prima assenti o invisibili o semplicemente passive impongano la loro attiva influenza nei processi di costruzione e organizzazione dei saperi non solo antropologici è dato evidente perfino nella profonda ridefinizione delle teorie e delle pratiche museografiche, ovvero nella revisione critica dell’identità di uno degli istituti culturali più conservatori e tradizionalmente associati al canone dell’autoreferenzialità. Nel senso comune, che – come diceva Cirese, uno dei padri fondatori della museografia antropologica – è «cascame di pensieri pensati da altri», i Musei sono ancora luoghi marcati da cesure e confini, riconoscibili da soglie che separano l’interno dall’esterno, connotati da ordinamenti progettati secondo categorie e tipologie eminentemente monoculturali e unidirezionali. Un’aura di sacralità permea le collezioni di patrimoni solitamente selezionati e radunati per attestare una identità, una storia, una nazione. Un luogo che sa ancora di «solitudine tirata a cera, che sa di tempio e di salotto, di cimitero e di scuola», per usare le parole di Paul Valéry. Così è probabilmente nella percezione collettiva, uno spazio statico, obsoleto, anacronistico e aristocratico, nonostante – come ha scritto Pietro Clemente sul n. 21 di Dialoghi Mediterranei – «da quarant’anni ci diamo da fare per mostrare il museo come luogo di conoscenza, di formazione, di stupore, dinamico, attivo, accogliente, necessario all’uomo del nostro tempo.(….) E questo perché con fatica e impegno di tanti negli ultimi quarant’anni la forma del museo e la sua comunicazione sono cambiate in modo impressionante, hanno seguito le potenze dell’informatica, dell’interattività, della videoproiezione, dell’allestimento immersivo ed emotivo».
In questa direzione è stato determinante il contributo degli antropologi che hanno aperto la strada alla progettazione di musei della cultura contadina, dopo che fuori dall’accademia, in forme più o meno spontanee o “selvagge”, erano state allestite mostre ed esposizioni permanenti, in gran parte create dal basso, per volontà di gruppi delle comunità locali o per iniziativa di figure popolari liminari di collezionisti solitari. Sono germogliate tra gli anni settanta e ottanta numerosissime realtà museali con esiti certamente disomogenei ma con tratti caratterizzanti comuni: la dimensione abbastanza piccola, l’alta rappresentatività areale, la soggettività e il protagonismo dei ceti che a livello locale avvertirono maggiormente il disagio della transizione dalla società contadina a quella dei consumi. Alcuni di questi musei sono perfino autobiografici, identificandosi la storia degli oggetti raccolti con la storia di vita dello stesso raccoglitore ed esitando in alcuni casi in forme espositive poetiche, politiche o artistiche. Un unicum, insomma, di suggestioni simboliche, di investimenti sentimentali, di narrazioni e di memorie. In qualche caso è lecito pensare che si siano ricongiunte le due figure dello studioso e del collezionista che nel secondo dopoguerra si erano oggettivamente separate. Del resto, come ebbe a scrivere Giuseppe Cocchiara, «i musei sono normalmente come le persone: hanno, quale essa sia, una loro personalità, un loro carattere, un loro umore, le virtù, i pregi, i vizi».
Se è vero che ogni museo è naturaliter antropologico dal momento che mette in scena un certo modo di discretizzare la rappresentazione che del reale e del mondo è sottesa ad ogni cultura, non c’è oggi istituto museale che, a fronte delle forti spinte alle contaminazioni etniche prodotte dalle migrazioni transconti- nentali, non debba fare i conti con il ripensamento della prospettiva fondamentalmente eurocentrica dei sistemi di selezione e di ordinamento dei materiali, con la revisione critica del principio interno di autorità, con la rifunzionalizzazione delle strategie e dei modelli di fruizione e con la riorganizzazione dello sguardo che orienta e definisce il senso di ciò che è visibile e i significati di ciò che è invisibile. Come i musei possono dialogare con le culture degli immigrati? Come possono favorire l’accesso e la partecipazione delle comunità straniere? In che modo possono diventare luoghi aperti alla negoziazione e alla inclusione sociale e culturale, spazi paratattici di collezioni molteplici e di espressioni di civiltà diverse coordinate in plurimi piani di lettura, che delle culture restituiscano le connessioni e non solo le differenze, i sostrati, le contiguità, i meticciamenti e i sincretismi e non solo le identità e le individualità? È concretamente possibile, astrattamente utopistico o del tutto irragionevole progettare musei in cui si riconoscano individui e collettività dalle origini e appartenenze storiche e culturali diverse?
Non risponde segnatamente a questi interrogativi il libro di Claudio Rosati, Amico Museo. Per una museologia dell’accoglienza (Edifir Firenze 2016), e tuttavia è una formidabile guida teorico-metodologica sull’evoluzione del dibattito e sulle esperienze museografiche, una mappa ragionata e una chiave di lettura preziosa per orientarsi sullo sviluppo e sulle prospettive degli studi, sulla storia dei linguaggi e dei criteri di conservazione e di esposizione, sulle forme della comunicazione e della valorizzazione del patrimonio dei beni culturali. L’autore è un museologo che ha operato nelle amministrazioni comunali e nella Regione toscana, studioso di tradizioni popolari, esperto nella gestione di vari musei e centri culturali. L’ampia raccolta di saggi nel volume contiene una documentata rassegna non solo di temi e problematiche ma anche di concrete esemplificazioni di musei progettati e realizzati sul territorio. Pur essendo la giustapposizione di testi redatti per occasioni diverse lungo un percorso umano e scientifico di più di trent’anni di attività, l’idea-forza che sostiene e tiene insieme le trecento e più pagine è il ruolo centrale assegnato al pubblico dei visitatori, non semplici utenti avventori senza nome ma soggetti collettivi coautori e corresponsabili della impresa museografica.
Rosati ricorda che a quanti volevano “visitare” il suo straordinario e stupefacente museo di Ozzano Taro nella campagna parmense, Ettore Guatelli rispondeva risolutamente che «il museo non si visita perché non è malato». Con la sua guida rendeva infatti il pubblico partecipe alla costruzione dei significati, capace ognuno di interagire con la propria sensibilità alla narrazione, di sentirsi coinvolto in quel progetto di vita dispiegato attraverso gli oggetti, la cui geometrica serialità esalta l’umiltà e l’ingegno del lavoro. «Più che un museo da visitare – scrive Rosati – dovremmo parlare di un museo che accoglie, che ascolta e che cerca di mettersi in sintonia con gli altri»: un museo amichevole, crocevia di incontri e di relazioni, luogo di benessere, spazio dinamico e performativo, inclusivo, accogliente e ospitale. «Pensiamo al visitatore come un ospite. Quando a casa nostra riceviamo un ospite andiamo a salutarlo fin sulla porta. Al museo dovremmo comportarci nello stesso modo. La soglia costituisce per tanti concittadini che non sono mai entrati in un museo (secondo le statistiche sette su dieci) una barriera culturale prima che fisica». Rosati insiste su questo punto tanto da auspicare un “museo delle buone maniere”, una istituzione culturale per antonomasia del dialogo, «un’impresa per eccellenza pluridisciplinare che mette in campo più competenze fino a quelle del visitatore, sempre più partner che fruitore passivo, nelle sue istanze di interpretazione delle collezioni». Quella museale è una sorta di «cassetta degli attrezzi» da cui ognuno, secondo le proprie esigenze, può estrarre le coordinate e le mappe cognitive per leggere attraverso gli oggetti esposti il paesaggio culturale a cui alludono, il mondo complesso e frastagliato che sta fuori al di là delle pareti fisiche dell’edificio.
Il museo così concepito non nasce mai compiuto né mai si completa, essendo una struttura d’uso flessibile, organismo che vive e si rinnova nel confronto con i soggetti che abitano e operano nel territorio. Da qui la funzione essenziale della comunicazione che nella museografia di Rosati ha «una pregnanza semantica, spesso non pienamente riflettuta e riconosciuta nel suo significato più autentico». Comunicare è parola oggi probabilmente inquinata dall’abuso commerciale e mediatico, dal frastuono della società dello spettacolo e dalle torsioni pubblicitarie imposte dal marketing. L’autore ne recupera l’etimo, alla radice quel communis agere, quel fare insieme che descrive un processo circolare, una reciprocità di sguardi, un equilibrio e uno scambio di ruoli, di linguaggi e di esperienze. A questa tensione dialettica che trasforma i musei in campi di interattività e di mutua duttilità si legano istanze di democratizzazione del patrimonio e di patrimonializzazione dei beni conservati. Rosati sottolinea la stretta relazione esistente tra la qualità dei servizi offerti dall’istituzione museale e la preservazione e la valorizzazione di quel sentimento di appartenenza a una comunità che definisce civicità, ovvero quello spirito pubblico su cui si fonda la partecipazione alla vita democratica. In questo compito, nel contesto del territorio a cui afferisce, ogni museo non solo ha la sua comunità ma è anche comunità o tende a farsi comunità, riattivando memorie, alimentando l’orgoglio locale e costruendo un orizzonte di senso intorno ai simboli prodotti dalla storia del territorio.
Nella geografia urbana di Rosati il museo è uno spazio civico, «aperto come una piazza per dire o ricordare che il museo è un bene inalienabile di una comunità», per ribadire quanto ebbe ad affermare Derrida intorno all’eredità che «non è mai un capitale astratto e anonimo, non è soltanto un bene che ricevo, è anche un ordine di fedeltà, un’ingiunzione di responsabilità». In tempi di globalizzazione e di convulsioni e rigurgiti nazionalisti al concetto di “patria culturale” non appartiene tanto la tesaurizzazione fine a se stessa dei patrimoni ereditati quanto la loro interazione con il presente, la loro iscrizione e traduzione nei luoghi e nella vita degli uomini contemporanei. L’attenzione di Rosati per i piccoli e numerosi musei periferici disseminati in un territorio «modellato ad arte fin nel più piccolo borgo» discende dalla consapevolezza della storia eminentemente policentrica del nostro Paese, rappresentato dal tessuto connettivo di significative e capillari realtà locali e dalla pluralità delle identità urbane e culturali, «in un’Italia debole nella percezione dello Stato ma forte nella sua articolazione di associazioni, cooperative, sindacati, parrocchie».
In questa prospettiva grande spazio ha dedicato l’autore ai cosiddetti ecomusei che, per quanto la loro fortuna abbia generato usi impropri e abusi ideologici, hanno tuttavia il merito di esaltare il sistema di relazioni tra abitanti, territorio e patrimonio, secondo la nota triangolazione postulata negli anni settanta da Hugues de Varine. Luogo di mediazione e fulcro centrale tra gli oggetti e i soggetti, il territorio nella strategia della nouvelle musèologie va ri-territorializzato dalla comunità in un processo attivo e produttivo che connette fattori sociali, ecologici e antropologici. Nell’ecomuseo – sostiene Rosati – la commistione di contenuto e contenitore rimanda in qualche modo all’unitarietà della cultura, alla perfetta osmosi tra il “piccolo” e il “grande”, alla permanente interazione tra alto e basso, tra monumento e documento, tra aulico e popolare: un’idea che «abbraccia la pieve romanica e l’ordito dei campi coltivati». Nel descrivere alcuni musei di questo tipo attestati soprattutto in Toscana l’autore ribadisce l’importanza del ruolo del territorio quale fitto reticolo di interdipendenze di elementi antropici e naturali, specie «in una regione in cui la costruzione del paesaggio è costitutiva della sua stessa identità politica e culturale».
Il volume offre inoltre in una sorta di prontuario un ricco repertorio di suggerimenti metodologici su come progettare un museo, come allestirlo, come amministrarlo, come gestirne la comunicazione. Rosati si occupa della applicazione del codice Urbani ma anche della figura del custode che «può essere un grande orecchio che ascolta il pubblico, ma a sua volta ha bisogno di qualcuno che lo ascolti». Scrive di ricerche sul campo, delle tecniche di conservazione e di archiviazione delle fotografie, di didattica e dei rapporti con le scuole, ma anche di regolamenti interni, di visite guidate, della scrittura nei linguaggi museali, del volontariato giovanile, delle tecnologie digitali e perfino delle barriere architettoniche che non meno di quelle culturali si frappongono nell’accesso e nella fruizione degli ambienti. Indicazioni operative e ragionamenti antropologici che valgono per tutti i musei, siano essi naturalistici, scientifici, storici, archeologici, artistici. L’aspetto che unisce e attraversa le differenti tipologie è la puntuale attenzione di Rosati per i meccanismi della comunicazione museografica: ne conosce a fondo la grammatica, ne spiega il lessico e la sintassi, i sistemi di codifica e di decodifica delle collezioni esposte, i diversi modi di affrontare e risolvere il problema dei dislivelli di culture e sensibilità del pubblico a partire dall’uso e dall’articolazione degli spazi e dalla leggibilità e intelligibilità degli oggetti e dei contesti.
Dentro un museo che non vuole insegnare né dimostrare ma piuttosto mostrare e sperimentare assume un particolare rilievo la dimensione del fare e con essa la funzione del corpo, che contro i canoni convenzionali si intende affrancare dall’immobilità e dalla passività perché possa muoversi negli ambienti con passo da flâneur, lungo percorsi liberamente stimolati dalla curiosità conoscitiva che prevedano pause e distrazioni e, in questa strategia di progressivo appaesamento, le mani possano recuperare la loro primaria dimensione tattile, così da azionare i congegni, girare le mole, suonare gli strumenti – come già negli anni sessanta suggeriva Cirese – perché «rientra nei compiti della documentazione etnografica che si sappia come in realtà funzionano o funzionavano quegli strumenti». Ciò che preme a Rosati è in primo luogo la promozione di una nuova immagine del museo, liberato dalle narrazioni e dalle rappresentazioni stereotipate che lo assimilano al vincolo paralizzante e burocratico di una custodia quasi poliziesca dei beni, all’ordine sacro e severo del passato, alla noia del vetusto e del desueto, alla retorica aurea di una religione dell’ammirare e del contemplare ovvero del “visitare” muto ed effimero.
I musei sono oggi per fortuna un’altra cosa ma la cultura diffusa e l’uso prevalente che di fatto registra una bassa percentuale di visitatori associano l’accesso al museo all’idea anacronistica di un culto da osservare e di un rito da celebrare. Un’iniziazione di cui per generazioni si fa esperienza attraverso la scuola e che per molti nel tempo scolastico si consuma e si esaurisce. Rosati vorrebbe pertanto descolasticizzare il museo, inserirlo nell’area delle possibilità di consumo (cinema, musica, teatro etc.), perché diventi uno spazio “buono da pensare”, non lontano ma certo diverso dall’aula scolastica, non in contrapposizione ai luoghi di intrattenimento del tempo libero ma se mai in simmetrica concorrenza, non liminare ma domestico e familiare, in grado di comunicare non solo conoscenze ma anche emozioni, sinestesi, divagazioni, piaceri. La sua riconoscibilità nel panorama urbano è affidata alla qualità e quantità dei servizi che offre al pubblico più che all’importanza delle opere che conserva. Non diversamente Pietro Clemente con incisiva nettezza ha scritto anni fa: «Il museo è come i ristoranti e i programmi televisivi, ha bisogno di essere scelto dall’utente, di entrare nel circuito delle segnalazioni tra amici, di essere ricordato come una cartolina acquistata, per poter rispondere con successo allo scopo per cui è nato».
Di molti altri temi museali il libro di Rosati intreccia e dipana i molteplici fili di concetti e di progetti, di metodi e di regole, di schemi e di esperienze vive e positive. Attraverso le sue pagine vogliamo tuttavia riprendere quegli interrogativi che oggi con più forza s’impongono al centro del dibattito museografico. Ci si chiede se a fronte della pluralità di culture, di sensibilità e di diversità etniche ed umane che abitano e convivono pur tra mille contraddizioni nelle nostre città, il museo civico di cui ha ampiamente scritto Rosati, nucleo costitutivo del genius loci, non debba trovare un nuovo logos dell’accoglienza per parlare a tutti, occidentali e non, per rispettare tutte le soggettività, traversando e traducendo le frontiere fisiche e le barriere simboliche. Il riposizionamento museografico attento ad un ampliamento dei sistemi di ricezione presuppone non solo nuove forme di comunicazione ma anche un processo di risemantizzazione dei saperi e dei paradigmi ideologici e progettuali. Si pensi, solo per fare qualche esempio, alle categorie estetiche di matrice occidentale o alle tassonomie cronologiche e ideologiche che all’interno delle vecchie gabbie disciplinari tendono ad assolutizzare le identità e le differenze.
Il museo possibile della contemporaneità è forse lo spazio degli orizzonti incrociati, dello sguardo aperto ai prestiti, alle contaminazioni, agli ibridismi, ai sincretismi, a quanto costitutivamente impuro è stato prodotto dalle vicende transnazionali dei contatti e delle reciprocità tra i popoli. Di “musei come zone di contatto” ha scritto James Clifford, e alle sue parole non è inutile rinviare: «finché i musei non andranno al di là della consultazione, finché non includeranno una più vasta gamma di esperienze storiche e priorità politiche nell’attuale programmazione delle esposizioni e del controllo delle collezioni museali, essi saranno percepiti come puramente paternalistici da persone per cui quella del contatto con i musei è stata una storia di esclusione e condiscendenza». Gli stessi oggetti delle raccolte extraeuropee presenti nei musei etnologici potrebbero assumere nuovi significati e diversa efficacia comunicativa dalle storie e dai racconti dei migranti, dalle testimonianze di quanti hanno memoria dei soprusi e delle usurpazioni del colonialismo. Così pure i nostri musei della cultura contadina potrebbero arricchirsi dai loro saperi popolari e tradizionali e diventare luoghi di incontro, di confronto e di letture interculturali. Promuovendo la loro partecipazione alla elaborazione condivisa di nuovi significati e di nuove funzioni da attribuire alle collezioni, i musei così progettati possono contribuire alla costruzione di nuove cittadinanze, possono davvero essere “civici”, arricchiti cioè da quel «tasso di civicità» che Claudio Rosati auspica più volte nei suoi scritti.
Come è noto, le cose in un sistema museale hanno valore in quanto descrivono e suggeriscono nessi, interazioni, integrazioni e intersezioni. Nella rete paradigmatica che trasforma le collezioni in un insieme significativo di documenti, affiora in superficie quanto non si riesce a vedere, si percepisce l’evidenza dell’assenza, si coglie ciò che si nasconde dietro e sotto gli oggetti, quanto è implicito nei testi e nei contesti. Da qui la potenza materiale e simbolica e l’intrinseca capacità di comunicazione e di interpretazione del mondo che ogni manufatto esposto possiede ed esprime nella sua relazione dialettica con gli altri manufatti, contro certe ipotesi museografiche che vorrebbero paradossalmente fare a meno dei patrimoni oggettuali surrogati dall’algido profilo delle raffinatissime ricostruzioni digitali e virtuali. Come insegna Clemente, nessun allestimento può produrre effettiva conoscenza se privato degli effetti epifanici, vale a dire emozionali, teatrali e scenografici, che solo agli oggetti – coagulo di forma e materia ma anche e soprattutto di intimi legami e reciproche corrispondenze – restano in ultima istanza affidati.
«In un mondo contemporaneo lacerato dagli assolutismi etnici», per usare ancora le parole di Clifford, può passare anche attraverso «gli istituti più borghesi e più europei quali sono i musei» il superamento della sempre più radicale e micidiale dicotomizzazione noi/gli altri, se si declinano in una sintesi inedita universi materiali e culturali solitamente non comunicanti, capaci cioè di costruire narrazioni alternative rispetto al tradizionale concetto di patrimonio quale insieme di beni rappresentativi e identificativi di un’appartenenza etnica. A spinger un po’ più in là lo sguardo, la vera sfida della post-modernità prefigura probabilmente l’istituzione di musei interetnici, trasversali, pluridisciplinari, polisemici. Se alla radice del suo stesso statuto di fondazione l’antropologia è e resta un modello di conoscenza comparativa, il museo che vuole essere spazio di comprensione interculturale non può non basare il proprio linguaggio sulla comparazione, che riconduce la pluralità e la diversità degli elementi materiali e immateriali entro un comune ordine di intelligibilità, un orizzonte di senso tanto più ampio e duttile da ripensare e rimescolare gli stessi significati di arte, artigianato ed estetica maturati e definiti in epoche e culture diverse, i concetti di forma, uso, funzione e simboli, i confini dello spazio e i regimi del tempo. Si tratta di elaborare nuovi percorsi percettivi, più ampie reti comunicative, inediti accostamenti e contesti più complessi perché un museo non sia il luogo monologico di una collezione e i soggetti in una prospetttiva dialogante possano ritrovarsi e rinnovarsi, trasformare ed essere trasformati.
Fare del dialogo un dispositivo politico della “museografia partecipata” non è allora espediente retorico o demagogico né astrazione romantica o velleitaria ma piuttosto il pieno e condiviso riconoscimento dell’alterità, della presenza imprescindibile di quanti fanno parte del nostro vissuto quotidiano, della necessità della voce degli altri nel dibattito culturale come nella strategia e nella pratica dei diritti civili. Il museo dell’accoglienza prende corpo e vita se l’evidenza degli oggetti raccolti e ordinati dentro una fitta e complessa trama di analogie e differenze, discontinuità e permanenze rende finalmente visibile l’eternamente assente, l’invisibile: l’uomo. Nella sua unicità di individuo e nella sua unità di specie, come nella pluralità delle forme e dei modi di essere e di stare nel mondo.
Dialoghi Mediterranei, n. 25, maggio 2017
Riferimenti bibliografici
Clemente P., Graffiti di museografia antropologica italiana, Protogon Siena 1996
Clemente P.-Guatelli E., Il bosco delle cose. Il Museo Guatelli di Ozzano Taro, Parma 1996
Clifford J., Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri Torino 1999
Cirese A.M., Oggetti, segni, musei. Sulle tradizioni contadine, Einaudi Torino 1977
Cocchiara G., Storia del folklore in Italia, Sellerio Palermo 1981
Derrida J., Ecografie della televisione, Cortina Milano 1997
De Varine H., Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, Clueb Bologna 2005
Valery P., Le problème des musées, in Oeuvers I, La Pléiade Paris 1957
_______________________________________________________________________________
Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. La sua ultima pubblicazione è la cura di un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (2015).
________________________________________________________________