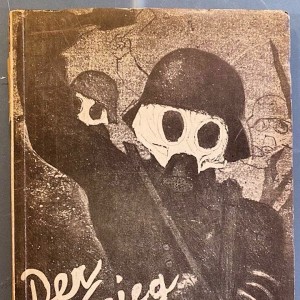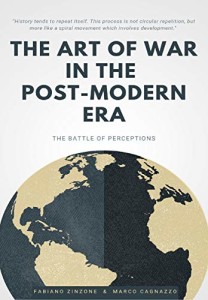di Giovanni Cordova
Mentre scrivo queste brevi riflessioni per Dialoghi Mediterranei, la guerra sul fronte orientale dell’Europa è abbondantemente entrata nel secondo mese di atrocità e devastazioni. In pochi avevano previsto e scommesso che la serie di provocazioni, tatticismi bellicisti preparatori e investimenti strategici nell’industria delle armi (“della difesa”, si dice con furbo eufemismo) avrebbero compiutamente traghettato il continente europeo e le sue (enormi) propaggini politiche a una dimensione dello scontro che siamo soliti osservare altrove. Un altrove non tanto distante per l’ampiezza delle coordinate geografiche (i Balcani e il nord Africa, ad esempio, sono teatri di guerra forse ancor più prossimi di quanto non lo sia l’Ucraina) ma secondo le polarizzazioni politico-culturali di estraneità e familiarità, di condivisione e respingimento che ogni conflitto richiama e alimenta.
A difesa di quanti ritenevano che le ostilità e gli scambi di accuse tra leader mondiali e relativi vassalli non fossero altro che il sintomo di un riassestamento delle relazioni politiche ed economiche globali (lo scenario multipolare di cui tanto si parla in queste settimane), un gioco delle parti fisiologicamente destinato a esaurirsi, sacrificato sull’altare della Realpolitik e dei compromessi, si potrebbe citare Karl Polanyi. Storico e pensatore ungherese insuperato nella riflessione critica – e dunque antropologicamente orientata – sull’economia e sulla naturalizzazione della sua declinazione mercatale e marginalista, nella sua opera più conosciuta, La grande trasformazione (1974), Polany considera il XIX secolo come caratterizzato dalla persistenza (benché flebile) di un diffuso desiderio di mantenimento della pace. E ciò in ragione della necessità di preservazione dell’equilibrio del potere e degli interessi dell’alta finanza, specie europea. Il commercio esigeva il mantenimento della pace e a questo provvedeva un’organizzazione permanente deputata a fornire il legame tra organizzazione politica ed economica: l’alta finanza, appunto. Intimamente extraterritoriale e transnazionale, l’alta finanza aveva tutto l’interesse a ostacolare l’insorgenza di guerre che avrebbero potuto interferire con i fondamenti monetari del sistema economico globale – fondato sulla base aurea internazionale – che mai avrebbe potuto convivere con la deflagrazione di un conflitto mondiale.
Questo equilibrio si mantenne almeno fino agli anni Novanta del diciannovesimo secolo, quando – sullo sfondo dello sfaldamento del sistema internazionale fondato sulla base aurea e della concorrenza tra nazioni per l’accaparramento del mercato coloniale – nemmeno l’alta finanza riuscì a impedire la formazione di raggruppamenti politico-militari come la Triplice Intesa e la Triplice Alleanza. L’analisi storica di Polanyi prosegue fino a contemplare lo sviluppo del commercio estero e la necessità della difesa delle valute e delle economie nazionali, fino a esaminare l’intreccio tra autarchia e totalitarismo che il Novecento avrebbe salutato con orrore. Ma soprattutto, Polanyi individua l’errore storico inseguito utopisticamente dal liberalismo economico di provvedere alla realizzazione di un sistema di mercato autoregolato. Visione fallace, questa, perché «sceglieva di fondarsi su un motivo soltanto raramente riconosciuto come valido nella storia delle società umane, cioè il guadagno» (Polanyi 1974: 38), mentre il laissez-faire liberale non avrebbe mai resistito all’interventismo delle istituzioni politiche centrali nazionali – dibattito, questo, che non si è mai esaurito fino ai nostri giorni.
 L’intuizione di Karl Polanyi è solo in parte smentita dai fatti. Rimanendo – ancora per poco – limitati a un ordine del discorso economicista, l’investimento nel settore militare e l’attivazione della cosiddetta economia di guerra sembrano arginare in modo molto limitato l’annunciato crollo del PIL russo (e ucraino). In un orizzonte economico innestato sull’ininterrotta competizione nell’accesso a nuovi segmenti di mercato e alla dinamica di accumulazione e allocazione a(nta)gonistiche di risorse finanziarie (presagio concreto e mai sopito di nuovi conflitti), lo stato di guerra impone un brusco rallentamento, una condizione di vita che avevamo relegato a un assetto pre-moderno. Del resto, in un ordine mondiale nel quale le missioni geo-economiche delle grandi potenze politiche sono perennemente impegnate a ridurre anche di pochi giorni le rotte necessarie allo scambio delle merci – la geografia esplorativa del XXI secolo – attraverso partnership e alleanze che consentano di aggirare gli ostacoli alla più rapida circolazione possibile di risorse energetiche e altro materiale di scambio, la paralisi sembra il contrario della modernità. Ricordiamo l’ostruzione del canale di Suez nel 2021 e le funeste previsioni di rincari e penuria di materie prime. Ma l’anti-modernità della guerra poggia più decisamente su altre basi.
L’intuizione di Karl Polanyi è solo in parte smentita dai fatti. Rimanendo – ancora per poco – limitati a un ordine del discorso economicista, l’investimento nel settore militare e l’attivazione della cosiddetta economia di guerra sembrano arginare in modo molto limitato l’annunciato crollo del PIL russo (e ucraino). In un orizzonte economico innestato sull’ininterrotta competizione nell’accesso a nuovi segmenti di mercato e alla dinamica di accumulazione e allocazione a(nta)gonistiche di risorse finanziarie (presagio concreto e mai sopito di nuovi conflitti), lo stato di guerra impone un brusco rallentamento, una condizione di vita che avevamo relegato a un assetto pre-moderno. Del resto, in un ordine mondiale nel quale le missioni geo-economiche delle grandi potenze politiche sono perennemente impegnate a ridurre anche di pochi giorni le rotte necessarie allo scambio delle merci – la geografia esplorativa del XXI secolo – attraverso partnership e alleanze che consentano di aggirare gli ostacoli alla più rapida circolazione possibile di risorse energetiche e altro materiale di scambio, la paralisi sembra il contrario della modernità. Ricordiamo l’ostruzione del canale di Suez nel 2021 e le funeste previsioni di rincari e penuria di materie prime. Ma l’anti-modernità della guerra poggia più decisamente su altre basi.
Anzitutto una precisazione. Le guerre esistono, coinvolgendo ogni angolo del globo, e sono variamente sostenute o alimentate prevalentemente dall’Occidente. Secondo la rilevazione dell’Armed Conflict Location & Event Data Project, a parte quello ucraino sono dieci i conflitti che nel corso del 2022 potrebbero evolvere diramandosi in una dimensione globale (Etiopia, Yemen, Sahel, Nigeria, Afghanistan, Libano, Sudan, Haiti, Colombia, Myanmar), cui andrebbero aggiunti migliaia di episodi/eventi di violenza politica. Da questo computo si esclude la violenza strutturale che le traiettorie dello sviluppo e delle politiche internazionali post-coloniali hanno generato e ampliato, violenza che parla il linguaggio di altre mortificazioni: il debito, i vincoli commerciali imposti dai colonizzatori agli ex-colonizzati, la presenza militare per contrastare la lotta al terrorismo e i flussi migratori incontrollati.
Ma la guerra russa all’Ucraina – con la complessa genealogia di corresponsabilità che l’ha generata – è difficilmente ignorabile o ascrivibile all’inferiorità culturale e politica delle popolazioni tribali che sembrano conoscere solo il conflitto e necessitano di un dittatore, secondo il peggior retaggio coloniale. È un macigno nel cuore della soggettività culturale e politica europea e sebbene questa visibilità sia anche sorretta dalla paura riposta in una guerra molto vicina all’Europa (“non nel mio cortile!” è l’imperativo etnocentrico di respingimento della violenza fuori dal recinto di casa nostra), il confronto con l’economia politica e morale della guerra non è più procrastinabile.
Nelle società-contro-lo-Stato, il dispositivo centrifugo della guerra segna la massima alterità idealtipica dai modelli di organizzazione sociale fondati sulla centralizzazione del potere politico e sullo scambio. La guerra indigena su cui riflette Pierre Clastres in relazione ai “selvaggi” dell’Amazzonia indigena permette l’autonomia politica dei gruppi locali – inibendo la concentrazione di autorità, prestigio e ricchezza e la sua conversione in coercizione, diseguaglianza e sfruttamento. Essa garantisce la dispersione del potere, perennizzando lo spostamento del baricentro sociale in una sede extra locale, alimentando la circolazione dell’alterità. «La guerra primitiva non ha necessariamente una “funzione sociale”, ma avrà sempre un effetto politico. La negazione dello Stato in questo caso sarebbe una conseguenza dell’affermazione della guerra e non la sua causa finale» (Viveiros de Castro 2021: 74). Altre guerre, altre vocazioni sociali, altre antropo-poiesi.
 L’immaginario bellicista ha fatto irruzione nel nostro quotidiano. Nei corpi, nei pensieri, nella soggettività più profonda. Questa penetrazione non sembra aver incontrato particolari difficoltà. Ormai da tempo, del resto, l’orrore e l’indicibile sono visionabili, cliccabili, accessibili e fruibili, come alle giostre dei parchi di divertimento, ma a distanza di sicurezza. Quel tanto che ne permetta l’assuefazione senza sperimentare fino in fondo l’angoscia e le sue conseguenze di disintegrazione psico-fisica. È, in fondo, lo scenario della guerra diffusa, delle guerre localizzate (molto lontane) e a bassa intensità, combattute perlopiù da droni e in cui l’umano non emerge che nel registro ossificato degli ‘errori’ che i bombardamenti intelligenti provocano di tanto in tanto. Siamo in presenza della perdita dell’orrore, cioè di quella terribile percezione estetico-cognitiva che ci fa trasalire allorquando percepiamo la precarietà del vivente e la sua distruggibilità, come nota Talal Asad nel suo saggio sul terrorismo suicida in cui sostiene che l’orrore che questo fenomeno suscita derivi dalla confusione delle forme del corpo e dalla ab-normalità che segna i luoghi, i tempi e gli attori degli attentati?
L’immaginario bellicista ha fatto irruzione nel nostro quotidiano. Nei corpi, nei pensieri, nella soggettività più profonda. Questa penetrazione non sembra aver incontrato particolari difficoltà. Ormai da tempo, del resto, l’orrore e l’indicibile sono visionabili, cliccabili, accessibili e fruibili, come alle giostre dei parchi di divertimento, ma a distanza di sicurezza. Quel tanto che ne permetta l’assuefazione senza sperimentare fino in fondo l’angoscia e le sue conseguenze di disintegrazione psico-fisica. È, in fondo, lo scenario della guerra diffusa, delle guerre localizzate (molto lontane) e a bassa intensità, combattute perlopiù da droni e in cui l’umano non emerge che nel registro ossificato degli ‘errori’ che i bombardamenti intelligenti provocano di tanto in tanto. Siamo in presenza della perdita dell’orrore, cioè di quella terribile percezione estetico-cognitiva che ci fa trasalire allorquando percepiamo la precarietà del vivente e la sua distruggibilità, come nota Talal Asad nel suo saggio sul terrorismo suicida in cui sostiene che l’orrore che questo fenomeno suscita derivi dalla confusione delle forme del corpo e dalla ab-normalità che segna i luoghi, i tempi e gli attori degli attentati?
«Quando non c’è un segno del corpo vivente su cui poter fare affidamento, il terreno che sostiene il senso dell’essere umano – e, di conseguenza, di ciò che significa essere compassionevoli – si sbriciola. Ciò che sembra generare orrore è la facilità con cui il confine tra ciò che è vivo e ciò che non lo è – tra la sacralità di un cadavere umano e l’empietà di una carcassa animale – può essere attraversato» (Talal Asad, 2009: 79).
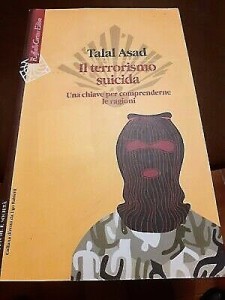 L’anestetizzazione al dolore, all’orrore, all’ab-norme sarebbe in fondo comprensibile, nell’epoca in cui la minaccia dei mutamenti climatici acquisisce il carattere tetro di un’epifania distopica e assolutamente attuale, come mostrano le immagini – acquisite, diffuse e consumate come mai prima d’ora – di catastrofi ambientali, violente precipitazioni alluvionali, tornado che squarciano il paesaggio, tristi capitolazioni delle specie viventi che abitano l’ecosistema. Abituarsi allo stra-ordinario e non sorprendersi più di tanto dell’inesorabile cammino verso la fine che l’umanità sta percorrendo non è una reazione difensiva del tutto comprensibile? Nell’era della riproducibilità della sofferenza e delle tragedie che affliggono l’umanità, l’attesa e le aspettative più funeste riducono il margine dell’inatteso. Sul baratro ci siamo già da un pezzo. Per questo, forse, sembra assumere maggiore rilevanza la spasmodica ricerca di contro-segni che incrinino le retoriche, i racconti, le narrazioni, quasi che la verità – o la post-verità, come è stata definita – costituisse ormai l’unico terreno di lotta o mediazione possibile. Riprenderò questo punto oltre.
L’anestetizzazione al dolore, all’orrore, all’ab-norme sarebbe in fondo comprensibile, nell’epoca in cui la minaccia dei mutamenti climatici acquisisce il carattere tetro di un’epifania distopica e assolutamente attuale, come mostrano le immagini – acquisite, diffuse e consumate come mai prima d’ora – di catastrofi ambientali, violente precipitazioni alluvionali, tornado che squarciano il paesaggio, tristi capitolazioni delle specie viventi che abitano l’ecosistema. Abituarsi allo stra-ordinario e non sorprendersi più di tanto dell’inesorabile cammino verso la fine che l’umanità sta percorrendo non è una reazione difensiva del tutto comprensibile? Nell’era della riproducibilità della sofferenza e delle tragedie che affliggono l’umanità, l’attesa e le aspettative più funeste riducono il margine dell’inatteso. Sul baratro ci siamo già da un pezzo. Per questo, forse, sembra assumere maggiore rilevanza la spasmodica ricerca di contro-segni che incrinino le retoriche, i racconti, le narrazioni, quasi che la verità – o la post-verità, come è stata definita – costituisse ormai l’unico terreno di lotta o mediazione possibile. Riprenderò questo punto oltre.
Eppure la commossa solidarietà destinata ai rifugiati ucraini, tangibile nelle innumerevoli espressioni e manifestazioni di solidarietà rinvenibili nelle ultime settimane, non sembra affatto stantia, asfittica, liturgica – nel senso più liso che possa essere attribuito al termine. Certo, essa risponde – talvolta implicitamente, talaltra con maggiore evidenza – anche alle implicazioni politiche che presiedono alla costruzione sociale della figura del rifugiato, come un’ormai affermata linea di ricerca socio-antropologica certifica senza difficoltà. Rifugiati non si nasce ma si diventa, e non solo in conseguenza di eventi avversi o calamità naturali, ma anche in virtù di costellazioni politiche di volta in volta mobilitate.
E senza dubbio i rifugiati ucraini sono “buoni da pensare”, e in particolare per pensare l’Europa e la sua confusa e incerta identità politica, che però nelle ultime settimane sembra essersi consolidata di fronte alla tragedia del fronte ucraino e alle possibilità (politiche ed economiche), tutte da verificare, che l’opposizione alla Russia di Putin schiuderebbero in un ordine geopolitico multipolare. Sembra consolidarsi, perché le contraddizioni restano insolute – e, forse, non potrebbe essere diversamente: mentre scrivo, leggo che la Polonia negherebbe la possibilità di abortire alle donne ucraine vittime di stupro. E, se il dato delle elezioni presidenziali francesi ci ricorda che questa identità europea non è poi del tutto suffragata dalla volontà popolare, cosa dire dei rifugiati non ucraini (i neri) ai quali viene impedito di salire sui treni e mettersi in salvo fuggendo dall’Ucraina? La linea del colore non è che una delle fratture che ancora percorrono il progetto di integrazione europea ma non per questo meno infamante.
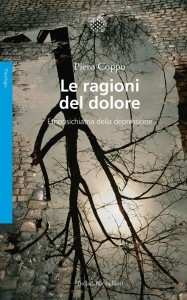 In un mirabile saggio dedicato a un’esplorazione etno-psichiatrica della depressione, Piero Coppo, scomparso la scorsa estate, riporta, a proposito del nesso tra disturbi depressivi, lutto e melanconia, il mutamento nelle percezioni di Sigmund Freud rispetto all’incombenza della Prima Guerra Mondiale. Il fondatore della psicoanalisi aveva inizialmente sposato le ragioni del conflitto e da una postura patriottica, giungendo a scrivere a Sándor Ferenczi che tutta la sua libido si riversava sugli austroungarici (Coppo 2005:51). Era il 1914. In breve tempo, l’orrore della guerra e la sua realtà funesta si imposero alla coscienza dell’analista, trascinandolo in uno stato depressivo l’uscita dal quale non fu slegata dalla produzione di una teoria sulla morte e sulla guerra che avrebbe alimentato la sua più ampia speculazione su lutto e melanconia.
In un mirabile saggio dedicato a un’esplorazione etno-psichiatrica della depressione, Piero Coppo, scomparso la scorsa estate, riporta, a proposito del nesso tra disturbi depressivi, lutto e melanconia, il mutamento nelle percezioni di Sigmund Freud rispetto all’incombenza della Prima Guerra Mondiale. Il fondatore della psicoanalisi aveva inizialmente sposato le ragioni del conflitto e da una postura patriottica, giungendo a scrivere a Sándor Ferenczi che tutta la sua libido si riversava sugli austroungarici (Coppo 2005:51). Era il 1914. In breve tempo, l’orrore della guerra e la sua realtà funesta si imposero alla coscienza dell’analista, trascinandolo in uno stato depressivo l’uscita dal quale non fu slegata dalla produzione di una teoria sulla morte e sulla guerra che avrebbe alimentato la sua più ampia speculazione su lutto e melanconia.
Eros e thanatos: la guerra – gli entusiasmi che suscita, non inquadrabili solo alla luce dei pur evidenti interessi economici; la proiezione del Sé in fratrie e clan nemici; l’inconfessabile adesione alle visioni del conflitto come “motore” o “igiene” della Storia, eufemisticamente confessata nella ripetizione del motto latino “Si vis pace, para bellum”, il richiamo alla Resistenza partigiana traslata in altri contesti storici, politici e culturali. Ma anche, ovviamente, l’angoscia, l’afflizione di fronte alle miserie che la guerra reca, e che si cuciono addosso ai vestiti, ai corpi infreddoliti e alle strumentalizzazioni politiche – provenienti da ogni parte – dei rifugiati ucraini. Per quanto tendiamo a rimuoverle, la guerra stimola pulsioni libidiche e di morte, solo in parte inibite dalla sensibilità post-moderna che si voleva avesse chiuso definitivamente con il secolo breve delle ideologie, delle grandi narrazioni e dei conflitti planetari.
Non intendo proseguire nello sviluppo di una riflessione psicoanalitica della guerra. Ma l’ambivalenza che questa solleva, stuzzica e richiama non può non essere oggetto di riflessione. Come inquadrare altrimenti gli appelli che alcuni rappresentanti delle democrazie liberali occidentali rivolgono dai principali canali televisivi a cittadini e cittadine perché si convincano che la guerra ha delle conseguenze positive in termini di sviluppo, crescita economica e maturazione politica? Quali artifizi retorici possono giustificare i peana che accompagnano il deciso incremento della spesa pubblica in materia di armamenti con discutibili e quanto mai franosi riferimenti alle esternalità positive in termini di occupazione e PIL? Se la proposta vaticana di affiancare una donna russa a un’altra donna ucraina alla XIII stazione della Via Crucis del Venerdì Santo suscita dubbi sull’equidistanza del posizionamento ecclesiale e pontificale – indipendentemente dall’efficacia del simbolo nel dispositivo rituale religioso – la ragione forse non risiede unicamente nell’evitare un’indebita confusione tra aggressori e aggrediti.
La (post)modernità, con il correlato di razionalizzazione, disincanto e primato della tecnica, sembrava determinare l’ingresso in un’era in cui lo spirito del mondo sarebbe stato incarnato dalla neutralità della tecnica, almeno in Occidente. Un’ulteriore conseguenza del dominio della tecnica sarebbe stata poi la ‘spoliticizzazione’ della vita sociale e l’irriducibilità del nuovo ordine delle cose alla guerra, preludio a una pace universale (Verra, Portoghesi 1998). La guerra in Ucraina testimonia della provvisorietà della storia, e di come la post-modernità non sia affatto antitetica alle imprese della guerra, se i circoli militari impegnati nella riflessione geo-strategica sulla difesa ammettono apertamente che le “minacce” non saranno mai del tutto neutralizzate, ma solo temporaneamente sopite (Zinzone, Cagnazzo 2020).
Nei conflitti post-moderni gli avversari possono essere sì ridimensionati, ma non eliminati. Anzi, le guerre diventano ancor più complicate vista l’intersezione tra dimensioni propriamente militari e domini politico-culturali che parimenti concorrono ad alimentare il conflitto, orientandone gli esiti. Ad esempio, la “disgregazione dall’interno” – la destabilizzazione di una potenza in guerra dovuta al collasso economico-produttivo, è del tutto equivalente, per portata ed evoluzione, allo scontro tra battaglioni. Inoltre, è interessante che i militari attribuiscano al “fattore umano” una rilevanza cruciale nel determinare vittorie e sconfitte, di gran lunga più incisiva delle dotazioni tecnologiche e dei sistemi d’arma (Citati 2020). Insomma, che guerra e (post)modernità costituiscano un ossimoro sarebbe solo la straniante e paradossale illusione derivata dal tramonto delle aspettative che la fine delle grandi narrazioni e delle idee di progresso portavano con sé.
Più sopra ho fatto riferimento alla verità come orizzonte di senso che avviluppa gran parte degli eventi e dei processi della contemporaneità. Nel corso di questo conflitto stiamo assistendo a una rincorsa di asserzioni e smentite, propaganda e fact-checking (talvolta anch’esso impreciso, come è stato dimostrato). Nulla di particolarmente inedito, se è vero che in guerra la prima a morire è proprio la verità. La ricerca della verità è una parte tutt’altro che trascurabile della posta in gioco rinvenibile sul fronte ucraino. Una ricerca che coinvolge enti governativi e non governativi come organizzazioni e cittadini comuni. Una ricerca mobilitata molto spesso contro trame internazionali che sfuggono al controllo e persino alla cognizione della gente comune. In una recente inchiesta sul fenomeno QAnon negli Stati Uniti (ma non solo), Wu Ming 1 (2021) distingue opportunamente tra ipotesi e fantasie di complotto, visto che sarebbe fin troppo facile bollare ogni contro-narrazione (e anche la contro-informazione che, limitandoci al caso italiano, è stata cruciale nello scenario politico e culturale repubblicano) come forsennato e insulso complottismo.
Sarebbe sbagliato correlare con troppa disinvoltura, come fa buona parte della nostra stampa, stagioni, eventi, campi sociali differenziati, con il solo scopo di respingere e stigmatizzare un ordine del discorso (e i suoi depositari) quando non va incontro a determinati interessi economico/politici. Con parole più chiare: tracciare una corrispondenza tra sostenitori di Putin, negazionisti del COVID-19 e altre tipologie di sostenitori delle più ardite fantasie di complotto (e magari legarle con metodologia alquanto dubbia a criteri socio-economici come le dotazioni di capitale economico e culturale) mi sembra un’operazione bislacca, fiacca e infondata. Tuttavia, mi pare abbastanza evidente prendere in considerazione come questi processi sociali, situati al crocevia di eventi piuttosto inattesi (ma non del tutto imprevedibili) accaduti negli ultimi anni, abbiano in comune l’ambizione di ridisegnare i confini della verità e attribuire nuovi statuti fattuali a vicende che sono ben lontane dall’essere giudicate incontrovertibili.
 Questo tentativo di riposizionamento del ‘vero’ presenta a mio avviso un’esplicita connotazione politica. Anche qui, nulla di nuovo sotto il sole. Come i Cultural Studies britannici hanno ampiamente dimostrato da tempo, attingendo alla lezione gramsciana, ogni segno, ogni messaggio, ogni produzione culturale, anche quando proviene dai centri ortogenetici dell’egemonia politico-culturale possono essere risignificati, alterati, riplasmati, persino sovvertiti, e ritorcersi pertanto contro il mittente. A risultare oggi più evidente è però la progettualità unitamente all’estensione che i processi di smentita-decostruzione-ribaltamento posseggono, legando tra loro casi ed eventi diversi, variamente accomunati tuttavia dal sentore di una qualche cospirazione ordita dai potenti della terra a danno dei popoli.
Questo tentativo di riposizionamento del ‘vero’ presenta a mio avviso un’esplicita connotazione politica. Anche qui, nulla di nuovo sotto il sole. Come i Cultural Studies britannici hanno ampiamente dimostrato da tempo, attingendo alla lezione gramsciana, ogni segno, ogni messaggio, ogni produzione culturale, anche quando proviene dai centri ortogenetici dell’egemonia politico-culturale possono essere risignificati, alterati, riplasmati, persino sovvertiti, e ritorcersi pertanto contro il mittente. A risultare oggi più evidente è però la progettualità unitamente all’estensione che i processi di smentita-decostruzione-ribaltamento posseggono, legando tra loro casi ed eventi diversi, variamente accomunati tuttavia dal sentore di una qualche cospirazione ordita dai potenti della terra a danno dei popoli.
Sebbene lo scontro tra ‘alto’ e ‘basso’ (tra potenti e oppressi) sia alla base di alcune delle più potenti ideologie della storia – nonché delle annunciazioni messianiche di molte religioni – ciò che mi colpisce è la capacità che queste contro-narrazioni hanno di legare genealogie e contesti differenti, istituendo una circolarità che spinge ogni potenziale ricercatore di verità a trovare la ‘sua’ piccola tessera di celato, nascosto, ignorato e ricomporla in una trama più ampia, stratificata, globale. Al netto delle premesse politiche che sono individuabili in questo affresco – la conquista per l’egemonia non è il primo passo per l’emancipazione? – mi sembra che queste rimangano tali, senza schiudere un reale orizzonte di trasformazione politica. Dietro la decodificazione dei segni e lo smascheramento di complotti o, più modestamente, delle strategie affabulatrici del potere, si è esaurita la spinta all’aggregazione di piattaforme sociali pronte a misurarsi sul terreno politico della lotta per il cambiamento dello stato di cose presente?
 Mi sento di condividere le intuizioni del filosofo coreano Byung-Chul Han (2022), secondo il quale il piano dell’immanenza che nutre la nostra esperienza del reale è stato progressivamente sostituito da informazioni; non-cose prive di referenti reali, concreti, misurabili al quale appigliarsi nella vita vissuta. Nella società “infomaniaca” satura di dati, immagini e comunicazione, l’ambizione più stimolante è quella di condividere il proprio pensiero e non di prefigurare soluzioni concrete ai problemi e all’oppressione dell’umanità. E se la ratifica di un posizionamento politico – e la differenziazione da altri – diventa l’obiettivo primo (se non esclusivo) di ogni atto comunicativo (la funzione indessicale: affermare cioè un contenuto quasi esclusivamente per rivelare da quale parte si collochi l’enunciatore) fino ad annacquarne i referenti primari, non è detto che ciò contribuisca alla salute della sfera pubblica.
Mi sento di condividere le intuizioni del filosofo coreano Byung-Chul Han (2022), secondo il quale il piano dell’immanenza che nutre la nostra esperienza del reale è stato progressivamente sostituito da informazioni; non-cose prive di referenti reali, concreti, misurabili al quale appigliarsi nella vita vissuta. Nella società “infomaniaca” satura di dati, immagini e comunicazione, l’ambizione più stimolante è quella di condividere il proprio pensiero e non di prefigurare soluzioni concrete ai problemi e all’oppressione dell’umanità. E se la ratifica di un posizionamento politico – e la differenziazione da altri – diventa l’obiettivo primo (se non esclusivo) di ogni atto comunicativo (la funzione indessicale: affermare cioè un contenuto quasi esclusivamente per rivelare da quale parte si collochi l’enunciatore) fino ad annacquarne i referenti primari, non è detto che ciò contribuisca alla salute della sfera pubblica.
Ammetto che queste considerazioni possano essere etichettate all’insegna della repulsione all’anelito democratico che guida la “presa di voce” dei senza-potere e alla criticabilità di ogni cosa che accompagna i processi di liberazione e democratizzazione. Ma di fronte all’incontrovertibile dato della sofferenza umana provocata da questo conflitto, dibattere sul numero esatto dei civili morti nel bombardamento del teatro di Mariupol sembra quanto meno lunare, salva la legittima richiesta di un’informazione corretta e veritiera. Affermare la collusione di ogni potere e la sua irriformabilità ci autorizza a oltrepassare le soggettività infrante che la guerra – ogni guerra – porta con sé? Non credo. E, se posso concludere queste riflessioni con un auspicio personale, spero che la giusta ricerca delle complicità e la speculazione analitica intorno alle diffuse e trasversali responsabilità condivise dall’Occidente non ci facciano mai assuefare alla vita e alla morte vissute là dove la guerra diventa il quotidiano che tutto inghiotte con sé. Se la guerra non è antitetica alla (post)modernità, ciò che serve è forse un moto di inattualità: il coraggio della pace, la dismissione degli arsenali bellici e la cessazione di ogni politica esercitata contro il pianeta e gli esseri che lo abitano.
Dialoghi Mediterranei, n. 55, maggio 2022
Riferimenti bibliografici
Asad Talal, Il terrorismo suicida. Una chiave per comprenderne le ragioni, Milano, Raffaello Cortina, 2009 (2007).
Citati Dario, L’arte della guerra nell’età post-moderna: la battaglia delle percezioni, in “Analisi Difesa”, https://www.analisidifesa.it/2020/07/larte-della-guerra-nelleta-post-moderna-la-battaglia-delle-percezioni/.
Coppo Piero, Le ragioni del dolore. Etnopsichiatria della depressione, Torino, Bollati Boringhieri, 2005.
Han Byung-Chul, Le non-cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale, Torino, Einaudi, 2022.
Polanyi Karl, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, Torino, Einaudi, 1974.
Verra Valerio, Portoghesi Paolo, Moderno e post-moderno, in Treccani – Enciclopedia del Novecento, Il Supplemento, online.
Viveiros de Castro Eduardo, L’intempestivo, ancora. Pierre Clastres di fronte allo Stato, Verona, ombre corte, 2021.
Wu Ming 1, La Q di Qomplotto, Roma, Edizioni Alegre, 2021.
Zinzone Fabiano, Cagnazzo Marco, The art of war in the post-modern era. The battle of perceptions, Youcanprint, 2020.
_____________________________________________________________
Giovanni Cordova, dottorando in ‘Storia, Antropologia, Religioni’ presso l’Università ‘Sapienza’ di Roma, si interessa di processi migratori – con particolare riguardo al sud Italia, società multiculturali e questioni di antropologia politica nel Maghreb. Per la sua ricerca di dottorato sta esaminando la dimensione politica ‘implicita’ nella vita quotidiana dei giovani tunisini delle classi sociali popolari nonché la commistione tra i linguaggi della religione e della politica. Prende parte alla didattica dei moduli di antropologia nei corsi di formazione rivolti a operatori sociali e personale della pubblica amministrazione in Calabria e Sicilia.
______________________________________________________________