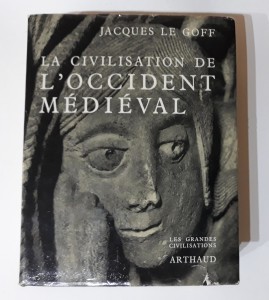dopo saman
di Alberto Giovanni Biuso
Nel numero 51 di Dialoghi Mediterranei è apparso un testo di Antonello Ciccozzi che ho letto con grande attenzione, interesse e piacere [1]. Attenzione perché affronta un tema assai complesso quale quello delle differenze etniche come «diversità che non arricchiscono»; interesse perché lo fa attingendo alla letteratura sociologica su questo tema, a dati statistici, ad analisi rigorose; piacere per la libertà di pensiero e anche per il coraggio civile che la sua prospettiva mostra.
Ci vuole infatti soprattutto coraggio, oggi, a svolgere il proprio lavoro di studiosi delle scienze sociali, delle scienze umane, della politica, senza farsi troppo condizionare dai dogmi del politicamente corretto che sono diventati i fondamenti di un moralismo fuori dal quale sembrano esserci soltanto pregiudizi, miserie e soprattutto «razzismo». Parola, quest’ultima, che va perdendo sempre più il suo significato euristico – così denso e così grave – per trasformarsi in un luogo comune, in un termine buono per ogni occasione polemica, e – nei casi peggiori – in una clava esercitata contro l’interlocutore che non si adegui a determinati princìpi ideologici ed etici.
Le tesi di Ciccozzi
Provo quindi prima di tutto a sintetizzare quella che a me è sembrata la linea di fondo dell’analisi di Ciccozzi, che si occupa del tragico caso della diciottenne italo-pachistana Saman Abbas, uccisa dai suoi familiari – madre compresa – per aver rifiutato un matrimonio combinato e in generale non essersi comportata come una buona donna musulmana. Di fronte a un caso come questo, e ai non pochi analoghi eventi di vessazioni e di violenze che non arrivano all’omicidio ma sono assai pesanti, Ciccozzi intende evitare «il doppiamente erroneo posizionamento (in gran parte politico-ideologico) del dare solo la colpa all’Islam versus l’opposto e complementare sentenziare che l’Islam non c’entrerebbe assolutamente nulla con certi accadimenti delittuosi, che anzi osteggerebbe». Per cercare di comprendere la complessità e la tragicità in certi casi insuperabile di un simile conflitto tra le costumanze islamiche e quelle europee, lo studioso ritiene necessario ricordare con chiarezza alcuni dati di fatto:
- l’Occidente è un «luogo che resta per alcuni migranti, chiusi in un identitarismo non disposto a negoziazioni, una dimensione di alterità culturale nient’altro che negativa, minacciosa e da osteggiare»;
- l’ambiguità e la pericolosità del senso di colpa europeo che si esprime nell’esigenza di «decolonizzare», che produce «un panorama assiologico in cui come colpevole emerge essenzialmente il noi occidentale, reo di non capire le migrazioni, di sfruttare i migranti, di non prendere coscienza delle sue colpe coloniali, di semplificare l’Islam in un modello statico»;
- la consequenziale adozione di «un galateo abbastanza bizantino di accortezze ermeneutiche postcoloniali da adottare quando si parla dell’Altro, ma sostanzialmente ipocomplessi, poiché rispondenti a uno schema di fondo elementare, quasi pavloviano in cui, di fronte a questioni che chiamano in causa l’alterità migrante, l’intellettuale universitario è chiamato a conformarsi ad un engagement paladino rivolto verso i vari Sud del mondo, interni ed esterni, che si risolve nell’ostentazione enfatica di una unidirezionale filippica sulle responsabilità dell’Occidente», con il risultato paradossalmente (in apparenza) suprematista di «sussumere l’Occidente nei suoi peccati coloniali, in un’essenzializzazione che lo priva di qualsiasi portato positivo, e a pensare che i problemi del Sud del mondo vengano solo dal Nord del mondo e mai da cause interne. […] In tal modo, a partire da uno schema di fondo radicalmente anti-etnocentrico ed esotista che rovescia contrappassisticamente il sentimento etnocentrico e imperialista di superiorità coloniale, trasformandolo in senso di colpa entro la griglia manichea del “noi-cattivi/altri-buoni”, il negativo altrui, in quanto elemento epistemologicamente perturbante, viene regolarmente rimosso al momento del suo emergere: viene silenziato».
 Il risultato di questi e altri simili presupposti è un vero e proprio mito sociologico invalidante, che Ciccozzi sintetizza nella formula di una «interdizione morale rispetto al riconoscere l’eventualità dell’estraneità ostile del migrante». Mito invalidante anche in prospettiva mediatica in quanto «se qualcosa che riguarda in qualche modo i fenomeni migratori non va per il verso giusto, meglio stare zitti o deviare l’attenzione altrove, per non violare la sacralità assoluta del migrante». Su tutto infine pende l’accusa tremenda e definitiva lanciata contro chi cerca di capire la complessità di conflitti spesso per loro natura insanabili, vale a dire le formule magiche «razzista», «islamofobo» o insulti analoghi.
Il risultato di questi e altri simili presupposti è un vero e proprio mito sociologico invalidante, che Ciccozzi sintetizza nella formula di una «interdizione morale rispetto al riconoscere l’eventualità dell’estraneità ostile del migrante». Mito invalidante anche in prospettiva mediatica in quanto «se qualcosa che riguarda in qualche modo i fenomeni migratori non va per il verso giusto, meglio stare zitti o deviare l’attenzione altrove, per non violare la sacralità assoluta del migrante». Su tutto infine pende l’accusa tremenda e definitiva lanciata contro chi cerca di capire la complessità di conflitti spesso per loro natura insanabili, vale a dire le formule magiche «razzista», «islamofobo» o insulti analoghi.
Ciccozzi ha buon gioco nel documentare come comportamenti oppressivi verso le donne e verso chiunque siano parte costitutiva della dottrina religiosa e giuridica di molte potenti correnti e raggruppamenti della Umma, della comunità musulmana nel mondo, in Pakistan, in Afghanistan, in Arabia Saudita e in molti altri luoghi dove l’Islam controlla istituzioni e cultura. Il limite più grave delle sottovalutazioni nelle quali incorrono studiosi e cittadini europei è non percepire la natura identitaria e soteriologica che per molte comunità islamiche riveste la pratica intransigente della Sharia. Ricordando gli studi di Mary Douglas, Ciccozzi afferma che «dal loro punto di vista quelle persone uccidono in nome del bene della famiglia e della comunità, per loro si tratta di sacrifici rituali dal valore palingenetico, con cui purificano il loro orizzonte morale da quelle che percepiscono come contaminazioni».
Sottovalutazioni le quali sono spesso e banalmente frutto della diffusione del politicamente corretto che diventa una sottile ma grave forma di complicità con forme di oppressione e di violenza che hanno radici teologiche e psicologiche assai profonde: «diluire i delitti d’onore nella categoria del femminicidio e del patriarcato produce un’opacità del “noi non siamo meglio di loro”, un relativismo della cultural blindness che, se consola rispetto all’imperativo categorico implicito del tutelare il dogma progressista multiculturalista che comanda che “la diversità è arricchimento”, lo fa al prezzo di mascherare questi reati culturalmente motivati in una cappa di omertà politically correct».
Il cortocircuito tutto occidentale, tutto nostro, tra relativismo culturale, multiculturalismo, assimilazionismo ed etnocentrismo, produce una vera e propria tribalizzazione del diritto e della sociologia, per la quale ciò che è ritenuto gravissimo e inaccettabile se praticato dentro nuclei familiari europei, viene invece accettato, giustificato, sottovalutato se accade in nuclei familiari islamici. Di fronte alla diffusione in Europa di usi e costumi guidati non da una minoranza sparuta da difendere ma dalla seconda religione al mondo per diffusione e la prima per espansione; di fronte alla richiesta arcaica (spesso semplicemente implicita) di valutare i reati in relazione non alla loro natura ma alla collocazione religiosa e culturale di chi li compie; di fronte al «diffondersi di una giurisprudenza islamica parallela a quelle nazionali, in nome di un pluralismo giuridico che desta molti dubbi», Ciccozzi è assai chiaro nell’affermare che tutto questo
«ci dovrebbe fare capire, fuori dalla tentazione dello schieramento politicoideologico polarizzante, che il multiculturalismo ha un limite dopo il quale bisogna essere assimilazionisti: chi ammazza una figlia in nome di un codice d’onore, chi pensa che violentare una donna non sia un reato a partire da una visione del mondo arcaica e predatoria dei rapporti di genere introiettata nel Paese di nascita, chi ritiene che sia lecito e irrinunciabile mutilare gli organi genitali femminili per trasformare la donna in un essere socialmente docile, chi commette reati interni alla famiglia in nome di precetti religiosi non compatibili con gli ordinamenti giuridici occidentali, chi fa tutto questo mette in pratica dei micro atti di colonizzazione culturale, di imperialismo dal basso che vanno riconosciuti e sanzionati come forme di ur-fascismo esotico, come tattiche spontanee sostanzialmente meta-terroristiche, in quanto rivolte contro princìpi di civiltà che abbiamo il diritto e il dovere di tutelare, e che i rei percepiscono viceversa come terreno di conquista a partire da una loro disposizione di estraneità ostile nei confronti delle nazioni che li ospitano e delle Costituzioni che le regolano».
Non tutto l’Islam è fondamentalista, certo, ma le tendenze fondamentaliste dell’Islam sono assai forti e volte a costruire quello che Ciccozzi chiama con apprezzabile parresia una «forma esotica di moderno fascismo di matrice islamista», che rende davvero disneyana la speranza che individui e comunità cresciuti nella Sharia, «una volta assaggiato il balsamo della civiltà vorranno generalmente abdicare di propria sponte dai costumi che indossano e arricchirci con il loro farsi europei diversi ma non troppo». Si tratta, da parte di chi nutre quella illusione, di una amara eterogenesi dei fini, se è vero che questi auspicati neoconvertiti ai valori occidentali «non sa[nno] che farsene anche dei diritti di sinistra, che capisc[ono] sempre meno, e interpreta[no] come patetici segni di decadenza; questo a partire dalla mutazione, da certe parti del tutto incompresa, dei diritti del lavoro in diritti civili».
Ed è a partire da questo punto, dai diritti del lavoro trasformati in diritti civili, che vorrei proseguire il dialogo empatico con Ciccozzi, per poi tentare di virare il discorso verso una prospettiva non sociologica ma antropologica e teoretica. Sulla questione della Sharia, della sua natura intimamente oppressiva e delle sue conseguenze, non penso infatti di poter aggiungere nulla alle analisi che qui ho cercato di sintetizzare e a partire dalle quali proverò a svolgere brevemente qualche ulteriore considerazione in merito al più generale fenomeno migratorio del quale casi come quello di Saman Abbas costituiscono una conseguenza.
Dal punto di vista metodologico è necessario distinguere fenomeni e comportamenti tra loro simili ma assolutamente non identici: etnocentrismo, pregiudizio, xenofobia, razzismo. La classificazione proposta da Taguieff mi sembra corrisponda alla varietà e complessità dei fenomeni di esclusione.
L’etnocentrismo è la naturale preferenza di ogni gruppo umano per le consuetudini, le credenze, i costumi nei quali i suoi membri sono stati allevati e che sono per loro del tutto ovvi rispetto a costumi diversi giudicati ‘esotici’; si tratta di un fenomeno universale nello spazio e nel tempo.
Il pregiudizio consiste in una generalizzazione illegittima (come tutte le generalizzazioni) di fenomeni reali; se non è vero che tutti i siciliani sono mafiosi, corrisponde a realtà che lo siano non pochi abitanti dell’Isola. I pregiudizi possono essere ovviamente anche positivi e rivolti al proprio gruppo.
La xenofobia è un non occasionale atteggiamento di ostilità verso gli stranieri, motivato in forme molteplici ma che affondano tutte sostanzialmente nella paura di ciò che non si conosce.
Il razzismo, infine, è il fenomeno certamente più denso e più grave perché consiste nell’etichettare individui e gruppi non per quello che fanno ma per quello che sono. Le vittime del razzismo non possono, neppure volendo, essere diverse da ciò che sono e quindi il loro statuto è irredimibile. La forma più estrema di razzismo è quella biologica, oggi in pratica non sostenuta da nessuno. Più debole ma sempre radicale è il razzismo culturale, che reputa inferiori individui e gruppi per l’insieme di norme, valori, credenze e simboli che guidano i loro comportamenti [2].
Il giornalismo e la pubblicistica non scientifica tendono a definire “razzismo” anche comportamenti etnocentrici, pregiudiziali e xenofobi. In questo modo banalizzano il concetto e non fanno un buon servizio alle vittime di queste diverse forme di esclusione. Sulla base anche di tali necessarie distinzioni metodologiche, cercherò ora di inserire in un più ampio quadro storico la questione del multiculturalismo, delle differenze integrabili in identità più ampie, delle differenze che invece rimangono nell’attuale fase storica inoltre passabili, delle differenze non solo irriducibili ma anche pericolose per le modalità democratiche di convivenza politica alle quali società e cultura europee sono pervenute con molta fatica e anche versando il sangue di filosofi, studiosi, cittadini, nei secoli che vanno dalla fine del Medioevo al Novecento.
Le guerre che sconvolsero l’Europa all’inizio dell’età moderna e che ebbero il loro apice nella guerra dei Trent’Anni (1618-1648) furono così totali e così feroci anche perché furono combattute in nome di Dio. Papisti contro riformati, riformati in lotta tra di loro, re cattolici contro sovrani protestanti ma anche cattolici contro altri cattolici. Tutti combattevano in nome della verità e per motivi quindi di suprema giustizia, poiché nulla – evidentemente – è più giusto che lottare per la verità assoluta del Dio. Le paci di Westfalia posero fine a tali massacri, regolamentando i conflitti con norme assai rigide, che fecero emergere una delle strutture della guerra, il suo essere anche un gioco diplomatico che legittima, integra e, a volte, sostituisce forme ancora più distruttive di aggressività. Un conflitto rigidamente regolato risulta infatti meno feroce dello scatenarsi incontrollato e spontaneo della violenza.
Come hanno mostrato gli studi etologici di Konrad Lorenz e Irenäus Eibl-Eibesfeldt, è opportuno distinguere tra l’aggressività in generale – che è fenomeno biologico, individuale e interno al gruppo – e la guerra, la quale rappresenta invece un prodotto dell’evoluzione culturale. In quanto fenomeno storico, la guerra è superabile e la pace non è soltanto una bella utopia, a patto che della guerra si comprendano funzione e struttura.
Che cosa c’entra tutto questo con la questione migratoria? C’entra perché l’universalità dei conflitti fra gli esseri umani è data soprattutto da tre fattori: lo spacing o mantenimento delle distanze tra gruppi culturali; il reperimento delle risorse necessarie alla sopravvivenza; il rafforzamento dell’identità tribale. Territorialismi, tecnologie belliche, diplomazie sono delle strutture funzionali a questi scopi. Gli obiettivi delle guerre sono tanto comuni e diffusi da essere presenti anche in molte specie di scimmie antropomorfe e nelle popolazioni preagricole dei cacciatori-raccoglitori. Alcuni dei fattori che favoriscono i conflitti precedono ogni singolo episodio bellico: il desiderio di possedere qualcosa che possa dirsi proprio –donne, alimenti, terre, prede – ; il bisogno di saggiare le forze individuali e del gruppo cui si appartiene; una valvola di sfogo dell’aggressività progressivamente accumulata e repressa; un incremento demografico incontrollato.
L’aggressività è forma ed espressione del conflitto intra-specifico, diretto contro membri della stessa specie e non di quello delle varie specie tra di loro. Diversamente da altre specie, nell’Homo sapiens è assente un meccanismo inibitorio di atti di violenza fatale, in quanto noi siamo privi di armi naturali con le quali potere uccidere una grossa preda in un sol colpo. Da qui il proliferare patologico di una violenza senza freni, esercitata mediante armi che colpiscono da lontano e in modo anonimo, rafforzata dall’evidente contrasto fra la ‘nobiltà’ dei valori etici – quali la tolleranza e il cosmopolitismo – e il permanere di istinti fondamentali e atavici come la difesa del proprio gruppo e del proprio territorio contro qualunque invasore e ogni possibile minaccia.
Contrariamente alla guerra, l’aggressività è innata ma lo è perché indispensabile alla sopravvivenza (aggressività difensiva), all’evoluzione (aggressività adattativa), alla maturazione del singolo (aggressività esplorativa). Sottolineando la culturalità della guerra e la naturalità della pace, l’etologia mostra l’aggressività per quello che è: un impulso innato ma funzionale e orientabile verso la costruzione sociale come verso l’autodistruttività. La scelta dipende dalla saggezza della cultura, della quale il sistema di Westfalia fu espressione. Esso infatti escludeva categoricamente i civili dalle azioni di guerra. Norma e pratica, questa, fondamentale per evitare che ogni conflitto si trasformi in un massacro. Il sistema di Westfalia cominciò a incrinarsi con i conflitti combattuti in nome della Liberté Égalité Fraternité (giacobini e Napoleone) per crollare del tutto nel Novecento con l’evento fondamentale degli ultimi due secoli: la Grande Guerra 1914-1918.
Da allora la guerra non ha più rispettato niente e nessuno, tornando a un’altra sua dimensione fondativa e assai diversa dal gioco: la caccia. Decisivi furono gli sviluppi tecnologici, culminati con l’utilizzo dell’aviazione non come sfida nei cieli tra cavalieri/piloti ma come strumento terroristico esplicitamente teorizzato dal generale italiano Giulio Douhet durante la I Guerra Mondiale. Alla fine della Seconda guerra mondiale pur di ottenere la vittoria definitiva contro il male assoluto, rappresentato dalle potenze dell’Asse, si giunse al fuoco assoluto di Hiroshima e Nagasaki. In nome della suprema giustizia si giunse a cancellare in pochi minuti le vite di centinaia di migliaia di civili, di persone non in armi. Lo stesso era accaduto tra il 13 e il 15 febbraio del 1945 a Dresda, incendiata dall’aviazione britannica per esplicita volontà di Winston Churchill. Dresda non ricopriva alcun ruolo strategico; nel colpirla – e bruciarne centinaia di migliaia di abitanti – il democratico Churchill parlò esplicitamente di terrore da trasmettere ai tedeschi, ai cittadini tedeschi, non al loro governo.
Il tramonto di Westfalia e l’emergere del terrore
Come quello di Hiroshima e di Dresda, il terrore portato dagli eserciti statunitensi ed europei in Afghanistan, Iraq, Libia, Siria è attuato in nome della democrazia, dei diritti umani, della giustizia. Il terrore portato nel Vicino Oriente e in Europa dall’Isis e dalle altre forze islamiste è attuato in nome di Dio, del Corano e delle sue verità. Se tutte le guerre sono delle catastrofi, quelle giuste, quelle sacre, sono le più feroci, senza confronto.
Le prospettive umanitarie non hanno in realtà strumenti per opporsi davvero alle guerre combattute in nome di un Dio, della verità, della giustizia, della democrazia. Anzi, spesso hanno sostenuto – ad esempio nella guerra della Nato contro la Serbia – la necessità di guerre e bombe per l’appunto ˝umanitarie˝. Anche al di fuori della guerra giusta, la convinzione di parlare e agire in nome di un bene assoluto può condurre a esiti distruttivi e paradossali, come quelli che riguardano il tema dei flussi migratori dai Paesi africani verso l’Europa. Nei confronti di chi evidenzia che l’identità costituisce un elemento del tutto ovvio per qualunque società umana – delle più piccole tribù ai grandi Stati – si alza il coro del conformismo incapace di vedere, semplicemente vedere, che «l’umanità» non esiste, che si tratta di un mito positivistico ottocentesco, che le aggregazioni umane sono sempre parziali e si attuano in nome e per mezzo di elementi che accomunano i loro membri differenziandoli da altri.
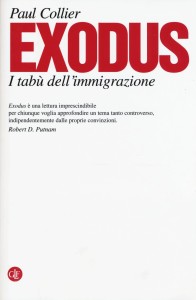 Ogni tanto qualcuno si sottrae al conformismo liberale e liberista dell’accoglienza indiscriminata che favorisce il capitale, mette a rischio le culture di arrivo e crea violenza contro i migranti. Lo ha fatto ad esempio Paul Collier, figlio di migranti e intellettuale di sinistra, il quale in Exodus: How Migration is Changing Our World argomenta a favore di una immigrazione ben temperata che si opponga sia all’accoglienza universale sia al rifiuto indiscriminato [3]. Collier documenta come Paesi quali il Canada e l’Australia, pur essendo enormemente più estesi degli Stati europei e quasi disabitati, limitano l’accesso soltanto a persone che possiedono titoli di studio superiori e filtrano i migranti anche tramite colloqui volti a valutare la loro possibilità di integrazione nella cultura di accoglienza. Di fronte a politiche così “chiuse, sovraniste, fasciste” attuate dal Canada e dall’Australia, perché non dichiarare loro guerra in nome del supremo diritto all’emigrazione? Sarebbe anche questa una guerra giusta.
Ogni tanto qualcuno si sottrae al conformismo liberale e liberista dell’accoglienza indiscriminata che favorisce il capitale, mette a rischio le culture di arrivo e crea violenza contro i migranti. Lo ha fatto ad esempio Paul Collier, figlio di migranti e intellettuale di sinistra, il quale in Exodus: How Migration is Changing Our World argomenta a favore di una immigrazione ben temperata che si opponga sia all’accoglienza universale sia al rifiuto indiscriminato [3]. Collier documenta come Paesi quali il Canada e l’Australia, pur essendo enormemente più estesi degli Stati europei e quasi disabitati, limitano l’accesso soltanto a persone che possiedono titoli di studio superiori e filtrano i migranti anche tramite colloqui volti a valutare la loro possibilità di integrazione nella cultura di accoglienza. Di fronte a politiche così “chiuse, sovraniste, fasciste” attuate dal Canada e dall’Australia, perché non dichiarare loro guerra in nome del supremo diritto all’emigrazione? Sarebbe anche questa una guerra giusta.
Potere, informazione, globalizzazione
La globalizzazione ha distrutto il progetto europeo, facendolo diventare una struttura soltanto mercantile e ‘umanitaria’, umanitaria in quanto mercantile. Un umanitarismo liberista dei diritti umani che ha dimenticato l’umanitarismo comunista di Karl Marx, per il quale uno degli strumenti decisivi dello sfruttamento dei lavoratori è
«un esercito industriale di riserva disponibile [eine disponible industrielle Reservearmee] che appartiene al capitale in maniera così assoluta come se quest’ultimo l’avesse allevato a sue proprie spese. Esso crea per i propri mutevoli bisogni di valorizzazione il materiale umano sfruttabile sempre pronto [exploitable Menschenmaterial], indipendentemente dai limiti del reale aumento della popolazione. […] Alla produzione capitalistica non basta per nulla la quantità di forza-lavoro disponibile che fornisce l’aumento naturale della popolazione. Per avere libero gioco essa ha bisogno di un esercito industriale di riserva che sia indipendente da questo limite naturale [Sie bedarf zu ihrem freien Spiel einer von dieser Naturschranke unabhängigen industriellen Reservearmee]. […] L’esercito industriale di riserva preme durante i periodi di stagnazione e di prosperità media sull’esercito operaio attivo e ne frena durante il periodo della sovrappopolazione e del parossismo le rivendicazioni [hält ihre Ansprüche während der Periode der Überproduktion und des Paroxysmus im Zaum ]. […] Il sedimento più basso della sovrappopolazione relativa alberga infine nella sfera del pauperismo. Astrazione fatta da vagabondi, delinquenti, prostitute, in breve dal sottoproletariato propriamente detto, questo strato sociale consiste di tre categorie. Prima, persone capaci di lavorare. Basta guardare anche superficialmente le statistiche del pauperismo inglese per trovare che la sua massa si gonfia a ogni crisi e diminuisce a ogni ripresa degli affari [seine Masse mit jeder Krise schwillt und mit jeder Wiederbelebung des Geschäfts abnimmt]. Seconda: orfani e figli di poveri. Essi sono i candidati dell’esercito industriale di riserva e, in epoche di grande crescita, come nel 1860 per esempio, vengono arruolati rapidamente e in massa nell’esercito operaio attivo» [4].
Aver dimenticato analisi come queste (decisamente poco ‘umanistiche’) è uno dei tanti segni del tramonto della ‘sinistra’, la quale vi ha sostituito le tesi degli economisti liberisti e soprattutto vi ha sostituito gli interessi del capitale contemporaneo, interessi dei quali i partiti di sinistra sono un elemento strutturale e un efficace strumento di propaganda. Soltanto dei miopi non vedono quanto è accaduto negli ultimi anni, il fatto che la sinistra si va dissolvendo perché ha rinunciato alla propria identità ideologica e alla base sociale che da sempre l’aveva caratterizzata, vale a dire ha rinunciato all’impegno e alla lotta a favore dei lavoratori, dei loro salari, dei loro diritti, dell’occupazione. La globalizzazione rappresenta infatti l’estensione del capitalismo e della speculazione finanziaria all’intero pianeta, a ogni economia, territorio, ambito produttivo e culturale. L’attacco globalista è diretto contro la Differenza e dunque contro le libertà, a favore di un’Identità che vorrebbe sottoporre l’intero pianeta e ogni individuo ai principi deterritorializzati e mercantili delle multinazionali e dei loro corifei.
Negli anni Venti del XXI secolo l’esercito industriale di riserva si origina dalle migrazioni tragiche e irrefrenabili di masse che per lo più fuggono dalle guerre che lo stesso capitale – attraverso i governi degli USA e dell’Unione Europea – scatena in Africa e nel Vicino Oriente. Una delle ragioni di queste guerre – oltre che, naturalmente, i profitti dell’industria bellica e delle banche a essa collegate – è probabilmente la creazione di una riserva di manodopera disperata, la cui presenza ha l’inevitabile (e marxiano) effetto di abbassare drasticamente i salari, di squalificare la forza lavoro, di distruggere la solidarietà operaia. È anche così che si spiega il sostegno di ciò che rimane della classe operaia europea a partiti e formazioni contrarie alla politica delle porte aperte a tutti. Non si spiega certo con criteri moralistici o soltanto politici. La struttura dei fatti sociali è, ancora una volta, economica. Il sostegno alla globalizzazione o invece il rifiuto delle sue dinamiche è oggi ciò che davvero distingue le teorie e le pratiche politiche, non certo le obsolete categorie di destra e sinistra.
Dicotomie concettuali come destra/sinistra o moderatismo/estremismo si rivelano dei miti invalidanti che ostacolano la comprensione e quindi l’azione politica. L’espressione forse più significativa e più grave di tale paralisi è il primato delle questioni etniche e razziali rispetto ai problemi economici e alle prospettive di classe. Ignorando l’intero impianto della dottrina marxiana, entrambe le espressioni della sinistra residuale – quella istituzionale e quella sedicente radicale – privilegiano la questione migratoria rispetto a quella del lavoro, senza rendersi conto di diventare in questo modo i più utili alleati dell’ultraliberismo. Come abbiamo visto, il dispositivo concettuale marxiano dell’esercito industriale di riserva ha invece ancora molto da insegnare agli umanisti liberali di sinistra che si fanno complici del capitale senza neppure rendersene conto. È infatti chiaro che un’apertura indiscriminata ai migranti è ben vista dal padronato, che può utilizzare persone disposte a lavorare per pochi euro all’ora e senza nessuna garanzia. La sinistra accogliente aiuta in questo modo pratiche di schiavizzazione.
 Migranti. Un’analisi sociologica
Migranti. Un’analisi sociologica
Alcune delle principali ragioni e forme del fenomeno migratorio sono analizzate da uno storico progressista e politicamente corretto come Stephen Smith, docente di Studi africani alla Duke University (USA), per molto tempo collaboratore dei quotidiani francesi Libération e Le Monde, corrispondente dall’Africa (dove ha vissuto a lungo) per numerose agenzie, autore de La ruée vers l’Europe. La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent che significa La corsa verso l’Europa e non il ben diverso Fuga in Europa, con il quale Einaudi ha deciso di tradurre il titolo.
Questo studioso rileva come in Africa esista una middle class suddivisa in due fasce. I membri della prima – costituita da 150 milioni di persone, pari al 13% della popolazione africana – «dispongono attualmente di un reddito quotidiano tra i 5 e i 20 dollari, incalzati da oltre 200 milioni di altri, il cui reddito giornaliero oscilla tra i 2 e i 5 dollari. Insomma: un numero in rapida crescita di africani è in ‘presa diretta’ con il resto del mondo e dispone dei mezzi necessari per andare in cerca di fortuna all’estero» [5]. Si tratta di un elemento chiave in quanto «la prima condizione» per progettare l’abbandono del proprio Paese «è il superamento di una soglia di prosperità minima» poiché «attualmente, in relazione al luogo di partenza e al precorso previsto», la cifra necessaria al perseguimento di tale obiettivo «oscilla fra i 1500 e i 2000 euro, ossia almeno il doppio del reddito annuo in un Paese subsahariano» (Smith 2018: 83-84).
Quella che arriva dall’Africa in Europa è quindi una collettività, scrive Smith, «sincronizzata con il resto del mondo, al quale è ormai ‘connessa’ tramite i canali televisivi satellitari e i cellulari – la metà dei Paesi [a sud del Sahara] ha accesso al 4G, che consente streaming e download di video e di grandi quantità di dati; ma anche mediante Internet, via cavi e sottomarini di fibra ottica» (ivi: XIII). Gli altri, vale a dire la grande parte della popolazione africana, «non hanno i mezzi per migrare. Non ci pensano neppure. Sono perennemente occupati a mettere insieme il pranzo con la cena, e quindi non hanno il tempo di mettersi al passo con l’andamento del mondo e, meno ancora, di parteciparvi» (ivi: 87). Solo una minoranza fugge da persecuzioni e guerre, tanto è vero che nel periodo di massima virulenza delle guerre in Africa, gli anni Novanta del Novecento, l’arrivo di migranti era incomparabilmente minore rispetto a quello che si sta verificando negli anni Dieci e Venti del XXI secolo. Ragionando in termini sociologici e storici e non sentimentali e morali – come va sempre fatto di fronte a fenomeni di tale portata – Smith ne deduce che «sarebbe tuttavia aberrante riconoscere in blocco lo status di vittima a chi fugge davanti alle difficoltà e magari non a chi le affronta» (ivi: 86).
Riflettendo sui 1500 dollari mediatamente necessari per raggiungere la Libia dalla Nigeria, il vescovo cattolico di Kafanchan, Joseph Bagobiri, osserva che «se ognuna di queste persone avesse investito questa somma in modo creativo in Nigeria in imprese realizzabili, sarebbero diventati datori di lavoro. Invece sono finiti soggiogati alla schiavitù e ad altre forme di trattamento inumano da parte dei libici. […] In questo Paese vi sono ricchezze e risorse immense. I nigeriani non dovrebbero diventare mendicanti lasciando la Nigeria alla ricerca di una ricchezza illusoria all’estero»; un altro vescovo, Julius Adelakun, invita i nigeriani a non sprecare il proprio danaro, offrendolo ai mercanti di vite umane, e utilizzarlo invece allo scopo di «sviluppare il nostro Paese per renderlo attraente e favorevole alla vita, in modo che siano i cittadini stranieri a voler venire da noi»[6]. Un simile autolesionismo che uccide le persone e impoverisce il Paese d’origine ha molte spiegazioni: due tra queste sono la visione distorta che si ha dell’Europa come luogo di ricchezza assicurata e i finanziamenti dei quali godono le ONG cosiddette ‘umanitarie’ allo scopo di raccogliere quanta più possibile forza lavoro a basso costo da immettere nelle economie europee.
Anche il progetto sintetizzato nella formula «aiutiamoli a casa loro» ha poco senso. Si tratta infatti di un obiettivo contraddittorio sia in via di diritto sia di fatto. Smith lo definisce un vero e proprio paradosso: «I Paesi del Nord sovvenzionano i Paesi del Sud sotto forma di aiuto allo sviluppo, affinché i deprivati possano migliorare le loro condizioni di vita e, sottinteso, restino a casa loro. In questo modo, i Paesi ricchi si danno la zappa sui piedi. Infatti, almeno in un primo momento, premiano la migrazione aiutando alcuni Paesi poveri a raggiungere un certo livello di prosperità grazie al quale i loro abitanti dispongono dei mezzi economici per partire e insediarsi all’estero. È l’aporia del ‘cosviluppo’, che mira a trattenere i poveri a casa loro mentre nello stesso tempo ne finanzia lo sradicamento. Non c’è soluzione, perché bisogna pur aiutare i più poveri, chi ne ha più bisogno…» (ivi: 86). Chi invece sostiene l’accoglienza più o meno universale, dovrebbe riflettere su altri dati di fatto, da Smith esposti con grande chiarezza:
«Nel 2017, tra gennaio e la fine di agosto, hanno attraversato il Mediterraneo 126.000 migranti, di cui 2428 dichiarati dispersi, cioè l’1,92%; dato leggermente inferiore alla mortalità post-operatoria di un intervento di chirurgia cardiaca nell’Europa occidentale (2%). Nonostante il rischio sia, per fortuna, limitato, ci si chiede perché non smetta di aumentare nonostante gli occhi del mondo siano puntati sul Mediterraneo e i soccorsi dovrebbero essere sempre più efficienti. La risposta è che le organizzazioni umanitarie rasentano la perfezione! In effetti, le imbarcazioni di soccorso si avvicinano sempre di più alle acque territoriali libiche e, in caso di pericolo di naufragio, non esitano a entrarvi per prestare soccorso ai migranti. Dal canto loro, i trafficanti stipano un numero sempre maggiore di migranti in imbarcazioni sempre più precarie. […] In cambio di una riduzione tariffaria, un passeggero è incaricato della ‘navigazione’ e di lanciare l’Sos non appena entri in acque internazionali: a tal fine gli viene consegnata una bussola e un telefono satellitare del tipo Thuraya. […] Lasciando i migranti alla deriva…per essere prima o poi soccorsi dalle navi delle organizzazioni umanitarie che sanno fare molto bene il loro mestiere, con l’inconveniente, però, che i migranti, sapendo di essere soccorsi, badano assai poco all’efficienza delle imbarcazioni messe a disposizione dai trafficanti. […] Occorre, tuttavia, arrendersi all’evidenza: per arrivare in Europa i migranti africani corrono un rischio calcolato simile ai rischi che corrono abitualmente nella vita che cercano di lasciarsi alle spalle» (ivi: 107-108).
 Di fronte a tali eventi e dinamiche, Smith afferma lucidamente che è necessario «de-moralizzare il dibattito» sull’emigrazione. I sentimentalismi costituiscono infatti in casi come questi i migliori alleati della violenza degli schiavisti e di quella dei razzisti. Anche lo scrittore Emmanuel Carrère sostiene la necessità di non trasformare la questione migratoria «in un eterno affare Dreyfus»[7]. Come ha insegnato Max Weber, l’etica impolitica della convinzione deve sempre confrontarsi con l’etica politica della responsabilità, la quale deve fare i conti con «tutte le conseguenze prevedibili dei propri atti, al di là del narcisismo morale» (in Smith 2018: 146). Cercando di delineare le possibili conseguenze di quanto sta accadendo tra Europa e Africa, Smith individua per il prossimo futuro cinque scenari.
Di fronte a tali eventi e dinamiche, Smith afferma lucidamente che è necessario «de-moralizzare il dibattito» sull’emigrazione. I sentimentalismi costituiscono infatti in casi come questi i migliori alleati della violenza degli schiavisti e di quella dei razzisti. Anche lo scrittore Emmanuel Carrère sostiene la necessità di non trasformare la questione migratoria «in un eterno affare Dreyfus»[7]. Come ha insegnato Max Weber, l’etica impolitica della convinzione deve sempre confrontarsi con l’etica politica della responsabilità, la quale deve fare i conti con «tutte le conseguenze prevedibili dei propri atti, al di là del narcisismo morale» (in Smith 2018: 146). Cercando di delineare le possibili conseguenze di quanto sta accadendo tra Europa e Africa, Smith individua per il prossimo futuro cinque scenari.
Il primo è l’Eurafrica, che «consacrerebbe l’‘americanizzazione’ dell’Europa» (ivi: 145) e implicherebbe «la fine della sicurezza sociale. […] Lo Stato sociale non s’adatta alle porte aperte, donde l’assenza storica di una sicurezza sociale degna del nome negli Stati Uniti, Paese d’immigrazione per eccellenza. Insomma, sopravviverà in Europa unicamente lo Stato di diritto, il vecchio Leviatano di Hobbes – che dovrà darsi un gran daffare per impedire la ‘guerra di tutti contro tutti’ in una società senza un minimo di codice comune» (ivi: 146-47).
Il secondo scenario è la fortezza Europa, alimentato anche dalle reazioni che suscita «una stampa che si preoccupa più della fiamma del proprio umanitarismo che delle sue conseguenze sulla collettività»; Smith ammette che «la fortezza Europa è forse meno indifendibile di quanto non sembrasse. […] Ciò nondimeno, qualsiasi tentativo esclusivamente sicuritario è votato al fallimento» (ivi: 148-149).
Il terzo scenario è la deriva mafiosa, una vera e propria «tratta migratoria» il cui rischio è «che i trafficanti africani facciano combutta o entrino in guerra con il crimine organizzato in Europa» (ivi. 149); una conferma sta nel fatto che l’80% delle «donne soccorse nel Mediterraneo» vengono destinate «a fini di sfruttamento sessuale. […] Gli intrecci fra prossenetismo e ‘passatori’, troppo spesso presentati come individui soccorrevoli che praticano una forma di commercio solidale, non è che la parte visibile di un’attività criminale assai più importante» (ivi: 150).
Un quarto scenario è il ritorno al protettorato, per il quale in cambio di privilegi e danaro ai ceti dirigenti, alcuni Paesi africani accetterebbero una «sovranità limitata in maniera proporzionale alle esigenze di difesa dell’Europa» (ivi: 151). Il quinto e ultimo scenario è, secondo Smith, il più probabile «in una politica raffazzonata» e «consisterebbe nel mettere assieme tutte le opzioni che precedono, senza mai realizzarle sino in fondo: insomma, ‘fare un po’ di tutto ma senza esagerare’» (ibidem).
A decidere quale di questi scenari prevarrà non saranno probabilmente gli europei ma gli stessi africani. In questi casi, infatti, il numero diventa decisivo. Nell’affrontare per quello che possono la questione, gli europei dovrebbero dunque ragionare sine ira et studio sulla natura e sulle conseguenze del liberalismo capitalistico che prima ha prodotto l’imperialismo in Africa e poi, di rimbalzo, la corsa impetuosa di molti africani verso l’Europa. Uno dei fondamenti teorici del liberalismo, infatti, è la distruzione di corpi intermedi tra il singolo essere umano e l’umanità in quanto tale. In questo senso il liberalismo è l’opposto della democrazia, la quale non pone al centro dello scenario sociale l’individuo ma le citoyen, il cittadino, vale a dire una persona radicata in un contesto collettivo consolidato, frutto di condizioni geografico-economiche ben precise e di eventi storici condivisi. Ed è sempre in questo senso che la sovranità del popolo è cosa ben diversa dalla difesa dei diritti dell’uomo.
Uomo è infatti un concetto astratto, per i Greci ad esempio del tutto marginale. Al centro della vita collettiva si pone invece l’abitante della πόλις, con i suoi diritti e con i suoi obblighi. Per la democrazia i territori, le culture, le organizzazioni collettive non costituiscono soltanto la somma di individui isolati e tra loro irrelati ma sono il risultato della contiguità spaziale e della comunanza temporale. Si è prima di tutto abitanti di un certo luogo e soltanto per questo si può diventare cittadini del mondo. È qui che il concetto di border mostra la propria funzione di delimitazione della dismisura, di κατέχον rispetto alla dissoluzione. La critica superficiale e pregiudiziale al concetto di frontiera, che pervade innumerevoli pagine della Rete e gli articoli di molta stampa, è dunque anch’essa una forma di ignoranza spettacolare, nel molteplice senso di questo aggettivo. Nella storia del XXI secolo il contrario di frontiera non è chiusura, il contrario della frontiera è il mercato, è il capitale, che sin dall’inizio ha avuto come fondamento la massima liberista «Laissez faire, laissez passer».
Applicare questo principio in modo totale e irrazionale, come tende a fare il liberismo contemporaneo significa, tra le altre conseguenze, «fare i conti senza l’ospite», vale a dire fare i conti senza coloro che nel territorio europeo risiedono da secoli e che cominciano a sentirsi stranieri nel proprio Paese (passeggiare ad esempio in via Padova a Milano mi ha dato esattamente questa impressione) o persino ‘invasi’. «L’arrivo di stranieri può importunare, la loro presenza può disturbare. Pretendere che non sia così mi sembra una petizione di principio idealistica e pericolosa» (Smith 2028: 112). Affrontare una simile realtà in termini psicologici o addirittura moralistici è sterile, per non dire anche pericoloso. De-moralizzare il problema è necessario anche perché «né lo straniero, né l’ospite sono a priori ‘buoni’ o ‘cattivi’, ‘simpatetici’ o ‘egoisti’. Vengono a trovarsi, insieme, in una situazione che occorre cercar di capire al pari delle circostanze, ovviamente differenti per l’uno e per l’altro. La mancata assistenza a una persona in pericolo è un reato, a condizione di potere prestare aiuto senza esporsi a pericoli (ultra posse nemo obligatur). […] La preoccupazione dell’equità internazionale non può confondersi con l’apertura delle frontiere a titoli di perequazione planetaria. Non è incoerente essere favorevoli all’equità internazionale e contrari alla totale apertura delle frontiere» (ivi: 112-113).
E questo anche perché ritenere che sia del tutto normale, e anzi auspicabile, che forze giovani e molto consistenti dei Paesi africani debbano venire in Europa e in Italia per risolvere i problemi demografici e contributivi del Vecchio Continente significa ancora una volta guardare la società e la popolazione africane in una prospettiva funzionale all’Europa, auspicando che cresca l’autodeportazione che è in atto in quei Paesi e che ha come conseguenza l’ulteriore aggravamento dei loro problemi economici. Della giustizia è parte fondamentale anche la difesa di se stessi, in caso contrario si tratta non di solidarietà ma di autodistruzione. Se è doloroso ma inevitabile che una potenza meglio armata, consapevole e determinata ne sottometta o distrugga un’altra, è assai meno comprensibile che i soggetti sottomessi collaborino attivamente alla propria distruzione. L’Impero Romano non venne certo cancellato dai cosiddetti barbari ma si dissolse per ragioni interne, alle quali le popolazioni del nord e dell’est aggiunsero soltanto la propria presenza, invocata da molti cristiani come purificatrice della decadenza latina. «La verità è che i barbari hanno beneficiato della complicità, attiva o passiva, della massa della popolazione romana. […] La civiltà romana si è suicidata»[8].
Qualcosa di analogo sta avvenendo nell’Europa contemporanea, uscita sconfitta e miserabile dalle due guerre mondiali del Novecento, vale a dire dalla più distruttiva guerra civile della storia moderna. L’Europa sta infatti implodendo su se stessa per una manifesta incapacità di gestire il proprio presente, affidato al capitalismo globalista sotto la guida statunitense e ai flussi religiosi provenienti dal mondo islamico.
Invece di nutrire ed esercitare prudenza rispetto a queste complesse dinamiche, la più parte degli europei si divide tra i sostenitori di un’accoglienza totale e indiscriminata e i difensori di una pregiudiziale chiusura. Posizioni entrambe inadeguate a comprendere ciò che sta avvenendo. I primi, gli accoglienti, praticano comportamenti dettati dal sentimentalismo umanistico e romantico e dall’universalismo cristiano. Due posizioni ideologiche molto rischiose e che contribuiranno alla fine dell’Europa come sinora è stata conosciuta. Il futuro degli europei è sempre meno in mano agli europei anche a causa del fatto che «la gioventù africana si precipiterà nel vecchio continente, perché è nell’ordine delle cose. […] Secondo le previsioni dell’Onu (United Nations Populations Division 2000: 90), l’arrivo di 80 milioni di migranti nel corso di cinquant’anni porterebbe a una popolazione immigrata di prima e seconda generazione corrispondente al 26% di quella presente nell’Unione Europea […]. Oggi vivono nell’Unione Europea (compreso il Regno Unito) 510 milioni di europei a fronte di 1,3 miliardi di africani sul continente vicino. Entro trentacinque anni, questo rapporto sarà di 450 milioni di europei a fronte di 2,5 miliardi di africani, ossia il quintuplo» (Smith 2018: XII–XIV). Sottovalutare la demografia è scientificamente insensato [9]. Il rapporto tra gli umani e l’ambiente si fonda infatti, come quello di qualsiasi altra specie, soprattutto sul numero. Il numero e la giovinezza dei popoli africani molto probabilmente prevarranno. E alla fine sarà giusto così, di fronte al pervicace cupio dissolvi che sempre più caratterizza l’Europa.
Identità e Differenza
L’umanità è nomade, plurale, meticcia; è Differenza. L’umanità è spazi, legami, comunità; è Identità. Non è possibile comprendere le vicende della nostra specie, la loro complessità, se non si è consapevoli di questa dinamica incessante di scambio e di conservazione, di apertura e chiusura, di ponti di transito e ponti levatoi. Le relazioni tra gruppi umani non sono riducibili alla semplificazione sentimentale e mercantile dei manifesti Benetton di Oliviero Toscani o delle lacrimevoli immagini che invadono i Social Network. Lo spazio e il tempo sono strutture fondamentali. Lo spazio fa sì che, come sostiene il già citato Paul Collier, Stati e Nazioni con enormi risorse e bassa densità abitativa – USA, Australia, Canada, ad esempio – possano giovarsi dell’arrivo di intere popolazioni da altre terre, al contrario dell’Europa che rappresenta una piccolissima propaggine del grande continente asiatico, dove l’arrivo di grandi masse non può che generare conflitti anche gravi e in ogni caso la sottomissione dei nuovi arrivati agli autoctoni o viceversa. Almeno, è questo che da millenni accade alle nostre terre.
Il tempo è costruttore di legami, stratificatore di costumi, creatore di gesti, facitore di culture. L’umano è questo spazio e questo tempo che si incarna nei singoli e nelle collettività. L’umano è socialità, politica, simboli e non soltanto produzione economica e accumulazione finanziaria.
In questo magma materiale e culturale si radicano i popoli e le classi. Essersi illusi di sostituire la centralità di queste strutture e di tali dinamiche con un’omologazione multietnica sentimentale e quindi superficiale ha segnato il tramonto della sinistra e il successo ovunque del populismo, nonostante gli eserciti mediatici e le risorse finanziarie che tentano di criminalizzare tale prospettiva sociale e politica. Per capire il fenomeno migratorio, la sua funzionalità all’ordine liberista e al capitale, sarebbe necessaria la lucidità che emerge ad esempio da un intervento di Carlo Freccero sul manifesto:
«Temo che la sinistra, privata dalla sua classe di riferimento, il proletariato, abbia fatto dei migranti una sorta di foglia di fico per dimostrare di essere ancora dalla parte dei più deboli.
Ma i migranti non sono il nuovo proletariato perché la loro coscienza identitaria non è qui ma altrove. Hanno diritto a non essere culturalmente sradicati, a meno che non si tratti di una loro libera scelta. Viceversa gli abitanti dei quartieri più poveri in Europa, hanno diritto a non essere sradicati dalle loro usanze da parte di un’immigrazione culturalmente eterogenea. I migranti non risiedono in via Montenapoleone e non portano via lavoro agli amministratori delegati. Decidere come fanno le élites che il popolo è brutto sporco e cattivo perché non vuole accoglierli è ingiusto. È il popolo che porta il peso dell’immigrazione con la perdita di valore del lavoro manuale.
La svalutazione del lavoro in questi anni di ordoliberalismo e di euro è stata possibile solo grazie all’esercito di riserva costituito dai migranti. È logico che le élites economiche siano favorevoli all’immigrazione. Le libera dall’incombenza di delocalizzare dove c’è disperazione, portando la disperazione direttamente qui»[10].
Ancora una volta è necessario tener conto di spazio, tempo, numero. Nella Grecia antica gli stranieri erano protetti dalla divinità più importante, da Zeus. E dunque gli obblighi di ospitalità erano inderogabili ma riguardavano singoli o famiglie. In caso contrario l’arrivo era visto come una guerra e in quanto tale veniva legittimamente combattuto. E questo valse soprattutto da quando lo sviluppo delle πόλεις pose la questione dello statuto di cittadinanza, risolta da tutte le città con normative assai rigide. Sia a Sparta sia ad Atene, come in ogni altra città, si cercava soprattutto di garantire l’equilibrio tra gli indigeni e i richiedenti ospitalità. La concessione della cittadinanza era esclusa in partenza, se non per particolari meriti civili, e ad essere accolti erano singoli o famiglie, non interi popoli. Nei rapporti tra gli esseri umani il numero conta perché è anche il numero che crea l’equilibrio tra identità e differenza.
Questa chiave più ampia, e che va ben oltre ogni singolo episodio, penso e credo aiuti a comprendere tragedie come quella di Saman Abbas e della sua famiglia. Interpretare in modo moralistico, sentimentale o ‘politicamente corretto’ una complessa dinamica sociale significa essere «marxisti immaginari», come anni fa scrisse Vittoria Ronchey. Uno dei problemi del presente è che la compassione cristiana e gli interessi del capitale convergono e contribuiscono al dramma dell’Europa.
Dialoghi Mediterranei, n. 52, novembre 2021
Note
[1] A. Ciccozzi, , Diversità che non arricchiscono: la questione dell’estraneità ostile nei reati culturalmente motivati, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 51, settembre-ottobre 2021: 113-131.
[2] P.A. Taguieff, Le Racisme. Un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir, Paris, Flammarion 1997, ed. it. Il razzismo. Pregiudizi, teorie, comportamenti, di F. Sossi, Milano, Raffaello Cortina 1999.
[3] P. Collier, Exodus: How Migration is Changing Our World, Oxford University Press 2013, ed. it. Exodus. I tabù dell’immigrazione, trad. di L. Cespa, Laterza, Roma-Bari 2016.
[4] K. Marx, Das Kapital, libro I, sezione VII, cap. 23, «Das allgemeine Gesetz der kapitalistichen Akkumulation», §§ 3-4.
[5] S. Smith, Fuga in Europa. La giovane Africa verso il vecchio continente, trad. di P. Arlorio, Einaudi, Torino 2018: XII–XIV. Sulla giovinezza dell’Africa si legga l’intero secondo capitolo del libro, dal significativo titolo L’isola-continente di Peter Pan: 29-53. I numeri di pagina delle successive citazioni da questo libro sono indicati nel corpo del testo tra parentesi.
[6] Africa/Nigeria – “Le somme pagate ai trafficanti per finire schiavi in Libia avrebbero potuto creare posti di lavoro in Nigeria”, nota dell’agenzia di stampa cattolica Fides, 15.12.2017.
[7] E. Carrére A Calais, trad. di L. Di Lella e M.L. Vanorio, Adelphi, Milano 2016: 16.
[8] J. Le Goff, La civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Arthaud, 1964, ed. it. La civiltà dell’Occidente medievale, trad. di A. Menitoni, Einaudi, Torino 1983: 22-23.
[9] Lo mostra con ricchezza di argomenti anche Olivier Rey nel suo Dismisura (il significativo titolo originale è Une question de taille, un problema di dimensione), trad. di G. Giaccio, Controcorrente, Napoli 2016.
[10] C. Freccero, Se le élites sono economiche e non culturali, in “il manifesto”, 12.6.2018
Alberto Giovanni Biuso, professore ordinario di Filosofia teoretica nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, dove insegna Filosofia teoretica, Filosofia delle menti artificiali e Sociologia della cultura. È collaboratore, redattore e membro del Comitato scientifico di numerose riviste italiane ed europee. È direttore scientifico della rivista Vita pensata. Tema privilegiato della sua ricerca è il tempo, in particolare la relazione tra temporalità e metafisica. Si occupa inoltre della mente come dispositivo semantico; della vitalità delle filosofie e delle religioni pagane; delle strutture ontologiche e dei fondamenti politici di Internet; della questione animale come luogo di superamento del paradigma umanistico. Nel 2020 ha pubblicato due libri: Tempo e materia. Una metafisica (Olschki Editore), Animalia (Villaggio Maori Edizioni).
______________________________________________________________