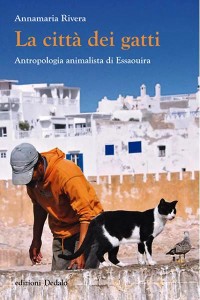L’antropologia in quanto scienza che studia l’uomo dovrebbe costituire per sua stessa ontologia uno strumento attraverso cui abbattere i pregiudizi e i preconcetti, soprattutto razziali e culturali, che ammorbano la società contemporanea. Lo studio e il confronto con altre società potrebbero infatti aiutare a cancellare quel cinismo, spesso frutto dell’ignoranza, che è causa primaria di diffidenza e indifferenza. Paradossalmente, più la tecnologia e il progresso scientifico acquisiscono nuove dimensioni e scoprono nuovi orizzonti, più, come dimostra la cronaca di questi ultimi mesi, si creano muri e barriere sia fisiche sia mentali.
Il nesso perverso e direttamente proporzionale tra progresso scientifico e regresso sociale e culturale si attesta non solo nella relazione tra gli uomini, ma anche in quella tra umano e non-umano e più in generale tra uomo e natura. A guardar bene dentro la torsione di questo rapporto, si constata che proprio in seguito al progresso scientifico si è assistito alla trasformazione degli animali in merce: «la postulazione di una continuità animalità-umanità da parte di tali discorsi naturalistici è solo fittizia poiché in realtà l’unico vero polo del rapporto è costituito dalla cultura, da una cultura particolare, quella occidentale capitalista, che proietta sulla natura la propria inclinazione alla reificazione che trasferisce dal mondo sociale al mondo animale la propria intrinseca ideologia modellata sul feticismo delle merci e sull’individualismo proprietario» (Rivera, 2000: 20).
L’antropologia, dunque, aiuterebbe a comprendere il senso dell’uomo e del rapporto che egli istituisce con gli altri. Tale senso viene approfondito in modo originale, attraverso una prospettiva autobiografica e innovativa, da Annamaria Rivera nel suo ultimo lavoro, La città dei gatti. Antropologia animalista di Essaouira, edito da Dedalo nel 2016. Un viaggio nella città marocchina di Essaouira che la studiosa compie a più riprese, da cui emerge non solo lo sguardo dell’antropologa ma anche l’anima e la sensibilità dell’animalista, e che il lettore può ripercorrere attraverso le strade, i mercati, le botteghe, la costa e i locali affollati da turisti, artisti di strada, ma soprattutto dai protagonisti dell’indagine: cani, gatti e gabbiani.
Una vera e propria etnografia, diversa da quelle a cui la letteratura scientifica ci ha abituato, e corredata di una ricca quanto suggestiva raccolta fotografica; un’etnografia non convenzionale – ci dice la stessa studiosa – che osserva lo strano rapporto stabilito nella città tra gatti, gabbiani, cani e umani, e che partendo proprio da tale rapporto indaga alcuni aspetti in fin dei conti classici della ricerca antropologica come quello relativo alla comunicazione e convivenza tra gli esseri umani. Ciò che la studiosa ci presenta è il frutto dell’osservazione partecipante di tradizione malinowskiana, ma lo spirito da cui muove è profondamente innovativo. I soggetti protagonisti non sono uomini-altri, ma sono gatti, gabbiani e cani, «attori e testimoni di un contesto, quello mogadoriano, che pur con poche contraddizioni, indubbiamente favorisce incontri, relazioni, perfino amicizie intra- specifiche». È l’esperienza stessa della studiosa che viene raccontata in prima persona con tutti i dubbi epistemologici e metodologici che ciò comporta. Così, si legge ad esempio della familiarità, dell’affezione e del rispetto che l’antropologa prova per la fauna locale: si sdraia con il cane, ricerca il gatto che l’aveva colpita in una precedente passeggiata, fa colazione con una coppia di gabbiani con cui perfino sembrerebbe stabilire un rapporto di reciproca fiducia e abitudine. Ma nello stesso tempo si legge del dubbio e della sofferenza che la spiccata sensibilità animalista provoca di fronte alla visione del sacrificio di un montone durante un cerimonia solenne. Il racconto in prima persona diventa, dunque, una strategia narrativa per presentare alcune suggestioni che vanno oltre il troppo semplicistico amore per gli animali, vessillo spesso ormai sbiadito di uomini e donne in una società che tende ad estremizzare ogni aspetto.
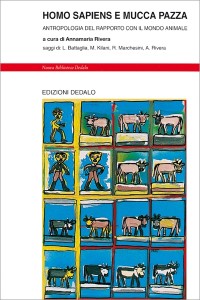 Il testo si apre come una classica etnografia: la collocazione geografica dell’antica Modagor e le vicende storiche della città, il richiamo di artisti e rock star. Una storia di scambi e interazioni culturali che ha reso la città marocchina esempio di cosmopolitismo, di coesistenza fra religioni e popoli diversi come berberi ed ebrei, fino almeno all’avvento del colonialismo francese che segna l’inizio di un peggioramento delle condizioni proprio della comunità ebraica. La storia di Essaouira è dunque processo ed esito di una laboriosa fusione di popoli e religioni, una commistione volta a favorire la rimozione di facili stereotipi culturali che interessano il mondo musulmano. Tuttavia, a parte l’inizio, nulla è convenzionale. La stessa antropologa ribadisce il carattere parziale e sperimentale, ma anche – possiamo aggiungere – innovativo ed estremamente attuale della propria indagine, puntualizzando più volte lo scopo della ricerca sul campo: il racconto del rapporto tra umano e non umano, non in una città dell’Occidente capitalista, ma in uno spazio urbano fortemente identificato con il mondo musulmano dove anche la forma di religiosità popolare stimola e valorizza il rispetto per gli animali. In particolare, l’antropologa descrive il rapporto che si crea tra i reietti della società e i gatti, i gabbiani e i cani.
Il testo si apre come una classica etnografia: la collocazione geografica dell’antica Modagor e le vicende storiche della città, il richiamo di artisti e rock star. Una storia di scambi e interazioni culturali che ha reso la città marocchina esempio di cosmopolitismo, di coesistenza fra religioni e popoli diversi come berberi ed ebrei, fino almeno all’avvento del colonialismo francese che segna l’inizio di un peggioramento delle condizioni proprio della comunità ebraica. La storia di Essaouira è dunque processo ed esito di una laboriosa fusione di popoli e religioni, una commistione volta a favorire la rimozione di facili stereotipi culturali che interessano il mondo musulmano. Tuttavia, a parte l’inizio, nulla è convenzionale. La stessa antropologa ribadisce il carattere parziale e sperimentale, ma anche – possiamo aggiungere – innovativo ed estremamente attuale della propria indagine, puntualizzando più volte lo scopo della ricerca sul campo: il racconto del rapporto tra umano e non umano, non in una città dell’Occidente capitalista, ma in uno spazio urbano fortemente identificato con il mondo musulmano dove anche la forma di religiosità popolare stimola e valorizza il rispetto per gli animali. In particolare, l’antropologa descrive il rapporto che si crea tra i reietti della società e i gatti, i gabbiani e i cani.
Questo approccio se applicato nella nostra società, capitalista e di consumo in cui veganesimo e vegetarianismo sono solo una moda, consente una riflessione nuova ed originale sull’uomo: la tolleranza passa anche attraverso la compassione e il rispetto che la società mostra nei confronti degli animali domestici e non. Non si tratta soltanto di una difesa animalista, ma di rendere sano un rapporto sociale e civile: «ben lontani dall’essere sempre prodotto dell’opulenza contemporanea, (….) la familiarità con gli animali, il rapporto affettivo e di cura nei loro confronti, fino alla simbiosi e al maternage, si configurano, in realtà come un universale antropologico o almeno come un costume decisamente transculturale». In altre parole, la familiarità con gli animali non è esclusiva della società ricca e benestante, non riguarda un genere preciso, quello femminile, ma al contrario è spesso protagonista nelle società che vivono ai limiti della sopravvivenza, dei marginali e dei più poveri. Cosi la coppia gattara, protagonista di uno dei tanti episodi di affezione riportato nel testo, è forse l’immagine più toccante e più identificativa di quel lusso dei poveri di cui parla la studiosa: un uomo e una donna in evidente stato di indigenza, lei nella carrozzina probabilmente paralitica, lui che la spinge, la preoccupazione di entrambi di portare da mangiare ai gatti e la ripetizione dell’azione da parte dell’anziano uomo che continua nel proprio gesto anche dopo la morte della moglie, in una sorta di dono e chissà magari di ricordo della propria amata.
La relazione che intercorre tra umani e non umani, ovvero animali, è argomento su cui l’uomo si è interrogato da millenni, i cui effetti si perpetuano non solo nel nostro modo di vedere gli animali, ma anche nel modo in cui ci approcciamo all’Altro, alla diversità. Infatti, già Aristotele nella Politica sostiene: «solo l’uomo tra tutti gli animali ha la parola […] Questo infatti è il carattere proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, che solo ha la nozione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e di tutte le altri antitesi mentali» (cit. in Buttitta, 1995: 51). A questo modo di pensare, a cui si richiamerà Cartesio, si oppone molti secoli dopo un illuminato Voltaire per il quale «la capacità di sentire, quella di ricordare di collegare le idee tra loro non sono connesse alla capacità di parlare ma sono desumibili – per l’uomo come per l’animale – dal comportamento non verbale» (Battaglia, 2000: 156). Ci sarebbe dunque una continuità tra natura e cultura, tra animali e uomini.
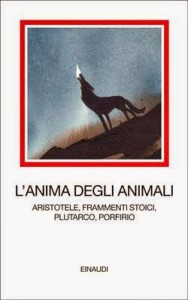 Ma è l’approccio aristotelico che sembra aver resistito nel tempo, che si è propagato nel corso dei secoli e dei millenni ed è proprio tale paradigma responsabile dunque del primato che ha avuto la parola, ovvero il rappresentare, sulla dimensione del fare, così relegando al campo della natura tutto ciò che è legato alla dimensione fisica, anche del lavoro, e veicolando un evidente quanto pericoloso messaggio ideologico attraverso cui dominare e legittimare il proprio arrogante dominio: l’uomo sull’animale, la cultura sulla natura. È innegabile poi la sequela di conseguenze che un tale ragionamento comporta. L’opposizione uomo/animale sot- tende infatti anche un’opposizione cultura/natura, fare/rappresentare: «nella contrapposizione fra natura e cultura l’animale “sta per la natura”, e la cultura nella sua doppia accezione, umanistica e antropologica, sarebbe una caratteristica essenziale nonché esclusiva della specie umana» (Marchesini Tonutti, 2007:13). L’umanità diventa tale solo avendone rimosso tutti i tratti animaleschi e rendendo la cultura uno strumento attraverso cui dirozzare, educare ed elevare l’uomo stesso: «pertanto, la vita spirituale dell’uomo trova negli studia humanitatis non un completamento, bensì il proprio fondamento» (ivi: 17). Nello stesso tempo la sfera animale diventa un modo attraverso cui l’uomo ripensa sì se stesso, ma in termini oppositivi rispetto all’animale.
Ma è l’approccio aristotelico che sembra aver resistito nel tempo, che si è propagato nel corso dei secoli e dei millenni ed è proprio tale paradigma responsabile dunque del primato che ha avuto la parola, ovvero il rappresentare, sulla dimensione del fare, così relegando al campo della natura tutto ciò che è legato alla dimensione fisica, anche del lavoro, e veicolando un evidente quanto pericoloso messaggio ideologico attraverso cui dominare e legittimare il proprio arrogante dominio: l’uomo sull’animale, la cultura sulla natura. È innegabile poi la sequela di conseguenze che un tale ragionamento comporta. L’opposizione uomo/animale sot- tende infatti anche un’opposizione cultura/natura, fare/rappresentare: «nella contrapposizione fra natura e cultura l’animale “sta per la natura”, e la cultura nella sua doppia accezione, umanistica e antropologica, sarebbe una caratteristica essenziale nonché esclusiva della specie umana» (Marchesini Tonutti, 2007:13). L’umanità diventa tale solo avendone rimosso tutti i tratti animaleschi e rendendo la cultura uno strumento attraverso cui dirozzare, educare ed elevare l’uomo stesso: «pertanto, la vita spirituale dell’uomo trova negli studia humanitatis non un completamento, bensì il proprio fondamento» (ivi: 17). Nello stesso tempo la sfera animale diventa un modo attraverso cui l’uomo ripensa sì se stesso, ma in termini oppositivi rispetto all’animale.
Il segno della frattura nella continuità tra natura e cultura è affrontato da Pietro Li Causi e Roberto Pomelli in L’anima degli animali. In una società in cui l’uomo persevera nella distruzione e nello sfruttamento incontrollato ed egoista delle risorse naturali, riflettere o meglio ripensare al modo in cui gli Antichi si sono occupati della questione relativa al rapporto con gli animali potrebbe essere spunto a cui attingere per un progetto antropologico di cambiamento. Dopo secoli, infatti, in cui si è riconosciuto agli animali facoltà sentimentali e intellettive come dimostrano le similitudini omeriche, Aristotele nell’Etica Nicomachea e nella Politica nega, come già ricordato, quelle capacità razionali e segna di fatto una profonda e permanente cesura tra umano e animale. A sorpresa, tuttavia, i due studiosi palermitani ci presentano un Aristotele diverso, quello dell’Historiaia Animalium, in cui da un lato si riconosce all’animale una forma d’intelligenza e dall’altro si ribadisce una relazione ecosistemica con l’ambiente. Se ad Aristotele è imputata una frattura, sono gli stoici che intensificando la differenza tra umani e animali rendono questi ultimi a tutti gli effetti dispositivi antropoeitici: «essi non sviluppano alcuna forma di ragionamento interiore e di conseguenza non hanno alcuna capacità di parlare né di ragionare» (Li Causi, Pomelli, 2015: XXV). Tuttavia, è innegabile che è soprattutto oggi – con le tendenze vegetariane e vegane, con l’assurda distruzione che l’uomo infligge all’ambiente causando la contaminazione ad esempio delle carni di ovini e pollame (si pensi ai casi della mucca pazza o a quelli dell’aviaria) – che si impone una nuova riflessione che non può prescindere dalla zootecnica e dal legame che questa ha con l’antroposfera.
Su questa scia, dunque, l’etnografia animalista, come la definisce Annamaria Rivera, si inserisce e assume un più significativo respiro. Attraverso il racconto della propria esperienza, l’antropologa mostra come la solidarietà tra gli uomini passa sì attraverso il modo in cui questi ultimi si approcciano agli animali, ma diventa anche un modo per affrontare la categoria animale a livello antropologico: «in tutte le culture, in tutti i sistemi di pensiero, infatti, la simbologia animale è fonte indispensabile per la costruzione dell’umano e del culturale» (Rivera, 2000: 7). Si comprende allora il ruolo chiave rivestito dagli animali nel mondo romano: essi sono – come è noto nelle pratiche sacrificali – protagonisti delle credenze divinatorie funzionali alla conoscenza del futuro, ma nello stesso tempo essenziali per modificare la realtà (Burket 2003: 202).
 Proprio sul sacrificio si concentra la studiosa, scardinando o quanto meno mettendo in dubbio le consolidate teorie antropologiche che riconoscono nella violenza uno strumento atto a controllare la violenza stessa. Questo modo di pensare, secondo l’antropologa, nasconde implicitamente una sorte di determinismo naturalistico: «se l’interpretazione del sacrificio quale strumento di garanzia o ripristino dell’equilibrio del gruppo sociale, al prezzo di una violenza minima e stilizzata, è potuto divenire un topos, quasi indiscutibile della teoria antropologica, è anche perché un buon numero di antropologi non sono mai stati sfiorati dall’idea, e dai conseguenti dilemmi, che i non umani siano esseri morali: senzienti, sensibili, affettivi e intelligenti».
Proprio sul sacrificio si concentra la studiosa, scardinando o quanto meno mettendo in dubbio le consolidate teorie antropologiche che riconoscono nella violenza uno strumento atto a controllare la violenza stessa. Questo modo di pensare, secondo l’antropologa, nasconde implicitamente una sorte di determinismo naturalistico: «se l’interpretazione del sacrificio quale strumento di garanzia o ripristino dell’equilibrio del gruppo sociale, al prezzo di una violenza minima e stilizzata, è potuto divenire un topos, quasi indiscutibile della teoria antropologica, è anche perché un buon numero di antropologi non sono mai stati sfiorati dall’idea, e dai conseguenti dilemmi, che i non umani siano esseri morali: senzienti, sensibili, affettivi e intelligenti».
In realtà, l’antropologia ha inserito spesso gli animali nel proprio oggetto di studio individuandoli ora come animale-risorsa, ora come sistemi simbolici, ora come personificazione dell’istinto (Marchesini, Tonutti, 2007: 12-13). Tuttavia, solo da qualche decennio, nella relazione tra umani e non umani, ci si è interrogati sul secondo membro della relazione nel segno di un vero e proprio rinnovamento epistemologico, atto a liberarsi da ciò che Marchesini definisce “trappola dell’antropocentrismo” inteso come arroganza e protervia dell’uomo ad assolutizzare la propria realtà, negando di conseguenza anche soltanto la possibilità di un’esistenza cognitiva dell’animale (Marchesini 2000: 127). Da ciò alla reificazione il passo è dunque breve: «l’animale diventa così una cosa oppure un quasi uomo, la sua identità viene radicalmente mortificata […] l’animale-cosa può essere utilizzata senza alcuna remora e nello stesso tempo non intacca la supremazia e unicità dell’uomo» (ibidem).
Anche oggi la metafora animale viene utilizzata per discretizzare la realtà e, in particolare, per bestializzare gli altri esseri umani, per disumanizzarli. L’animale, dunque, funziona come operatore simbolico con cui l’uomo pensa se stesso e gli altri, con cui rappresenta e spesso inferiorizza gli altri esseri umani per legittimare la propria potenza e il proprio dominio: «tutti coloro la cui cultura è diversa da quella egemone, non rientrando i loro comportamenti nel discretizzato secondo i modelli dominanti, sono associati alla natura. Non appartengono al dominio del logos ma a quello del caos» (Buttitta, 1995: 51).
Anche nel mondo latino gli animali, protagonisti dei prodigii, sono elementi della tradizione attraverso cui legittimare la supremazia romana. La natura si piega alla cultura al fine di proiettare quest’ultima come mezzo e strumento di potere. In questo contesto, l’animale potrebbe anche essere un monstrum che si presenta come un essere animale o umano privo di organi e di parti vitali, oppure come un essere umano o animale con parti superflue. Segni, questi, della rottura della pax deorum, di quel patto che attraverso il sacrificio rituale garantiva il ripristino del cosmos. Il carattere simbolico era dunque presente anche nel mondo antico e riguardava, sostiene Sperber, anche la categoria mostruosa nelle credenze popolari. Per Sperber, gli animali fantastici possiedono un carattere simbolico latente, in quanto le tassonomie sono aperte ed hanno un numero infinito di posizioni per le nuove specie, che si andranno ad aggiungere a quelle già scoperte. L’uomo contemporaneo ha forzato volutamente tali tassonomie mediante la creazione della zootecnica. All’epoca degli antichi Romani non esisteva di certo la zootecnica e chissà cosa penserebbero della possibilità di manipolare geneticamente il corpo animale allo scopo di renderlo più produttivo e trasformarlo così in un “bene di rapido consumo”(Marchesini, 2000: 133). Chissà cosa penserebbero gli antichi Romani dello scimpanzuomo che negli anni Ottanta è stato creato in laboratorio! Siamo passati, infatti, da un rapporto simbiotico con la natura ad un rapporto dicotomico con essa a causa di un cambiamento della stessa definizione di scienza: non più un modo per ripensare e valutare le realtà possibili, ma arrogante e cieca certezza che giudica come oggettiva una realtà del tutto soggettiva.
 L’indagine, o meglio il racconto, di Rivera ha dunque un duplice merito: da un lato attraverso la rappresentazione della città degli elisei tenta di scardinare quei pregiudizi, cliché e stereotipi che purtroppo ormai sono intimamente legati ovvero connaturati al mondo musulmano; dall’altro inserisce nella ricerca antropologica ed etnografica un nuovo soggetto, quello rappresentato dagli animali. Così, seguendo un processo tipico dell’antropologia, quale quello dell’opposizione e del decentramento posizionale, è possibile delineare l’uomo in base a ciò che non è uomo. Ciò che era già emerso nella riflessione, ad esempio, dei filosofi greci, oggi è assai difficile comprendere a causa della ricerca a tutti i costi di un’oggettività artificiosamente creata e più spesso forzata e di un ragionamento astrattamente dicotomico. Tale procedimento mentale conduce alla constatazione quasi rassegnata che «se certi gruppi sono stati considerati sterminabili è anche perché numerose specie di altri viventi lo sono stati prima di loro». Legittimare il massacro, il sacrificio in nome della scienza e della cosmetica equivale così a legittimare il massacro di esseri umani in nome della purezza della razza, della superiorità della specie.
L’indagine, o meglio il racconto, di Rivera ha dunque un duplice merito: da un lato attraverso la rappresentazione della città degli elisei tenta di scardinare quei pregiudizi, cliché e stereotipi che purtroppo ormai sono intimamente legati ovvero connaturati al mondo musulmano; dall’altro inserisce nella ricerca antropologica ed etnografica un nuovo soggetto, quello rappresentato dagli animali. Così, seguendo un processo tipico dell’antropologia, quale quello dell’opposizione e del decentramento posizionale, è possibile delineare l’uomo in base a ciò che non è uomo. Ciò che era già emerso nella riflessione, ad esempio, dei filosofi greci, oggi è assai difficile comprendere a causa della ricerca a tutti i costi di un’oggettività artificiosamente creata e più spesso forzata e di un ragionamento astrattamente dicotomico. Tale procedimento mentale conduce alla constatazione quasi rassegnata che «se certi gruppi sono stati considerati sterminabili è anche perché numerose specie di altri viventi lo sono stati prima di loro». Legittimare il massacro, il sacrificio in nome della scienza e della cosmetica equivale così a legittimare il massacro di esseri umani in nome della purezza della razza, della superiorità della specie.
Dall’intersezione di queste due prospettive deriva un’opera originale – a ragione la stessa studiosa nell’introduzione parla di sperimentalismo a proposito della propria etnografia – adatta non solo agli addetti ai lavori, ma anche a tutti coloro che sono sensibili ai temi ambientali. Lungi dal volere equiparare gli animali agli esseri umani, pericolo questo sotteso spesso ad atteggiamenti estremisti e integralisti nei confronti dei non umani, Annamaria Rivera, animalista e antropologa ci insegna a non sottovalutare che gli animali partecipano della società e il rapporto che l’uomo istituisce con essi veicola messaggi sociali, ideologie e valori. Così, ciò che l’antropologa ha definito lusso dei poveri diventa un modo per i reietti di svincolarsi dal bisogno e di sentirsi liberi. Umanizzare l’animale, infatti, equivale a incorrere nuovamente nella trappola dell’antropomorfismo, quando, al contrario, è più opportuno «restaurare una razionalità aperta, capace di dialogare con una realtà che le resiste, con ciò che appare, a un’analisi sommaria, oscuro e irrazionale, misterioso» (Battaglia, 2000: 157).
Se non altro l’etnografia animalista insegna che la tolleranza, il rispetto, la compassione e la solidarietà passano anche per il rapporto che le diverse società intrattengono con le altre specie. In altre parole, c’è un «legame estrinseco tra sessimo, specismo e razzismo», per citare l’autrice. Attraverso la tolleranza intesa come non assolutizzazione della realtà, è possibile abbattere i pericoli dell’antropocentrismo: «il tollerante, infatti, non confonde i confini, è il fanatico che vuole distruggerli» (ivi: 150). E in una società assuefatta dall’odio e dal pregiudizio e dallo sfruttamento ambientale e umano urgerebbe farsi carico dell’esigenza della dignità e del rispetto degli altri umani e delle altre specie. “La città dei gatti” diventa dunque metafora esemplare, un modello sociale di attenzione verso il prossimo che potremmo prendere come riferimento facendo appello a quell’augurio di Voltaire che continua ad essere una preghiera tristemente inascoltata: «Fa’ che ci aiutiamo l’un l’altro a sopportare il fardello di un’esistenza penosa e passeggera […] Che tutte le piccole sfumature tra questi atomi chiamati uomini non siano segnali di odio e di persecuzioni» (ivi: 149). Solo così la città dei gatti diventa la città degli uomini e sarà proprio la disciplina antropologica a dare gli strumenti e le categorie ermeneutiche perché l’uomo intervenga nella salvaguardia di sé e contestualmente della diversità della specie.
Dialoghi Mediterranei, n.20, giugno 2016
Riferimenti bibliografici
Luisella Battaglia, Ai confini della tolleranza. Voltaire e la comunità terrestre, in A. Rivera, a cura, Homo sapiens e mucca pazza, Dedalo, Bari 2000: 149-173
Walter Burkert, Creation of the Sacred: Tracks of biology in early religions, 1996, trad. it., La Creazione del Sacro: orme biologiche nell’esperienza religiosa, Adelphi, Milano 2003
Antonino Buttitta, L’Effimero sfavillio, Flaccovio, Palermo 1995.
Pietro Li Causi, Roberto Pomelli, L’anima degli animali, Einaudi, Torino 2015.
Roberto Marchesini, La fabbricazione dei viventi: dall’animale-partner all’animale-macchina, in A. Rivera, a cura, Homo sapiens e mucca pazza, Dedalo, Bari 2000: 113-147
Roberto Marchesini, Sabrina Tonutti, Manuale di zooantropologia, Meltemi, Roma 2007.
Annamaria Rivera, La città dei gatti. Antropologia animalista, Dedalo, Bari 2016.
Annamaria Rivera (a cura di), Homo Sapiens e Mucca Pazza Antropologia del rapporto con il mondo animale, Dedalo, Bari, 2000.
Manès Dan Sperber, Pourqouis les animaux parfaits, les hybrises et les mostre sont-ils bons à penser symboliquement, in «L’Homme», 1975, 15, 2: 5-34
http://www.fahrenheit.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-4dfd4443-4a6d-4337-b867-ef615efe3d03.html#p=0
_______________________________________________________________________________
Virginia Lima, giovane laureata in Beni Demoetnoantropologici e specializzata in Antropologia culturale ed Etnologia presso l’Università degli Studi di Palermo, ha orientato parte dei suoi interessi scientifici verso l’antropologia del mondo antico, approfondendo la funzione culturale del prodigium inteso non solo come momentanea rottura dell’ordine cosmico ma anche come strumento della memoria culturale del popolo romano.
________________________________________________________________