dopo saman
di Enzo Pace
Mentre leggevo l’articolo d’Antonello Ciccozzi [1] mi è tornato in mente Neve (kar) di Orhan Pamuk [2]. Come in un giallo – ma non è un giallo – l’autore si cala nei panni di un improvvisato investigatore (turco-tedesco) che vuole scoprire perché in una piccola e remota città della Turchia orientale si registri un così alto numero di suicidi di donne. Siamo a Kars, ai confini con l’Armenia (si conserva, sia detto per inciso, in buono stato la chiesa dei Dodici Apostoli risalente al X secolo) e la Georgia. Una cittadina di 150 mila abitanti, turchi di culture e lingue diverse: armeni, georgiani, curdi, hazari più vari profughi afghani. Le donne si suicidano a Kars perché non sopportano che venga loro imposto di togliersi lo hijab. Sulle loro teste si scaricano tutte le tensioni di un conflitto ideologico-politico di relativa lunga durata che ha diviso e divide la Turchia post-ottomana. Kars è come una stretta stanza dove sono costretti a vivere degli estrenei che diventano sempre più nemici fra loro. Da un lato, i radicali difensori della fede (musulmani di tendenza neo-fondamentalista) e dall’altro, i radicali difensori del laicismo dello Stato (kemalisti orfani di Atatürk). Uno scontro che passa sopra le teste delle donne, dunque: si sentono strappare di dosso un abito del cuore che altri vorrebbero, invece, imporre come regola vincolante. In entrambi i casi, il verbo imporre….s’impone.
 Non solo in Turchia. Nel 2004, il parlamento francese ha votato la legge che vieta “l’ostentazione” di ogni tipo di simbolo religioso. Il caso che ha portato a questa decisione rimonta al 1989, quando tre studentesse francesi, figlie di migranti d’origine marocchina, si sono presentate in classe al liceo di Creil (nell’Oise, Alta Francia) con il foulard islamique, come fu raccontato il giorno dopo da Le Figaro. La commissione nominata da Chirac a lungo discusse e, alla fine deliberò, non all’unanimità (con la sofferta astensione di un sociologo come Jean Baubérot [3] che ha dedicato i suoi studi proprio al tema della laicità in Francia) sulla necessità o meno di ribadire l’esclusione di qualsiasi segno religioso nello spazio pubblico. In realtà, all’inizio l’argomento dibattuto era solo lo hijab. Sennonché, gli illuminati esperti compresero subito che prendersela solo con questo pezzo di stoffa avrebbe contraddetto il principio costituzionale d’égalité: non si poteva vietare un simbolo ritenuto distintivo di una religione come l’islam senza tenere conto di simboli di altre religioni (la kippa degli ebrei, il turbante dei sikh, le croci portate addosso dai cattolici e ortodossi e così via).
Non solo in Turchia. Nel 2004, il parlamento francese ha votato la legge che vieta “l’ostentazione” di ogni tipo di simbolo religioso. Il caso che ha portato a questa decisione rimonta al 1989, quando tre studentesse francesi, figlie di migranti d’origine marocchina, si sono presentate in classe al liceo di Creil (nell’Oise, Alta Francia) con il foulard islamique, come fu raccontato il giorno dopo da Le Figaro. La commissione nominata da Chirac a lungo discusse e, alla fine deliberò, non all’unanimità (con la sofferta astensione di un sociologo come Jean Baubérot [3] che ha dedicato i suoi studi proprio al tema della laicità in Francia) sulla necessità o meno di ribadire l’esclusione di qualsiasi segno religioso nello spazio pubblico. In realtà, all’inizio l’argomento dibattuto era solo lo hijab. Sennonché, gli illuminati esperti compresero subito che prendersela solo con questo pezzo di stoffa avrebbe contraddetto il principio costituzionale d’égalité: non si poteva vietare un simbolo ritenuto distintivo di una religione come l’islam senza tenere conto di simboli di altre religioni (la kippa degli ebrei, il turbante dei sikh, le croci portate addosso dai cattolici e ortodossi e così via).
Dietro l’argomento del trattamento paritario di tutte le religioni, tuttavia, c’era dell’altro. Quasi tutti i componenti della commissione pensavano che, proibendo l’ostentazione di tutti questi simboli, compreso il velo, le comunità musulmane di Francia avrebbero alla fine accettato (assimilato?) il principio della necessaria separazione fra Stato e religione. Un intervento fermo, quindi, simile a quello compiuto in tempi passati nei confronti della Chiesa cattolica, divenuta ormai convinta sostenitrice che tale separazione la renda più libera da ogni tentazione politica.
 La Turchia e la Francia hanno, ça va sans dire, storie diverse, ma curiosamente il foulard li divide. La Turchia moderna, sotto la guida di Mustafa Kemal Atatürk, scelse di modellare lo Stato post-ottomano non voltandosi indietro, bensì guardando verso l’Europa. Fu abolito il califfato nel 1923 e instaurata una repubblica laica. Lo scrivo in corsivo perché, se è vero che il Padre della moderna Turchia porta a compimento il processo avviato con le riforme dell’Ottocento (tanzimat) e sterilizza definitivamente il principio di legittimazione religiosa del potere politico, con tutta una serie di drastici provvedimenti (dalla cancellazione del sistema normativo fondato sulla shari ̔a alla liquidazione dei beni delle turuq, le confraternite di matrice sufi, vera spina dorsale dell’islam vissuto, dal divieto del velo per le donne alla proibizione d’indossare il fez per gli uomini), è altresì vero che la moderna repubblica trasformerà l’islam in un vero e proprio apparato ideologico di Stato (per tornare ad Althusser). Le donne turche si tolsero il velo, alcune con un senso di liberazione, altre con sofferenza, altre ancora con risentimento.
La Turchia e la Francia hanno, ça va sans dire, storie diverse, ma curiosamente il foulard li divide. La Turchia moderna, sotto la guida di Mustafa Kemal Atatürk, scelse di modellare lo Stato post-ottomano non voltandosi indietro, bensì guardando verso l’Europa. Fu abolito il califfato nel 1923 e instaurata una repubblica laica. Lo scrivo in corsivo perché, se è vero che il Padre della moderna Turchia porta a compimento il processo avviato con le riforme dell’Ottocento (tanzimat) e sterilizza definitivamente il principio di legittimazione religiosa del potere politico, con tutta una serie di drastici provvedimenti (dalla cancellazione del sistema normativo fondato sulla shari ̔a alla liquidazione dei beni delle turuq, le confraternite di matrice sufi, vera spina dorsale dell’islam vissuto, dal divieto del velo per le donne alla proibizione d’indossare il fez per gli uomini), è altresì vero che la moderna repubblica trasformerà l’islam in un vero e proprio apparato ideologico di Stato (per tornare ad Althusser). Le donne turche si tolsero il velo, alcune con un senso di liberazione, altre con sofferenza, altre ancora con risentimento.
La Turchia, in ogni caso, divenne alla lunga un modello nel periodo storico che vede emergere dal Maghreb al Mashreq i movimenti di lotta per l’indipendenza anti-coloniale. In nome della liberazione dallo “straniero”, questi movimenti riuscirono per un breve tratto di storia a tenere assieme le varie tendenze culturali, sociali e religiose presenti in queste società, spesso storicamente caratterizzate da pluralismo religioso e dalla polarizzazione ideologico-politica. Non tutte le anime, in verità, confluirono, giacché i movimenti di risveglio puritano del XVIII secolo (del ritorno al puro islam, così come immaginato, per esempio, da ̔Abd al-Wahhāb) avevano già preso una loro strada autonoma per contrastare il colonialismo. Un punto qualificante che li differenziava da quelli unitari e transconfessionali che si mobilitavano per l’indipendenza era il ruolo attivo riconosciuto alle donne nella lotta politica. Tra queste ultime, infatti, militavano gruppi che avevano intuito di essere a un tornante della storia non solo politica, ma anche sociale dei loro rispettivi Paesi. Erano donne che si svelavano, giacché togliersi il velo era considerato un modo per parlare della liberazione di tutte le donne dai vincoli propri di una società patriarcale e tribale, rinsaldate nel respiro lungo della storia dalle protesi religiose che uomini al potere e dotti di corte avevano con cura messo a punto per tenere in piedi un sistema sociale fondato sul principio della femina hierarchica [4].
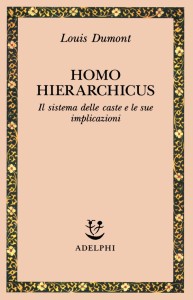 Le nuove élite che guidavano tali movimenti e che sono diventate poi le classi dirigenti degli Stati nazionali post-coloniali non avevano in mente la creazione di Stati islamici né tanto meno d’instaurare un ordinamento giuridico la cui unica e suprema fonte fosse la shari ̔a. Non penso immediatamente solo alla vicenda della Tunisia moderna, sotto la guida di Bourghiba, ma anche alle varie nuove classi dirigenti che si sono affermate in altri Paesi del Mashreq (Siria, Iraq, Libano, Egitto) e del Maghreb (Algeria, Libia).
Le nuove élite che guidavano tali movimenti e che sono diventate poi le classi dirigenti degli Stati nazionali post-coloniali non avevano in mente la creazione di Stati islamici né tanto meno d’instaurare un ordinamento giuridico la cui unica e suprema fonte fosse la shari ̔a. Non penso immediatamente solo alla vicenda della Tunisia moderna, sotto la guida di Bourghiba, ma anche alle varie nuove classi dirigenti che si sono affermate in altri Paesi del Mashreq (Siria, Iraq, Libano, Egitto) e del Maghreb (Algeria, Libia).
Nel 1956 il presidente tunisino annuncerà la cancellazione della poliginia, ricorrendo a una esegesi modernista del Corano, accompagnata da due rilevanti riforme sociali: l’innalzamento dell’obbligo scolastico per tutti e dell’età matrimoniale per le ragazze. In una generazione e mezza, è accaduto così che il tasso di fecondità sia passato da 6,9 per donna nel 1960 all’1,9 del 2005. Tale indice, dopo essere risalito leggermente nel 2009, si è attestato stabilmente attorno all’1,9. Se compariamo il caso tunisino con altri Paesi vediamo come, magari con più lentezza, la tendenza alla transizione demografica si è compiuta o sta per compiersi [5]. Può essere istruttivo, a tal proposito, richiamare il caso dell’Iran: il tasso di fecondità dal 2009 si mantiene al di sotto della soglia del 2% (tasso di sostituzione), tant’è che non appena salito al potere, il pasdaran Ahmadinejad aveva lanciato nel 2010 un nuovo piano per incrementare le nascite per poter arrivare, entro un decennio, a quota 150 milioni, quasi raddoppiando la popolazione attuale. Se confrontiamo il caso iraniano con i Paesi confinanti, l’Iraq (4,6) e l’Afghanistan (5,2) mantengono ancora un tasso di fecondità elevato (4,1) a fronte, invece, dell’abbassamento, per esempio, avvenuto rispettivamente in Turchia (2,1) e in Siria (2,8).
L’indice appena richiamato da solo non spiega molto; se correlato con un altro importante indicatore di mutamento sociale, quale l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione (tenendo sotto controllo sia l’alfabetizzazione rispetto al genere sia l’andamento nel tempo del grado d’istruzione progressivamente raggiunto da donne e uomini), allora diventa rilevante per misurare se e in che modo i rapporti asimmetrici tra donna e uomo siano cambiati in una determinata società. Se il mutamento dei modelli procreativi non abbia a che fare con la mobilità sociale e culturale delle donne. Ciò che risulta, comparando con l’aiuto di questi macro-dati diverse società a maggioranza musulmana nel mondo, è il relativo peso del fattore religioso in tale processo rispetto ad altre dimensioni sociali, come, per esempio, la persistenza dei matrimoni endogamici, la patrilocalità (la tendenza dei figli maschi a risiedere nei pressi dell’abitazione paterna), la prassi delle spose bambine, il costo della dote per la prima figlia femmina da maritare, l’ineguale ripartizione dell’eredità e così via. Un insieme di usi e costumi, istituzioni e regole proprie di società di tipo tribale e patriarcale, di cui c’è memoria in parte già nel Corano e che la grande macchina imperiale dei califfi omayyade prima e ̔abbasidi poi (fra l’VIII e il XI secolo) finirà per legittimare alla stregua di norme compatibili con le fonti del diritto coranico (testo sacro, tradizione orale, giurisprudenza consolidata degli esperti e dotti, sforzo interpretativo, quando ammesso dalla varie scuole di fiqh). Gli ottomani con l’invenzione di un sistema giuridico parallelo – il qānūn – ampliarono flessibilmente il campo del riconoscimento di tali usi e costumi. Per cui, per un verso l’islam “c’entra”, per un altro, siamo di fronte a una sorta di processo di secolarizzazione istituzionale (tramite il diritto) di un messaggio religioso che tende a adattarsi, riproducendolo, a un ordine sociale fondato sul primato del familismo, del sistema di parentela e clientela, che Muhammad mostra invece di voler superare in nome di un’etica che non riconosce più il vincolo di sangue come regolatore sociale, giacché un altro legame viene affermato, quello della fratellanza e sorellanza di tipo spirituale (“dite alle credenti e ai credenti”), che rende tutti uguali davanti al Dio unico.
Come scriveva Mahmoud Mohamed Taha, maestro sufi sudanese, condannato a morte dal dittatore Nimeyri (al potere fra il 1971 e il 1985) nel suo libro The Second Message of Islam [6], nel grande corpus della tradizione scritta e orale islamica è possibile trovare un nucleo originario del messaggio profetico, che è stato troppo a lungo soffocato dalle esigenze degli imperi dinastici (una caratteristica non certo esclusiva dell’islam; anche il cristianesimo è stato piegato alla logica imperiale così come una via ascetica come il buddismo, che non voleva essere una religione, lo diventa ad opera di un principe indiano, Ashoka, nel III secolo a.C.). Questo nucleo è ciò che egli chiamava il secondo messaggio dell’islam, non ancora pienamente affermato: una parola viva rinnovata rimasta troppo a lungo lettera morta.
P uò essere utile ricordare che Nimeyri, dopo aver preso il potere con un colpo di stato militare nel 1969, instaura un regime autoritario verniciato di rosso, abbracciando, infatti, dapprima l’ideologia socialista panaraba, collaborando strettamente sia con il leader egiziano Nasser sia con quello libico Qhaddafi, per poi avvicinarsi progressivamente alla Cina di Mao in funzione anti-sovietica. Nel 1983, Nimeyri, per rafforzare il suo consenso, si appoggia all’emergente movimento di tipo fondamentalista islamico di Hasan Tourabi. Questo movimento diverrà egemone all’indomani della caduta di Nimeyri, grazie alla presa di potere da parte di un generale, Omar Bashir, la cui lunga dittatura terminerà solo due anni fa, salutata da una mobilitazione sociale e politica, che ha visto la partecipazione attiva di donne impegnate nella battaglia al tempo stesso per la democratizzazione del loro Paese e per l’emancipazione femminile. Sarà Nimeyri nel 1983 a elevare la shari ̔a a fonte ultima del diritto, estendone il vigore su tutto il territorio nazionale, anche nel Sud del Paese, dove vivono popolazioni cristiane o legate alle religioni tradizionali.
uò essere utile ricordare che Nimeyri, dopo aver preso il potere con un colpo di stato militare nel 1969, instaura un regime autoritario verniciato di rosso, abbracciando, infatti, dapprima l’ideologia socialista panaraba, collaborando strettamente sia con il leader egiziano Nasser sia con quello libico Qhaddafi, per poi avvicinarsi progressivamente alla Cina di Mao in funzione anti-sovietica. Nel 1983, Nimeyri, per rafforzare il suo consenso, si appoggia all’emergente movimento di tipo fondamentalista islamico di Hasan Tourabi. Questo movimento diverrà egemone all’indomani della caduta di Nimeyri, grazie alla presa di potere da parte di un generale, Omar Bashir, la cui lunga dittatura terminerà solo due anni fa, salutata da una mobilitazione sociale e politica, che ha visto la partecipazione attiva di donne impegnate nella battaglia al tempo stesso per la democratizzazione del loro Paese e per l’emancipazione femminile. Sarà Nimeyri nel 1983 a elevare la shari ̔a a fonte ultima del diritto, estendone il vigore su tutto il territorio nazionale, anche nel Sud del Paese, dove vivono popolazioni cristiane o legate alle religioni tradizionali.
Tutto ciò porterà poi alla secessione definitiva del Sud-Sudan. Il colpo di stato organizzato nel 2019 dai militari per destituire Omar Bashir è stato salutato da manifestazioni pacifiche nelle strade di Khartum. Una delle molte protagoniste della protesta, la segretaria dell’ONG “Sudanese Woman in Action” ha chiesto che il nuovo governo cancelli tutte quelle norme, surrettiziamente giustificate in base alla shari ̔a, che consentono i matrimoni combinati, in particolare fra uomini anziani e bambine, e che s’introducano pene severe contro tutte le forme di violenza domestica, compresa lo stupro fra coniugi. Mahmoud Taha, è bene ricordalo, viene arrestato nel gennaio del 1985 accusato di apostasia, perché aveva osato scrivere un pamphlet contro l’introduzione della shari ̔a in Sudan. Si rifiutò di riconoscere il tribunale religioso che lo avrebbe giudicato colpevole e condannato a morte. Insomma, la shari ̔a, com’è avvenuto altrove e prima del Sudan, è un campo occupato da forze politiche che si fronteggiano e che usano il corpo della donna – da coprire più o meno integralmente – come oggetto di una contesa cui le donne stesse di fede musulmana cercano di sottrarsi, gridando dai tetti la loro voce.
Così come la transizione demografica in atto nei Paesi a maggioranza musulmana ci parla dei cambiamenti nei rapporti di genere, i riferimenti ai conflitti attorno al primato della shari ̔a ci dicono come si sono polarizzate, violentemente in vari casi, le diverse narrazioni dell’islam in gran parte delle società che sono dal 1961 a oggi i luoghi di partenza di persone migranti. Società in movimento con grandi attese e speranze di cambiamento, spesso deluse e frustrate per l’ingranarsi dell’istinto di conservazione del potere da parte di regimi autoritari (o sotto il segno dell’elmetto o sotto quello del turbante o con l’alleanza dell’uno con l’altro) [7] con l’interesse delle ex-potenze coloniali e dei nuovi padroni del mondo pronti a sostenerli per ragioni economiche e geopolitiche (l’Egitto è l’ultimo caso esemplare, a tal proposito). Un concorso di colpe che già abbiamo potuto vedere in Algeria – primo laboratorio della polarizzazione violenta fra elmetto e turbante – negli anni Novanta e che si prolunga in ciò che sta accadendo a Kabul mentre scrivo.
Fra Algeri e Kabul, in mezzo un ciclo di lotte sociali e politiche, i cui protagonisti sono movimenti collettivi di segno opposto: chi si batte per la democrazia, la difesa dei diritti fondamentali della persona, la fine di regimi autoritari corrotti, un avvenire dignitoso per la low cost generation (che noi ben conosciamo in Europa); chi pensa sia possibile coniugare sviluppo economico (di stampo liberale) e giustizia sociale (ispirandosi all’islam); chi crede fermamente che non ci sia altro da fare che combattere con le armi i nemici interni ed esterni (dividendosi, tuttavia, sulle tattiche e sugli obiettivi finali: un nuovo califfato oppure una riedizione dell’internazionale delle nazioni non-allineate, proletarie musulmane); chi, infine, pensa e dice che è venuto il momento di una riforma religiosa in nome di un islam progressivo e illuminato, che porti a compimento il lavoro emrneutico iniziato tempo fa da studiosi e intellettuali come, tra gli altri, Mohammed Arkoun o Nasr Abu Zayd e proseguito da un gruppo di studiosi di nuova generazione che ha scelto come etichetta per farsi riconoscere, il titolo del progressive islam.
 Su questo sfondo storico e sociale, parlare d’islam al singolare è divenuto impossibile. C’è una lotta, ci sono conflitti e la diversità è la regola. Da questo punto di vista, se ho ben compreso il pensiero di Ciccozzi, ha senso ancora discutere se l’islam dei migranti e dei loro discendenti di seconda e terza generazione (questi ultimi non più migranti, ma cittadini europei) c’entri o meno nella determinazione di comportamenti criminosi (dall’assassinio della giovane italo-pakistana Saman Abbas ai tanti efferati attentati compiuti, in particolare in Europa dal 2004 a oggi) e se sia l’islam nella sua versione tradizionalista a impedire l’integrazione sociale di tanti migranti di fede musulmana? I conflitti fra generazioni, i mutati rapporti di genere, il cambiamento degli stili di vita e di consumo delle nuove generazioni sono emersi da tempo anche nei Paesi d’origine dei padri e delle madri (o dei nonni e delle nonne) che hanno scelto di migrare. L’islam, la shari ̔ a, lo Stato islamico per una parte delle nuove generazioni della Riva sud del Mediterraneo vogliono dire poco o niente, non occupano probabilmente giorno e notte i loro pensieri. Per un’altra l’islam torna a parlare come religione del cuore e dell’identità culturale. Per un’altra ancora l’islam è una bandiera (nera o bianca a seconda del brand jihadista che i movimenti scelgono per distinguersi nel mercato della lotta armata) da agitare contro i nuovi imperialismi economici, politici e culturali dell’odiato Occidente.
Su questo sfondo storico e sociale, parlare d’islam al singolare è divenuto impossibile. C’è una lotta, ci sono conflitti e la diversità è la regola. Da questo punto di vista, se ho ben compreso il pensiero di Ciccozzi, ha senso ancora discutere se l’islam dei migranti e dei loro discendenti di seconda e terza generazione (questi ultimi non più migranti, ma cittadini europei) c’entri o meno nella determinazione di comportamenti criminosi (dall’assassinio della giovane italo-pakistana Saman Abbas ai tanti efferati attentati compiuti, in particolare in Europa dal 2004 a oggi) e se sia l’islam nella sua versione tradizionalista a impedire l’integrazione sociale di tanti migranti di fede musulmana? I conflitti fra generazioni, i mutati rapporti di genere, il cambiamento degli stili di vita e di consumo delle nuove generazioni sono emersi da tempo anche nei Paesi d’origine dei padri e delle madri (o dei nonni e delle nonne) che hanno scelto di migrare. L’islam, la shari ̔ a, lo Stato islamico per una parte delle nuove generazioni della Riva sud del Mediterraneo vogliono dire poco o niente, non occupano probabilmente giorno e notte i loro pensieri. Per un’altra l’islam torna a parlare come religione del cuore e dell’identità culturale. Per un’altra ancora l’islam è una bandiera (nera o bianca a seconda del brand jihadista che i movimenti scelgono per distinguersi nel mercato della lotta armata) da agitare contro i nuovi imperialismi economici, politici e culturali dell’odiato Occidente.
Una giovane coppia di tunisini del ceto medio può oggi immaginare di prendere una piccola barca, attraversare il periculosum mare (il Mediterraneo, ex-nostrum) e approdare in Europa. Non sa bene con chi deve prendersela. Non sta né con il partito d’ispirazione islamista né con chi ha sospeso la vita democratica e represso tutte le manifestazioni di protesta. Percepisce solo drammaticamente che la qualità della vita e le prospettive di miglioramento economico continuano a ridursi e aggrapparsi all’islam in tutto questo serve poco. Meglio l’Europa, in ogni caso, anche se l’ostilità nei confronti dei migranti e, in particolare, del migrante-musulmano (vai tu a spiegare che potrebbe essere anche cristiano, se provenisse, per esempio dall’Egitto o dalla Siria) è cresciuta. Sa che potrà andare incontro a frustrazioni e potrà sentirsi estraneo. Non penso, però, che arriverà a toccare le sublimi vette dell’ostilità che i movimenti di destra sorti contro “l’islamizzazione” dell’Europa hanno ormai prodotto in forme ben temperate. Questa nostra coppia non si sentirà a proprio agio; potrà rischiare di ripiegarsi su sé stessa. Sperava nel cambiamento, dopo la fine del regime di Ben ̔Alī Zayn al-̔Abidīn, un regime che aveva trovato ampio credito e sostegni finanziari da parte europea e americana. La stessa cosa si potrebbe dire dei tanti giovani (uomini e donne e non solo Zaki) che, dopo aver partecipato alle proteste di piazza al-Tahrir al Cairo, si sono trovati costretti a riparare altrove, molti in Europa.
 Parlo di ostilità a bella posta a commento di quanto Ciccozzi scrive a proposito di un’altra ostilità: quella che nutre il migrante che si sente estraneo nella società in cui ha deciso di vivere. Ciccozzi, nel ricorrere alla formula dell’estraneità ostile del migrante, allude ai genitori di Saman Abbas, che, comunque, se fosse provata la loro responsabilità penale, anche nella loro patria d’origine si sarebbero macchiati di un crimine, previsto da una legge varata in Pakistan nel 2016 [8]. C’è da chiedersi se la loro estraneità derivi effettivamente dal sentimento di appartenenza a una comunità di fede oppure dall’attaccamento a usi e costumi che rimandano all’idea secondo cui il matrimonio è un contratto che va siglato fra due capifamiglia e su questo punto non c’è negoziazione possibile e il conformismo sociale trionfa. L’estraneità, in ogni caso, è un sentimento che divide. Saman Abbas non lo condivideva così come tante altre giovani donne cittadine europee (di fatto o di pieno jure) con origini straniere. Si può dire, allora, che Saman Abbas fosse ben assimilata e i suoi genitori e parenti no? E per questa ragione (si presume) sia stata uccisa ?
Parlo di ostilità a bella posta a commento di quanto Ciccozzi scrive a proposito di un’altra ostilità: quella che nutre il migrante che si sente estraneo nella società in cui ha deciso di vivere. Ciccozzi, nel ricorrere alla formula dell’estraneità ostile del migrante, allude ai genitori di Saman Abbas, che, comunque, se fosse provata la loro responsabilità penale, anche nella loro patria d’origine si sarebbero macchiati di un crimine, previsto da una legge varata in Pakistan nel 2016 [8]. C’è da chiedersi se la loro estraneità derivi effettivamente dal sentimento di appartenenza a una comunità di fede oppure dall’attaccamento a usi e costumi che rimandano all’idea secondo cui il matrimonio è un contratto che va siglato fra due capifamiglia e su questo punto non c’è negoziazione possibile e il conformismo sociale trionfa. L’estraneità, in ogni caso, è un sentimento che divide. Saman Abbas non lo condivideva così come tante altre giovani donne cittadine europee (di fatto o di pieno jure) con origini straniere. Si può dire, allora, che Saman Abbas fosse ben assimilata e i suoi genitori e parenti no? E per questa ragione (si presume) sia stata uccisa ?
Saman era una giovane donna che dal punto di vista soggettivo poteva sentirsi culturalmente in between, fra l’ambiente culturale della famiglia e l’ambiente sociale più ampio (scuola, mondo del lavoro, tempo libero, consumi, pluralità di fedi religiose), differenziato e mutevole rispetto al primo. Saman aveva appreso a interagire con la diversità, percepiva la distanza culturale rispetto a usi e costumi seguiti dai suoi genitori. Probabilmente condivideva con tante altre sue coetanee europee, ma anche pakistane, egiziane, marocchine, afghane e via dicendo, la convinzione secondo cui tali usi e costumi non c’entrano più di tanto con il vissuto religioso. Donne, con velo o senza, che non capiscono più perché per essere musulmane si debba aderire senza discussione a un modello familistico, riflesso (umano troppo umano) di un sistema sociale di tipo tribale e patriarcale. La libertà di scelta, che in campo religioso si esprime nella modernità con la relativa autonomia del credente, costituisce un valore che appartiene anche all’islam (che non ha una chiesa né sacerdoti né autorità religiose supreme, nemmeno nel caso dello sciismo) soffocato e limitato nel respiro lungo della storia dal principio di obbedienza, che si deve a Dio e ai suoi profeti, ma che poi si è tradotto in assoluta subordinazione al Principe, il leader politico supremo di turno [9]. In società aperte e democratiche tale valore si libera con più facilità dai tanti vincoli che storicamente lo hanno compresso, relegandolo nel silenzio nella coscienza di chi crede; ma tale processo di liberazione è già in atto, si vede in trasparenza nelle forme del conflitto (religioso, fra generi, generazionale, politico) che ho sinteticamente ricordato poco sopra.
Dialoghi Mediterranei, n. 52, novembre 2021
Note
[1] A. Ciccozzi, Diversità che non arricchiscono: la questione dell’estraneità ostile nei reati culturalmente motivati, “Dialoghi Mediterranei”, 2021, n. 51.
[2] O. Pamuk, Neve, Torino, Einaudi, 2004 (ed. orig. turca 2002)
[3] J. Baubérot, Histoire de la laïcité en France, Paris, PUF, 2017 e ID., La Commission Stasi vue par l’un de ses membres, in « French Politics, Cultures and Society », 2004, 22/3: 135-141.
[4] Per parafrasare il noto studio sul sistema della caste indiane di L. Dumont, Homo Hierarchicus, Paris, Gallimard, 1966 (trad. it. da Adelphi 1991).
[5] Si veda Y. Courbage, E. Todd, L’incontro delle civiltà, Milano, Marco Tropea Editore, 2009.
[6] Syracuse, Syracuse University Press, 1987 (uscito postumo, a cura di uno dei suoi allievi riparato negli USA)
[7] Riprendo una formula su cui mi sono soffermato più ampiamente in Elmetti e turbanti, “Il Mulino”, 2016, 2: 49-62.
[8] Anche se sino a oggi si sono registrati ufficialmente più di mille duecento casi di delitti d’onore, secondo la commissione diritti umani pakistana. Ma è presto per fare un bilancio critico più puntuale.
[9] A. Laroui, Islam e modernità, Genova, Marietti, 1987, in particolare l’acuto saggio in cui l’autore confronta il pensiero di Machiavelli con quello di Ibn Khaldun.
_____________________________________________________________
Enzo Pace, è stato professore ordinario di sociologia e sociologia delle religioni all’Università di Padova. Directeur d’études invité all’EHESS (Parigi), è stato Presidente dell’International Society for the Sociology of Religion (ISSR). Ha istituito e diretto il Master sugli studi sull’islam europeo e ha tenuto il corso Islam and Human Rights all’European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation. Ha tenuto corsi nell’ambito del programma Erasmus Teaching Staff Mobility presso le Università di Eskishehir (Turchia) (2010 e 2012), Porto (2009), Complutense di Madrid (2008), Jagiellonia di Cracovia.(2007). Collabora con le riviste Archives de Sciences Sociales des Religions, Social Compass, Socijalna Ekologija, Horizontes Antropologicos, Religiologiques e Religioni & Società. Co-editor della Annual review of the Socioklogy of Religion, edito dalla Brill, Leiden-Boston, è autore di numerosi studi. Tra le recenti pubblicazioni si segnalano: Cristianesimo extra-large (EDB, 2018) e Introduzione alla sociologia delle religioni (Carocci, 2021, nuova edizione).
______________________________________________________________








