Una favola tra educazione alla legalità e educazione linguistica
Posted By Comitato di Redazione On 1 maggio 2020 @ 01:49 In Cultura,Letture | No Comments
I libri valgono e restano per quello che vi è scritto ma anche per quello che la lettura illumina, restituisce e presentifica. Nel tempo del coronavirus i libri sembrano assumere una luce particolare Così è per il libro di Maria Concetta Armetta, Armalilàndia. Cu nasci scìmia, po mòriri omu? Chi nasce scimmia, può morire uomo? (Pietro Vittorietti Edizioni, Palermo 2018), che – come si legge nella Prefazione – «offre agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado un […] contesto narrativo che consente di riflettere sugli atteggiamenti mafiosi nella nostra società e di attivare in classe percorsi di Educazione alla Legalità». In un mixing di italiano e dialetto siciliano, il libro racconta la storia dello zoo di Palermo che improvvisamente, a causa di una malattia contagiosa, diventa microcosmo della cultura e della prassi mafiosa. C’è un capomafia, Chiddu, che, spalleggiato da tre scimmie, pretende che tutti gli altri animali gli paghino il pizzo per potere vivere tranquilli nelle loro gabbie. La cultura mafiosa che impera nello zoo di Armalilàndia presenta tutti i corollari di una società che nega la legalità: intimidazioni, prestiti a usura, ritorsioni, estorsioni, soprusi. La vita illegale dello zoo è talmente deleteria per il quartiere su cui insiste e per il personale che vi lavora, al punto che il sindaco, con propria delibera, sancirà che lo zoo dovrà essere “chiuso per mafia”. Sarà riaperto solo dopo un lungo processo di sanificazione e dopo un arresto della curva dei contagi che comincerà a scendere non tanto grazie all’invenzione di un vaccino o di un farmaco, ma grazie a un nuovo contagio di un nuovo virus, quello della legalità. Questa seconda infezione determinerà una mutazione genetica tra gli animali dello zoo i quali assumeranno finalmente consapevolezza che la violenza non è mai una soluzione, che chi semina odio raccoglie odio, che chi nasce scimmia può morire uomo, che la mafia teme la scuola più della giustizia (Caponnetto), che la mafia è un fenomeno umano con un principio, una sua evoluzione e una sua fine (Falcone). Riaperto lo zoo, dopo la fine dell’epidemia, la sua vita tornerà a scorrere normalmente e i bambini vi potranno tornare con le loro famiglie per trascorrere giornate liete e serene all’insegna dell’armonia. Una bella storia che, ai tempi del Coronavirus, si rilegge sotto una nuova luce, mentre la lettura attiva e riattiva mille nuove suggestioni.
Il libro di Maria Concetta Armetta, insegnante elementare palermitana “di frontiera”, è molto più di una favola a lieto fine. Nel suo lavoro, l’educazione alla legalità si coniuga saldamente con l’educazione linguistica. Così, mentre a ragazzi e insegnanti è offerto uno strumento per affrontare in classe la questione della mafia, allo stesso tempo viene fornito un preziosissimo quadro narrativo e linguistico all’interno del quale compiere un percorso di scoperta, conoscenza e riflessione simultanee sulla legalità e sulla lingua. Anzi proprio la lingua sembra essere la vera protagonista della storia.
Il punto di partenza è semplice, ma non banale o scontato: se la mafia è, per certi versi, un “tratto antropologico”, la caratterizzazione di certi tipi umani passa anzitutto per la lingua; non è possibile, allora, inventarsi un racconto sulla mafia senza mettere in bocca ai personaggi espressioni, parole, verbalizzazioni di un “codice” che linguisticamente si esprime in dialetto. Messa in questi termini, il dialetto – che in tal modo assume un valore mimetico – non ne esce però bene: utilizzato come lingua dei mafiosi, sembrerebbe riproporre lo stereotipo-pregiudizio linguistico che vuole che a Palermo il dialetto sia la lingua della delinquenza e l’italiano quella delle istituzioni (cfr. D’Agostino 2006).
Ma l’interesse linguistico del lavoro di Armetta risiede effettivamente altrove, specialmente se si considerano i seguenti tre aspetti:
1) nel racconto, a usare forme dialettali non sono soltanto i mafiosi ma anche quanti ne subiscono la pressione e l’oppressione;
2) se è vero che nel libro il dialetto assolve a una funzione mimetica (e riguarda tutti i personaggi), non va dimenticato che ne assume un’altra perfino più rilevante: quella espressiva;
3) infarcendo di espressioni, parole e modi di dire dialettali un libro di narrativa pensato come strumento di percorsi educativi per la scuola, non solo si potenziano gli aspetti pedagogici connessi alla riflessione linguistica (che nella scuola deve sempre essere trasversale – e quindi può intrecciarsi anche con temi come la legalità), ma, al tempo stesso, si attua in maniera intelligente e originale la valorizzazione e l’insegnamento del patrimonio regionale nelle scuole, secondo il dettato e lo spirito della Legge 9/2011, che non è certo quello di istituire a scuola l’ora di dialetto o l’ora dell’insegnamento grammaticale del dialetto.
 Quanto al primo aspetto, i protagonisti di Armalilàndia sono armali «dai tratti tipicamente siciliani» (così si legge nella Prefazione e nella quarta di copertina). Questa loro sicilianità è espressa, oltre che con la messa in rilievo di certe specifiche azioni e certi tic, con la loro stessa lingua costituita (anche) da un insieme ricchissimo di elementi lessicali, fraseologici, paremiologici e onomastici tratti dalla cultura dialettale (la maggior parte dei quali opportunamente evidenziati graficamente e glossati nel testo tramite note). Ma non si tratta, in effetti, dell’espressione linguistica di personaggi «dai tratti tipicamente siciliani»; più esattamente si tratta di “traduzione” in siciliano o “in salsa siciliana” di tipi e caratteri umani universali. Così, le tre scimmiette – quelle che nell’immaginario comune tengono rispettivamente le mani sulla bocca, sugli occhi e sugli orecchi, a simboleggiare quanti non vogliono, ottusamente, accorgersi della realtà per leggerla, comprenderla e affrontarla – nello zoo di Armalilàndia – dove sono il braccio operativo di Chiddu, il capomafia della cosca dei Supirchiusi – diventano rispettivamente Parrapicca, Nentivitti e U Surdu (riproponendo, peraltro, implicitamente il tricolon palermitano nenti sàcciu, nenti vitti e si c’era nun ntisi) a predicare simbolicamente l’omertà, carburante, se non motore, di ogni atteggiamento e prassi mafiosi. Le due giraffe – che, al pari degli struzzi che nascondono la testa sotto la sabbia, stanno «tutto il giorno con le teste in giù a fissare il terreno» (loro, che, con il collo così lungo, potrebbero aprire lo sguardo a orizzonti sterminati!) –, sono antroponimicamente Lagnusìa e Mi Siddìa affidando ancora una volta ai loro nomi parlanti l’essenza del loro modo di concepire e vivere la vita. L’elefante che, per la sua stessa stazza, è “un uomo” eternamente spossato che si trascina «lentamente da una parte all’altra» senza riuscire a prendere con la proboscide «le noccioline dai bambini visitatori che, poverini, restavano delusi», è onomasticamente/proverbialmente “l’elefante Passapitittu”, portatore (e destinatario) di un nome volto a predicare i suoi caratteri di ‘persona insulsa e antipatica’ per usare la “definizione” che del composto dialettale si trova nel Vocabolario Siciliano di Piccitto-Tropea-Trovato. La leoncina, che all’interno dello zoo guiderà il processo di riscatto dal giogo mafioso, porta il nome di Amunì, a ribadire il fatto che, se si vuole cambiare la realtà, bisogna mettersi in gioco e compiere, per tappe, un lungo e faticoso percorso di cambiamento. Ancora con riferimento ai processi onomaturgici che presiedono alla designazione e alla connotazione dei personaggi di Armalilàndia, l’autrice non trascura neanche di far entrare in gioco nomi (che sono poi soprannomi) in grado di rivelare nella loro stessa sostanza semantica il relativo movente, evidenziando che molto spesso i soprannomi possono essere di natura idiomatica, essendo cioè affibbiati a un membro della comunità in ragione di un suo particolare tic o vezzo linguistico. Così la cassiera dello zoo è la Signorina Beddamatri perché «da qualche tempo, quando si avvicinava alle gabbie degli armali, esclamava agitando le mani verso l’alto: – Beddamatri, chi successi?». Onomastica e metaonomastica dialettale si fondono, dunque, a dare senso e significato profondo, e linguisticamente ben congegnato, alla caratterizzazione dei personaggi.
Quanto al primo aspetto, i protagonisti di Armalilàndia sono armali «dai tratti tipicamente siciliani» (così si legge nella Prefazione e nella quarta di copertina). Questa loro sicilianità è espressa, oltre che con la messa in rilievo di certe specifiche azioni e certi tic, con la loro stessa lingua costituita (anche) da un insieme ricchissimo di elementi lessicali, fraseologici, paremiologici e onomastici tratti dalla cultura dialettale (la maggior parte dei quali opportunamente evidenziati graficamente e glossati nel testo tramite note). Ma non si tratta, in effetti, dell’espressione linguistica di personaggi «dai tratti tipicamente siciliani»; più esattamente si tratta di “traduzione” in siciliano o “in salsa siciliana” di tipi e caratteri umani universali. Così, le tre scimmiette – quelle che nell’immaginario comune tengono rispettivamente le mani sulla bocca, sugli occhi e sugli orecchi, a simboleggiare quanti non vogliono, ottusamente, accorgersi della realtà per leggerla, comprenderla e affrontarla – nello zoo di Armalilàndia – dove sono il braccio operativo di Chiddu, il capomafia della cosca dei Supirchiusi – diventano rispettivamente Parrapicca, Nentivitti e U Surdu (riproponendo, peraltro, implicitamente il tricolon palermitano nenti sàcciu, nenti vitti e si c’era nun ntisi) a predicare simbolicamente l’omertà, carburante, se non motore, di ogni atteggiamento e prassi mafiosi. Le due giraffe – che, al pari degli struzzi che nascondono la testa sotto la sabbia, stanno «tutto il giorno con le teste in giù a fissare il terreno» (loro, che, con il collo così lungo, potrebbero aprire lo sguardo a orizzonti sterminati!) –, sono antroponimicamente Lagnusìa e Mi Siddìa affidando ancora una volta ai loro nomi parlanti l’essenza del loro modo di concepire e vivere la vita. L’elefante che, per la sua stessa stazza, è “un uomo” eternamente spossato che si trascina «lentamente da una parte all’altra» senza riuscire a prendere con la proboscide «le noccioline dai bambini visitatori che, poverini, restavano delusi», è onomasticamente/proverbialmente “l’elefante Passapitittu”, portatore (e destinatario) di un nome volto a predicare i suoi caratteri di ‘persona insulsa e antipatica’ per usare la “definizione” che del composto dialettale si trova nel Vocabolario Siciliano di Piccitto-Tropea-Trovato. La leoncina, che all’interno dello zoo guiderà il processo di riscatto dal giogo mafioso, porta il nome di Amunì, a ribadire il fatto che, se si vuole cambiare la realtà, bisogna mettersi in gioco e compiere, per tappe, un lungo e faticoso percorso di cambiamento. Ancora con riferimento ai processi onomaturgici che presiedono alla designazione e alla connotazione dei personaggi di Armalilàndia, l’autrice non trascura neanche di far entrare in gioco nomi (che sono poi soprannomi) in grado di rivelare nella loro stessa sostanza semantica il relativo movente, evidenziando che molto spesso i soprannomi possono essere di natura idiomatica, essendo cioè affibbiati a un membro della comunità in ragione di un suo particolare tic o vezzo linguistico. Così la cassiera dello zoo è la Signorina Beddamatri perché «da qualche tempo, quando si avvicinava alle gabbie degli armali, esclamava agitando le mani verso l’alto: – Beddamatri, chi successi?». Onomastica e metaonomastica dialettale si fondono, dunque, a dare senso e significato profondo, e linguisticamente ben congegnato, alla caratterizzazione dei personaggi.
Si osservava più sopra che nel libro di Armetta il dialetto serve a sicilianizzare linguisticamente tipi e caratteri umani che sono in realtà universali: una sorta di traduzione/ricollocazione palermitana attraverso l’uso del codice locale. Ma, a ben pensarci, il dialetto di Armalilàndia non è né siciliano né palermitano, giacché non attinge semplicemente alla tradizione linguistica della Sicilia o del capoluogo per riprodurla in maniera più o meno fedele. Al contrario, partendo dal ricco e in parte ancora vitale materiale lessicale e fraseologico del dialetto, l’autrice lo riproduce e lo riusa consapevolmente fino a piegarlo, talvolta, a rielaborazioni del tutto congrue con gli obiettivi didattici del volume. Così il proverbio siciliano cu nasci tunnu un po mòriri quatratu (già da altri prestato al gioco linguistico e reinventato come cu nasci tunnu un po mòriri simmenthal) viene qui rielaborato come sottotitolo del libro nella domanda (certamente retorica) Cu nasci scìmia, po moriri omu? Né siciliano, né palermitano, dunque, ma originalissimo “armalilandiese”, riconducibile esclusivamente al microcosmo/macrocosmo dello zoo, che si fa lingua propria ed esclusiva del racconto pur restando intrinsecamente, fedelmente e lealmente palermitana.
In un tempo in cui si usa il dialetto un po’ dappertutto, nella letteratura come nei social, nelle insegne dei locali come nella marchionimia (un po’ dappertutto, ma sempre meno nel parlato ordinario), cresce tra i siciliani la convinzione che in dialetto si possa parlare (e scrivere) di tutto, senza che si colga in ciò una grande contraddizione: che in dialetto si può parlare e scrivere di tutto a patto che lo si metta in rapporto 1/1 con l’italiano. Questa (presunta) “interscambiabilità”, che ad alcuni sembra un punto di forza, è in realtà un punto di debolezza: il dialetto, già in condizione di eteronomia rispetto all’italiano, finisce, infatti, per dipendere (ancora di più) dalla lingua nazionale – il che non è uno scandalo, ma è un paradosso se si considera che chi vuole promuoverlo per farlo parlare di tutto, lo fa per affrancarlo dall’“oppressione” della lingua nazionale.
Quanti ritengono che il dialetto debba potere parlare di tutto, partono da una considerazione: se il dialetto non ha parole (dovendo trattare di temi dei quali esso non è abituato a parlare – per es. scienza, medicina, filosofia, economia, diritto), basta assumere di peso una dose massiccia di lessico da una lingua che lo possiede (in genere l’italiano) per “sicilianizzarlo” colorandolo di vernice dialettale. Per quanto ciò possa apparire “normale” – il prestito e il calco linguistico sono il termometro della vitalità di una lingua –, non pochi sono i dubbi e le contraddizioni che emergono. Per esempio, se una tale operazione di “pianificazione linguistica” viene compiuta da italofoni L1 – che del dialetto sono “semiparlanti” –, accade che si perviene sì alla produzione di testi in siciliano o con parole siciliane, ma con una matrice linguistica sostanzialmente e irrimediabilmente italiana. Si produrranno, cioè, testi la cui struttura sintattica e testuale è costitutivamente italiana e solo sicilin(izzat)a nel lessico; testi la cui struttura lessicale è costitutivamente italiana e solo sicilia(nizzat)a nella fonetica (cfr. Paternostro e Sottile in stampa, a proposito della traduzione in siciliano del Corriere dell’Unesco ad opera di una Associazione significativamente chiamata Cademia siciliana). In tal modo, il lessico di questi testi finisce per apparire del tutto “innaturale”.
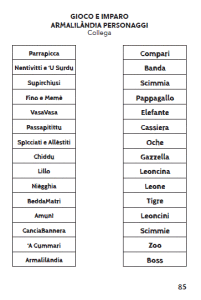 Molto recentemente, per esempio, abbiamo visto circolare sui social un manifesto in siciliano realizzato nell’ambito di una campagna promossa dalla Regione Lombardia tesa a invitare gli italiani a restare a casa, dicendolo in tutte le lingue regionali d’Italia. “Lassa u viru davanzi a porta” è quanto si legge nel manifesto riferito alla Sicilia e al dialetto siciliano. Siccome virus è parola che in siciliano non esiste, è stata presa quella dell’italiano, sicilianizzandola “per ipotesi”, senza un reale ancoraggio, cioè, alla effettiva realtà linguistica. Quest’ultima quantomeno pretenderebbe una considerazione: quando una nuova parola entra come prestito nel sistema linguistico che la riceve, essa ha bisogno di diverso tempo per adattarsi alla fonetica e alla morfologia di quel sistema (se la parola virus è entrata nel siciliano, è entrata proprio nella forma virus: proporre viru significa “ipotizzare” come quella parola verrebbe adattata in siciliano o come dovrebbe “suonare” in siciliano). Poiché l’ingegneria linguistica assume più meno esplicitamente il principio operativo di introdurre nuove parole da un’altra lingua (in genere l’italiano, lingua tetto), adattandole alla morfofonologia della lingua che accoglie (in genere un dialetto), si finisce per trascurare che la reale prassi linguistica dei parlanti segue in molti casi ben altre vie e ben altre soluzioni (spesso imprevedibili e apparentemente imperscrutabili). Per esempio, nel caso del siciliano, la parola per accendino (oggetto inventato nella prima metà dell’800) non corrisponde né ad accendinu né ad accenninu (che sembrerebbero le uniche forme possibili in ragione del loro grado di adattamento alle leggi fonetiche del siciliano): i parlanti siciliani hanno optato per il termine machinetta, risolvendo via metafora il problema di disporre di un termine nuovo per un oggetto nuovo. D’altra parte, quando dall’uso (e dalla memoria) è cominciato a scomparire l’arcaismo naca, è intervenuto a sostituirlo l’italianismo culla senza che i parlanti si siano accaniti a farlo diventare “sicilianissimamente” cudda (eppure, nella prospettiva dell’ingegneria linguistica, l’unica forma “realmente – ma solo ipoteticamente e puristicamente – siciliana” dovrebbe essere cudda in quanto adeguatamente adattata al siciliano – che, d’altro canto, è una forma che non esiste nella reale prassi linguistica dei parlanti siciliani).
Molto recentemente, per esempio, abbiamo visto circolare sui social un manifesto in siciliano realizzato nell’ambito di una campagna promossa dalla Regione Lombardia tesa a invitare gli italiani a restare a casa, dicendolo in tutte le lingue regionali d’Italia. “Lassa u viru davanzi a porta” è quanto si legge nel manifesto riferito alla Sicilia e al dialetto siciliano. Siccome virus è parola che in siciliano non esiste, è stata presa quella dell’italiano, sicilianizzandola “per ipotesi”, senza un reale ancoraggio, cioè, alla effettiva realtà linguistica. Quest’ultima quantomeno pretenderebbe una considerazione: quando una nuova parola entra come prestito nel sistema linguistico che la riceve, essa ha bisogno di diverso tempo per adattarsi alla fonetica e alla morfologia di quel sistema (se la parola virus è entrata nel siciliano, è entrata proprio nella forma virus: proporre viru significa “ipotizzare” come quella parola verrebbe adattata in siciliano o come dovrebbe “suonare” in siciliano). Poiché l’ingegneria linguistica assume più meno esplicitamente il principio operativo di introdurre nuove parole da un’altra lingua (in genere l’italiano, lingua tetto), adattandole alla morfofonologia della lingua che accoglie (in genere un dialetto), si finisce per trascurare che la reale prassi linguistica dei parlanti segue in molti casi ben altre vie e ben altre soluzioni (spesso imprevedibili e apparentemente imperscrutabili). Per esempio, nel caso del siciliano, la parola per accendino (oggetto inventato nella prima metà dell’800) non corrisponde né ad accendinu né ad accenninu (che sembrerebbero le uniche forme possibili in ragione del loro grado di adattamento alle leggi fonetiche del siciliano): i parlanti siciliani hanno optato per il termine machinetta, risolvendo via metafora il problema di disporre di un termine nuovo per un oggetto nuovo. D’altra parte, quando dall’uso (e dalla memoria) è cominciato a scomparire l’arcaismo naca, è intervenuto a sostituirlo l’italianismo culla senza che i parlanti si siano accaniti a farlo diventare “sicilianissimamente” cudda (eppure, nella prospettiva dell’ingegneria linguistica, l’unica forma “realmente – ma solo ipoteticamente e puristicamente – siciliana” dovrebbe essere cudda in quanto adeguatamente adattata al siciliano – che, d’altro canto, è una forma che non esiste nella reale prassi linguistica dei parlanti siciliani).
Alla domanda se la lingua italiana stesse bene, Tullio De Mauro era solito rispondere che la lingua sta benissimo, mentre ad accusare qualche problema di salute sono i suoi parlanti. Tale suggestione, mutatis mutandi, può essere riproposta anche nel nostro caso: certamente, adoperarsi per dare al siciliano la possibilità (anche solo in potenza) di parlare e scrivere di tutto può essere un modo per garantire i diritti dei suoi parlanti. Ma, in ogni caso, come i parlanti hanno i loro diritti (che le “Accademie”, disseminate in tutte le regioni italiane, dichiarano di volere difendere ad ogni costo), anche la lingua ha i propri; uno di questi potrebbe essere quello di non subìre un processo forzato di ingegnerizzazione che, seppur legittimo (in fin dei conti, l’ingegneria linguistica è una branca della sociolinguistica), impegna a riflettere se tali operazioni non conducano, alla fine, a rivitalizzazioni artificiali, senza considerare il problema della loro reale utilità.
Non è facile stabilire se con l’idea che in siciliano sia possibile (e necessario) parlare e scrivere di tutto, c’entri la lingua alla quale ci ha abituati la scrittura dell’ultimo Camilleri. Conta, comunque, che il dialetto che si trova in Armalilàndia non è né camilleriano (non è, cioè, “inventato”, anche solo in parte), né presenta una matrice italiana (non è, cioè, traduzione e adattamento in siciliano di parole e costrutti italiani, quale risultato di una dialettofonia di ritorno). La matrice linguistica che agisce nell’autrice di Armalilàndia resta compiutamente (e felicemente) dialettale; lo attestano, per esempio, le costruzioni sintattiche con il verbo posto a fine frase. E proprio perché nell’uso del dialetto dell’autrice agisce (fortunatamente) tale matrice, essa finisce per risalire anche nei frammenti di italiano regionale nei quali ci si imbatte leggendo il libro: «niente aveva detto», «se l’era vista pietre pietre», «mio figlio nella munnizza è stato seppellito», «rispose Fino, schiacciando l’occhio». E, ovviamente, anche nei “pezzi” di siciliano: «Talè, ora puru ‘u cabarettista spiritusu fai?», «a jurnata fici!» (al netto della dimensione diamesica e diafasica). Per questa ragione il dialetto di cui è infarcito il racconto di Armetta, nella sua reale autenticità, si presta più che adeguatamente a essere strumento per un percorso serio e consapevole di educazione linguistica nelle scuole.
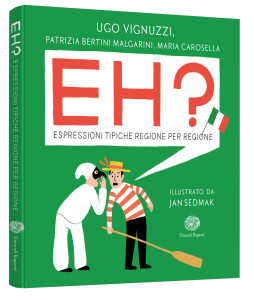 Quanto al secondo aspetto, abbiamo notato che il valore del dialetto utilizzato, spesso in condizione di code switching, nel libro di Armetta assume anche – e ovviamente – un valore espressivo. Non potrebbe essere diversamente. Tale è il valore principale che esso assume oggi tra bambini e ragazzini, prevalentemente italofoni. Riproporlo con la stessa funzione diventa, allora, una sorta di necessario “avvicinamento attanziale” da parte dell’autrice ai suoi potenziali giovani destinatari. Ma c’è di più: è stato recentemente pubblicato (2019) da tre validi linguisti romani (Vignuzzi, Bertini Malgarini, Carosella) un libro per “Einaudi Ragazzi” dal titolo Eh? Espressioni tipiche regione per regione. Si tratta di una raccolta di modi di dire tratti dalle varie tradizioni regionali e locali della nostra penisola con l’intento di guidare i ragazzi in un viaggio tra le espressioni dialettali e nei loro significati. Un viaggio che «ci permette di conoscerci meglio e di sentirci in qualche modo tutti più italiani» (così si legge nella quarta di copertina): si va da Salut! della Val D’Aosta a Bedda matri! della Sicilia. Di ciascuna espressione viene spiegato quando si usa, quando è nata, in che senso e in che misura è legata alle consuetudini della vita e ai caratteri antropologici delle diverse realtà regionali dell’“Italia delle Italie”. Questo inventario di un pezzo del patrimonio fraseologico e paremiologico delle regioni italiane non ha altro scopo – credo – se non quello di consegnare alle nuove generazioni uno prezioso scrigno di memoria al quale attingere per assumere consapevolezza della ricchezza culturale dell’universo linguistico italiano. Si potrebbe affermare che il libro di Armetta compie sostanzialmente la stessa operazione su scala regionale e palermitana: Talè cu c’è, Chista è a zita, Cchiù scuru i menzannotti un po’ fari, ci su cosi i rùmpiri, testa ca un parra si chiama cucuzza, e comu veni si cunta, sono unità farseologiche, tutte opportunamente collocate e contestualizzate all’interno del racconto, che permettono a bambini e ragazzi delle scuole quantomeno di riflettere, assieme agli insegnanti, sulle potenzialità espressive e sul valore identitario di uno straordinario patrimonio di lingua, storia e cultura di cui sono portatori i codici locali, le lingue regionali.
Quanto al secondo aspetto, abbiamo notato che il valore del dialetto utilizzato, spesso in condizione di code switching, nel libro di Armetta assume anche – e ovviamente – un valore espressivo. Non potrebbe essere diversamente. Tale è il valore principale che esso assume oggi tra bambini e ragazzini, prevalentemente italofoni. Riproporlo con la stessa funzione diventa, allora, una sorta di necessario “avvicinamento attanziale” da parte dell’autrice ai suoi potenziali giovani destinatari. Ma c’è di più: è stato recentemente pubblicato (2019) da tre validi linguisti romani (Vignuzzi, Bertini Malgarini, Carosella) un libro per “Einaudi Ragazzi” dal titolo Eh? Espressioni tipiche regione per regione. Si tratta di una raccolta di modi di dire tratti dalle varie tradizioni regionali e locali della nostra penisola con l’intento di guidare i ragazzi in un viaggio tra le espressioni dialettali e nei loro significati. Un viaggio che «ci permette di conoscerci meglio e di sentirci in qualche modo tutti più italiani» (così si legge nella quarta di copertina): si va da Salut! della Val D’Aosta a Bedda matri! della Sicilia. Di ciascuna espressione viene spiegato quando si usa, quando è nata, in che senso e in che misura è legata alle consuetudini della vita e ai caratteri antropologici delle diverse realtà regionali dell’“Italia delle Italie”. Questo inventario di un pezzo del patrimonio fraseologico e paremiologico delle regioni italiane non ha altro scopo – credo – se non quello di consegnare alle nuove generazioni uno prezioso scrigno di memoria al quale attingere per assumere consapevolezza della ricchezza culturale dell’universo linguistico italiano. Si potrebbe affermare che il libro di Armetta compie sostanzialmente la stessa operazione su scala regionale e palermitana: Talè cu c’è, Chista è a zita, Cchiù scuru i menzannotti un po’ fari, ci su cosi i rùmpiri, testa ca un parra si chiama cucuzza, e comu veni si cunta, sono unità farseologiche, tutte opportunamente collocate e contestualizzate all’interno del racconto, che permettono a bambini e ragazzi delle scuole quantomeno di riflettere, assieme agli insegnanti, sulle potenzialità espressive e sul valore identitario di uno straordinario patrimonio di lingua, storia e cultura di cui sono portatori i codici locali, le lingue regionali.
Quanto, infine, al terzo aspetto, si è detto che Armalilàndia è anzitutto un percorso didattico di educazione alla legalità all’interno del quale il dialetto entra per dare verisimiglianza antropologica e forza espressiva alla storia da cui partire per riflettere sulla mafia e sugli atteggiamenti mafiosi. Ora, nel libro le frasi e le espressioni dialettali sono idealmente poste in parallelo con molte altre frasi di cui è disseminato il racconto e dovute agli eroi dell’antimafia (in molti casi vittime della mafia). Esse sono ovviamente scritte in italiano perché così sono state pronunciate da chi le ha create e lasciate in eredità. Ma dentro un racconto disseminato di dialettalità, le frasi di Falcone, Borsellino, Padre Puglisi, sembrano risuonare, suggestivamente, con un forte accento palermitano dando al lettore, come probabilmente anche al bambino, la sensazione che non esiste una Palermo della mafia come altra cosa da una Palermo dell’antimafia, che non esiste una Palermo che parla un codice e una Palermo che ne parla un altro: esiste un’unica Palermo, di una sola palermitanità, dentro la quale si può scegliere e decidere se stare da una parte o dall’altra. La gente a Palermo non è diversa per cultura e lingua; lo è in base alle scelte che compie, o in base alla sua possibilità di decidere da che parte stare. Forse per questo, alla fine della storia, nello zoo di Armalilàndia si giunge alla pacificazione dopo aver scoperto che il capo mafia condivide con Amunì, l’eroina dell’antimafia, lo stesso dramma: quella di un congiunto ucciso. Non importa che da un lato il congiunto è un delinquente e dall’altro un padre fatto uccidere dallo stesso capo mafia per non essere riuscito a saldare un debito contratto per un prestito a usura; conta che il mafioso Chiddu e la giovane Amunì possono solidarizzare e prendersi per mano in nome dello stesso sordo dolore; conta che essendo figli dello stesso destino a nulla serve seminare odio. Quello che conta, alla fine, è che è possibile – che deve essere possibile – parlare a Palermo tutti la stessa lingua.
Dialoghi Mediterranei, n. 43, maggio 2020
Riferimenti bibliografici
D’Agostino¸ Mari (2006), Sociolinguistica dell’Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino.
Paternostro, Giuseppe e Roberto Sottile (in stampa), «Dalla risorgenza alla restaurazione: il dialetto fra nostalgia, rivendicazioni identitarie e appropriazioni indebite», in Atti del Convegno ILPE IV – La mediazione delle ideologie linguistiche attraverso la stampa: il caso delle lingue romanze, Messina, 23-25 ottobre 2019.
Vocabolario siciliano (1977-2002), a cura di G. Piccitto (vol. I), diretto da G. Tropea (voll. II-IV), a cura di S. C. Trovato (vol. V), Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Catania-Palermo.
______________________________________________________________
Roberto Sottile, insegna Linguistica italiana nel Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Palermo. Con il Gruppo di ricerca dell’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS) ha pubblicato il Vocabolario-atlante della cultura dialettale. Articoli di saggio (CSFLS, Palermo 2009) e il “Lessico della cultura dialettale delle Madonie. 1. L’alimentazione, 2. Voci di saggio” (CSFLS, Palermo 2010-2011). Ha anche dedicato una particolare attenzione al rapporto tra dialetto e letteratura e tra dialetto e mondo giovanile. Recentemente ha pubblicato il libro intitolato Dialetto e canzone. Uno sguardo sulla Sicilia di oggi (Cesati, Firenze 2018).
_______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM
URL to article: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/una-favola-tra-educazione-alla-legalita-e-educazione-linguistica/
Click here to print.




