C’era una frase di Montaigne che affascinava Leonardo Sciascia in modo quasi ossessivo; una frase che si trova nel capitolo XI del III libro degli Essais intitolato Degli Zoppi e che lo scrittore siciliano riprende sia in Porte Aperte che ne La sentenza memorabile: «Dopotutto, è un mettere le proprie congetture a ben alto prezzo, il volere, per esse, far arrostire vivo un uomo». Si tratta della «cosa più scettica, più integralmente scettica – commentava Sciascia – che sia mai stata detta», e per questo ispiratrice del suo scetticismo, considerato il «miglior antidoto per il fanatismo», valvola di sicurezza della ragione e di ogni forma di tolleranza.
L’avversione al fanatismo, oggi protagonista assoluto di un’attualità sempre più disumana (tra gli ultimi di una serie di atroci episodi, la strage di Charlie Hebdo o la decapitazione dei 21 cristiani copti in Egitto), è stato uno dei rovelli intellettuali di Sciascia. Non a caso, una delle sue letture preferite era il racconto I Teologi dello scrittore argentino Jorge Luis Borges, vera e propria “parabola del fanatismo”. È la storia di due fanatici che muoiono della stessa morte, condannato al rogo uno, bruciato da un fulmine l’altro: fatto che ne annulla simbolicamente l’opposizione, mentre l’indifferenza divina suggella beffardamente la loro riconciliazione.
Sciascia si ispira al racconto borgesiano in una delle Cronachette che pubblicò nell’’85: Don Mariano Crescimanno, vicenda del paradossale riavvicinamento di due polarità apparentemente irriducibili alla maniera dell’autore di Finzioni. Nella Sicilia borbonica dell’ultimo ventennio del ‘700, il marchese di Villabianca, personaggio già incontrato nelle pagine de Il Consiglio d’Egitto, sembra rappresentare la perfetta incarnazione del più puro e assoluto fanatismo: compiaciuto nel far monacare le figlie, rassicurato nell’assistere alle esecuzioni di morte, afflitto dal più malinconico patimento nel veder tramontare l’istituzione dell’Inquisizione. All’estremo opposto, troviamo Don Mariano Crescimanno, eretico spacciato per pazzo e rinchiuso nelle carceri inquisitoriali. Come nel caso di quasi tutti gli eretici incontrati nelle pagine dello scrittore racalmutese (primo tra tutti Diego La Matina in Morte dell’inquisitore, altra vittima del fanatismo religioso), la morte coincide con l’estrema solitudine a cui è condannato il personaggio: Crescimanno muore solo, al buio della sua cella, senza assistenza; al suo corpo non viene data neanche degna sepoltura, ma viene bestialmente interrato nel giardino del palazzo.
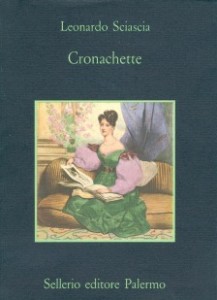 Il marchese di Villabianca e don Mariano Crescimano sembrano dunque appartenere a due categorie morali e storiche in apparenza inconciliabili, ma che si trovano inaspettatamente legate da un oggetto: il breviario dell’eretico che, scampato al rogo ordito dal viceré Caracciolo, viene non solo gelosamente custodito come reliquia dal fanatico, ma anche segnalato ai posteri. Sciascia arriva allora a supporre che – come nel caso dei Teologi di Borges – «nell’oltremondo il virtuoso e savio marchese di Villabianca si riconobbe nel peccatore e folle don Mariano Crescimanno». L’intransigente e l’eretico, l’inquisitore e l’inquisito, il potente e la vittima, trovano una paradossale quanto intima e interiore riconciliazione nel mondo dei morti.
Il marchese di Villabianca e don Mariano Crescimano sembrano dunque appartenere a due categorie morali e storiche in apparenza inconciliabili, ma che si trovano inaspettatamente legate da un oggetto: il breviario dell’eretico che, scampato al rogo ordito dal viceré Caracciolo, viene non solo gelosamente custodito come reliquia dal fanatico, ma anche segnalato ai posteri. Sciascia arriva allora a supporre che – come nel caso dei Teologi di Borges – «nell’oltremondo il virtuoso e savio marchese di Villabianca si riconobbe nel peccatore e folle don Mariano Crescimanno». L’intransigente e l’eretico, l’inquisitore e l’inquisito, il potente e la vittima, trovano una paradossale quanto intima e interiore riconciliazione nel mondo dei morti.
Ma il fanatismo è il tema chiave anche di un’altra “cronachetta”, la penultima, intitolata L’uomo dal passamontagna, dove l’estremismo religioso cede luogo a quello politico. Ambientata a Santiago del Cile nel 1977, durante il regime di Pinochet, si tratta della riscrittura di una storia che allo scrittore siciliano era stata raccontata a Parigi da Armando Uribe, poeta e professore di diritto tenacemente perseguitato dalla repressione dittatoriale. Si tratta della vicenda di un ex socialista divenuto spia al servizio della dittatura nelle vesti aberranti dell’uomo dal passamontagna, di «colui che senza dire una parola, soltanto con un gesto della mano, sceglieva tra i prigionieri ammassati nello stadio nazionale chi mandare alla tortura e chi alla morte» e che poi assumeva invece il ruolo contraddittorio di “pentito”, denunciando le barbarie di quello stesso regime di cui era stato complice. Emerge dunque, come prima cosa, la revocabilità borgesiana delle opposizioni: il perseguitato diventa persecutore, la vittima il carnefice, il traditore si schiera «miseramente» dalla parte dei torturati. Sciascia formula polarità borgesiane, confermando il destino di doppiezza, di diplopia, che è sempre in qualche modo connesso a ogni effigie del terrore. Ma vi è anche l’intento di astrarre l’enigmatica figura di questo propalatore di morte da ogni connessione con la contingenza, elevandolo a esempio universale di un modus operandi fanatico, a «indelebile, ossessiva immagine del terrore», del «terrore della delazione senza volto, del tradimento senza nome», a «fantasma dell’Inquisizione, di ogni inquisizione, dell’eterna e sempre più raffinata inquisizione. E, ancora, ad «atroce allucinazione, atroce simbolo».
 Nel maggio del 1977, non in Cile, ma a Milano, in via De Amicis, venne scattata la foto che diverrà l’immagine-icona degli “anni di piombo”: è una foto che ritrae un altro “uomo dal passamontagna”, un terrorista che spara a braccia unite e gambe piegate in direzione della polizia. Si potrebbe supporre allora che nelle intenzioni di Sciascia vi fosse quella di un avvicinamento, di una sovrapposizione tra le due figure: il traditore cileno, donatore di morte con un solo gesto della mano, e il terrorista dal volto coperto della foto-simbolo degli anni di piombo, entrambe rappresentazioni emblematiche, individualità spersonalizzate, non solo di un periodo, ma anche di un’idea.
Nel maggio del 1977, non in Cile, ma a Milano, in via De Amicis, venne scattata la foto che diverrà l’immagine-icona degli “anni di piombo”: è una foto che ritrae un altro “uomo dal passamontagna”, un terrorista che spara a braccia unite e gambe piegate in direzione della polizia. Si potrebbe supporre allora che nelle intenzioni di Sciascia vi fosse quella di un avvicinamento, di una sovrapposizione tra le due figure: il traditore cileno, donatore di morte con un solo gesto della mano, e il terrorista dal volto coperto della foto-simbolo degli anni di piombo, entrambe rappresentazioni emblematiche, individualità spersonalizzate, non solo di un periodo, ma anche di un’idea.
Tracce di Borges potrebbero essere rinvenute anche nell’Affaire Moro – riscrittura di un’altra vicenda in cui il fanatismo politico fa da protagonista – laddove l’autore tenta di immedesimarsi non solo con il presidente democristiano condannato a morte ma anche con i suoi sequestratori, di capirli «in quella difficile, terribile familiarità quotidiana che inevitabilmente si stabilisce»:
Nello scambiare parole, colloquiali o di accuse e discolpe. Nel consumare insieme i cibi. Nel sonno del prigioniero e nella veglia del carceriere. Nell’occuparsi della salute di quell’uomo condannato a morte. Nel leggere i suoi messaggi e nel rischio corso ogni volta per recapitarli. Tanti piccoli gesti; tante parole che inavvertitamente si dicono, ma che provengono dai più profondi moti dell’animo; un incontrarsi di sguardi nei momenti più disarmati; l’imprevedibile scambio di un sorriso; i silenzi – sono tante le cose, tanti i momenti, che giorno dopo giorno – per più di cinquanta – possono insorgere ad affratellare il carceriere e il carcerato, il boia e la vittima. E al punto che il boia non può più essere boia.
L’immedesimazione tra due polarità morali opposte – carceriere/carcerato, boia/vittima – che rimanda a I Teologi, e anticipa “cronachette” come Don Mariano Crescimanno e L’uomo dal passamontagna, avviene però qui non nella metafisica del regno dei cieli, come nel racconto borgesiano, ma nella dimensione tanto terrena quanto infernale della prigione del popolo, luogo di sentimenti «inavvertitamente» autentici. In quell’«inavvertitamente», che inaugura una serie di scelte lessicali votate a iscrivere il rapporto tra Moro e i brigatisti sotto l’egida di un inatteso sentimentalismo («incontrarsi di sguardi nei momenti più disarmati»; «imprevedibile scambio di un sorriso»), si notano la capacità di umana comprensione ma anche lo scetticismo di Sciascia, contrario a ogni forma di presa di posizione estrema e precostituita.
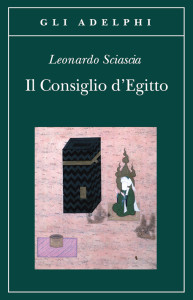 Ma l’intensità della polemica sciasciana contro il fanatismo, di cui espressione più emblematica è la pena di morte, trova il suo compimento letterario più alto nel monologo di Francesco Paolo Di Blasi ne Il Consiglio d’Egitto, quando si appresta a subire l’ultima, atroce tortura. Nel macabro scenario della preparazione del lardo che brucerà i piedi dell’avvocato, già informi per le precedenti ustioni, tanto da parere «sanguinolente e grommose zolle di carne», si dibattono dialetticamente umanità e disumanità, quasi fossero personificate. Ma la disperazione per l’imminente vittoria della brutalità più animalesca trova un ultimo, consolatorio conforto nella speranza che una cosa del genere «non sarebbe più accaduta nel mondo illuminato dalla ragione». Di Blasi ripensa all’infanzia, all’odore della sugna in cucina, odore di vita, d’amore, uguale a quello di morte del lardo che gorgoglia nella “tannura”, e si pone idealmente sullo stesso piano dei suoi torturatori, di quei giudici e sbirri sceneggiatori impietosi dell’allestimento di dolore che lo attende: chissà se anche loro, tornando a casa, svestendo i panni della grigia ufficialità a cui il ruolo li condanna, avrebbero ripensato a ciò che erano quotidianamente obbligati a compiere con un riverbero di ribrezzo, orrore, vergogna.
Ma l’intensità della polemica sciasciana contro il fanatismo, di cui espressione più emblematica è la pena di morte, trova il suo compimento letterario più alto nel monologo di Francesco Paolo Di Blasi ne Il Consiglio d’Egitto, quando si appresta a subire l’ultima, atroce tortura. Nel macabro scenario della preparazione del lardo che brucerà i piedi dell’avvocato, già informi per le precedenti ustioni, tanto da parere «sanguinolente e grommose zolle di carne», si dibattono dialetticamente umanità e disumanità, quasi fossero personificate. Ma la disperazione per l’imminente vittoria della brutalità più animalesca trova un ultimo, consolatorio conforto nella speranza che una cosa del genere «non sarebbe più accaduta nel mondo illuminato dalla ragione». Di Blasi ripensa all’infanzia, all’odore della sugna in cucina, odore di vita, d’amore, uguale a quello di morte del lardo che gorgoglia nella “tannura”, e si pone idealmente sullo stesso piano dei suoi torturatori, di quei giudici e sbirri sceneggiatori impietosi dell’allestimento di dolore che lo attende: chissà se anche loro, tornando a casa, svestendo i panni della grigia ufficialità a cui il ruolo li condanna, avrebbero ripensato a ciò che erano quotidianamente obbligati a compiere con un riverbero di ribrezzo, orrore, vergogna.
Siamo al di qua dell’Illuminismo. L’avvocato Di Blasi poteva ancora sperare che l’arrivo di una nuova era avrebbe scacciato via i detriti irrazionali di una società arretrata. Ma:
La disperazione avrebbe accompagnato le sue ultime ore di vita se soltanto avesse avuto il presentimento che in quell’avvenire che vedeva luminoso popoli interi si sarebbero votati a torturarne altri; che uomini pieni di cultura e di musica, esemplari dell’amore familiare e rispettosi degli animali, avrebbero distrutto milioni di altri esseri umani: con implacabile metodo, con efferata scienza della tortura; e che persino i più diretti eredi della ragione avrebbero riportato la questione nel mondo: e non più come elemento del diritto, quale almeno era nel momento in cui lui la subiva, ma addirittura come elemento dell’esistenza.
Il progresso non salva da eventuali ricadute di bestialità, ricadute ancora più violente. In un certo senso, si tratta anche del superamento dell’illuminismo caro a tanti critici sciasciani: ogni fiducia è persa, se neanche la ragione serve da deterrente. Se nella Prefazione alle Parrocchie di Regalpetra (1956), Sciascia affermava: «Credo nella ragione umana, e nella libertà e nella giustizia che dalla ragione scaturiscono», progressivamente questa fede viene meno. Siamo più vicini alla sfiducia nell’evoluzionismo storico che era stato di Pirandello e De Roberto e a una concezione circolare della storia ben lontana dal progressismo marxista: i mali si ripresentano sotto altre forme, ma immutabili nella sostanza d’orrore.
Il nostro è un mondo in cui non si può essere più neanche martiri, perché le battaglie individuali, le lotte e le sconfitte, si rivelano battaglie donchisciottesche, cause perse in partenza. La morte dell’avvocato Di Blasi – inscritta nella tonalità cupa di una sovrabbondanza di nero («il palco era addobbato di nero, c’erano pronte le nere candele»…«il servo in livrea, la livrea da lutto») – potrebbe essere letta come exemplum: è morto perché voleva cambiare il mondo. Ma l’utopia è bandita in nome di uno scetticismo privo di speranza. E il suo è un vano lottare: «non ha niente da confessare, l’avvenire non è garante della sua causa poiché il nostro sarà secolo della tortura non meno del suo». Il boia-capraio che, nelle ultime righe del libro, prega il suo Dio, «il Dio delle capre e del malocchio», per avere «mano ferma a recidere la corda», sembra rappresentare l’estremo suggello della brutalità di una pratica che non dovrebbe far parte del mondo degli uomini.
Dialoghi Mediterranei, n.12, marzo 2015
_______________________________________________________________
Marta Gentilucci, giovane laureata in Italianistica presso l’Università degli Studi di Bologna, ha collaborato con la Cineteca di Bologna e si occupa di giornalismo ed editoria. Tra i suoi interessi di ricerca, lo studio della letteratura delle migrazioni. Ha insegnato nel laboratorio di video-giornalismo presso il Liceo classico F. Scaduto di Bagheria. Ha partecipato a stage e seminari su identità di genere, letteratura post-coloniale e scritture migranti.
_______________________________________________________________









Giusto un complimento per l’articolo che esalta uno dei messaggi più sentiti ed universali del grande scrittore di Racalmuto.