Il richiamo della “remoteness”. Ambivalenze e potenzialità dell’estrema lontananza nelle aree interne e montane
Posted By Comitato di Redazione On 1 marzo 2023 @ 02:59 In Cultura,Società | No Comments
il centro in periferia
di Andrea Membretti [*]
Remotezza, remoteness, estrema lontananza
Nella lingua italiana è abbastanza raro trovare il sostantivo remotezza, ormai desueto: si incontra invece più facilmente l’aggettivo remoto, di solito come specificazione di luoghi, di territori, di regioni del globo (e, da qualche tempo, come elemento della comunicazione digitale, con riferimento alle connessioni da remoto). Nella lingua inglese, invece, il sostantivo remoteness compare tutt’oggi abbastanza diffusamente, perlomeno in discipline come la geografia, l’antropologia o la sociologia del territorio; l’accezione spazio-territoriale è comunque sempre predominante, anche rispetto all’aggettivo derivato, che si accompagna di frequente ai luoghi, connotandoli appunto come remote places.
Se consideriamo l’etimo dello stesso termine remoteness – quella remotezza che in italiano potremmo anche chiamare estrema lontananza, sebbene perdendo parte della semantica di questo vocabolo – vediamo che la sua origine si ritrova nel verbo latino removeo: questo significa “rimuovere”, “togliere”, “allontanare” qualcosa (o qualcuno) da qualcos’altro (o qualcun altro). I luoghi remoti – seguendo l’etimologia del termine ma anche il senso comune – sono dunque quelli percepiti, almeno da chi non li abita e spesso non li ha mai visti, come rimossi da quella vita quotidiana che si svolge negli spazi della aggregazione sociale e produttiva, “densi” di interazioni e funzioni. Sono quei luoghi estremamente lontani (culturalmente, prima ancora che fisicamente) dallo spazio sociale condiviso e dal mondo di significati proprio di quelle società che si auto-rappresentano come il “centro” (il core) di un territorio che si vuole come “intorno”, come “ambiente” che si allarga a cerchi concentrici sino alle estreme periferie, e si va poi rarefacendo, quasi dissolvendosi oltre i confini dello spazio percepito.
Questo meccanismo culturale e sociale di rimozione e allontanamento non riguarda solo la rappresentazione dei luoghi esotici, di quelle aree per noi europei remote come i deserti, le regioni equatoriali o il grande nord: la remoteness o estrema lontananza sembra infatti essere percepita anche da chi vive in aree urbano-metropolitane, come quelle italiane, rispetto ad alcune aree montane e rurali dello stesso Stato o addirittura della stessa regione in cui sono situate le grandi città o i territori più densamente popolati.
Una percezione dall’altrove
In questo processo di costruzione sociale della remoteness, l’immaginario condiviso gioca un ruolo fondamentale. Infatti, come sostiene l’antropologo Edwin Ardener (2012), «il remoto è composto da luoghi ‘immaginari’ e ‘reali’ al tempo stesso» (Ibid.: 521). Se è necessario che la remoteness abbia una qualche collocazione topografica, essa tuttavia «è definita all’interno di uno spazio topologico le cui caratteristiche sono espresse in un vocabolario culturale» (Ibid.: 523): dunque, essa «è prima di tutto un’esperienza concettuale» (Ibid.: 524).
I luoghi remoti, in questa accezione, non appaiono allora come quelli ai margini di un continuum spaziale, esterni ma comunque connessi, anche se in modo debole, al “centro”, senza soluzione di continuità. Piuttosto, continua Ardener, «la lezione delle aree remote è che si tratta di una condizione non legata alla periferia, ma al fatto che certe periferie non sono per definizione propriamente legate alla zona dominante. Sono percezioni della zona dominante, non fanno parte della sua esperienza codificata» (Ibid.: 532).
All’interno dei processi di marginalizzazione socio-economica e territoriale spinti dalla globalizzazione neoliberista e dalla radicale ridefinizione della geopolitica planetaria in atto in questi anni, i luoghi remoti sembrano quindi costituire una categoria diversa da quella di “periferia”: essi rappresentano, in termini culturali, un’alterità posta al di fuori del continuum spaziale e concettuale – di natura essenzialmente fluida – vissuto e messo in atto anzitutto negli spazi metropolitani. La loro estrema lontananza li pone quindi fuori dall’orizzonte quotidiano di chi vive le aree demograficamente ed economicamente “dense”, e li connota come elemento di rottura della fluidità in cui si muovono gli abitanti dei luoghi “centrali”, in rapporto all’ambiente circostante.
Questa caratteristica dei remote places – attribuita principalmente attraverso processi di etero-significazione – se da un lato li espone al rischio concreto di ghettizzazione, o addirittura di espulsione dalla società mainstream (il fenomeno analizzato da Rodriguez-Pose rispetto ai “places that do not matter”, 2017), dall’altro lato può rivelare un loro inatteso potenziale in termini di innovazione, creatività e anche attrattività, che altri territori, percepiti appunto come periferici e marginali (dunque tendenzialmente subalterni dentro un sistema di significati e relazioni univoco), di solito non possiedono. È un potenziale che possiamo definire, ancora sulla scorta della analisi di Ardener (2012), di “contro-specificazione”, che si manifesta soprattutto quando le popolazioni locali, o alcuni gruppi sociali specifici, diventano consapevoli di quell’insieme di risorse (culturali, reputazionali, identitarie…) legate alla determinata posizione da essi rivestita nello spazio simbolico più vasto. Infatti, secondo Ardener, «la remoteness è una specificazione, e una percezione, da altrove, da un punto di vista esterno; ma dall’interno la gente ha le proprie percezioni – se si vuole, una contro-specificazione dello spazio dominante, o di definizione, che lavora nella direzione opposta» (Ibid.:531).
Il potenziale rivoluzionario dei luoghi remoti
Il potenziale direi quasi rivoluzionario dei luoghi remoti è legato dunque al loro non appartenere, o all’appartenenza molto debole, alle catene delle relazioni economico-territoriali dominanti: al non esserne completamente ingabbiati. Questo potenziale riguarda non solo gli immaginari che su di essi sono costruiti ma anche la loro dimensione fisica e territoriale, il loro essere, almeno per certi versi, al di fuori o comunque solo debolmente colpiti – di rimbalzo potremmo dire – dalle dinamiche spaziali del capitalismo neo liberista.
Come ci ricorda Harvey (1985), la globalizzazione neoliberista sottrae infatti in misura crescente spazio e opportunità alle persone e alle comunità, subordinandole alle reti mondiali del capitale: in questo modo, essa contribuisce a uno scambio accelerato di merci e di significati culturali, stabilendo una subordinazione socio-spaziale ad ampio raggio al potere egemonico, ai nodi centrali della rete. All’interno di questo processo economico e politico, lo spazio fisico tende a essere trattato come un mero supporto, una piattaforma infrastrutturale per lo sviluppo di attività produttive e di servizio che sfruttano temporaneamente determinate posizioni geografiche e asset di risorse socio-culturali, per poi abbandonarli e trasferirsi in altre location, più redditizie in termini di costo della manodopera, diritti dei lavoratori, leggi antinquinamento, tassazione, ecc. Per molti aspetti, i luoghi concreti e comunitari, i “mondi della vita” (Habermas 1986) delle persone, sono trattati dal capitalismo globale come “non luoghi” (Augé, 1992) tra di loro intercambiabili, dove le caratteristiche locali distintive sono ridotte a quelle funzionali e convenienti per lo sfruttamento dei contesti in cui le attività economiche sono temporaneamente collocate (Gough, 2014).
Queste dinamiche producono gerarchie territoriali (per quanto instabili), competizione tra territori a livello globale, alleanze mutevoli tra città globali che cercano di prevalere sullo scacchiere economico planetario o macroregionale (Sassen 2001). Allo stesso tempo, questi processi favoriscono l’emarginazione di ampie porzioni del pianeta, colpiscono spazi già sfruttati e poi abbandonati dagli attori economici transnazionali che trasferiscono le loro attività altrove; le strategie di dislocazione produttiva impoveriscono le economie tradizionali e riducono la capacità di autodeterminazione delle comunità locali che si affidano a sistemi economici e del lavoro che non si radicano mai veramente nel loro territorio, ma che minacciano invece costantemente di andarsene verso luoghi più convenienti (Gray e Barford, 2018).
Come evidenziato da Krasteva (2020), i territori e le comunità locali tendono inoltre oggi ad essere trascurati ed espropriati delle loro prerogative di autodeterminazione e di autogoverno non solo dal mercato ma anche da attori politici istituzionali, spesso a loro volta pienamente inseriti in modelli economici e di governance neoliberisti. Infatti, se da un lato lo Stato – come attore territoriale – è apparso nel corso degli ultimi decenni indebolito dalla globalizzazione economica, dall’altro sembra ora uscire rafforzato in alcuni aspetti (ad esempio, nel controllo delle risorse e nell’esercizio del potere su scala diversa) dalla moltitudine di crisi (la cosiddetta “policrisi”) che si sono verificate negli ultimi anni, come quelle legate alle migrazioni internazionali, alla pandemia da COVID-19 e al cambiamento climatico. Siamo di fronte, sempre secondo Krasteva, ad una “rivincita dello Stato” (o addirittura, come scrive la studiosa bulgara, una “revenge of the State”, una sorta di “vendetta”), perlomeno nel continente europeo (dove si assiste anche ad una riaffermarsi dell’influenza esercitata dalla UE, in stretto rapporto con la NATO, specialmente in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina): un ritorno che privilegia il potere centrale (e “lontano” dai territori) rispetto alle autonomie locali, nonostante le storiche e le nuove rivendicazioni di maggiore autodeterminazione e controllo sul proprio spazio di vita avanzate dalle regioni periferiche, messe in evidenza proprio dalla gestione delle misure anti pandemiche negli ultimi tre anni (OCSE, 2021).
A fronte dei processi di marginalizzazione, subordinazione e sfruttamento territoriali appena descritti, che fanno perno sul trinomio periferizzazione-espropriazione-abbandono, le aree remote europee – o perlomeno alcune di esse – sembrano invece negli ultimi tempi acquisire un nuovo e inatteso valore, catalizzando crescente interesse e aspettative, soprattutto in certe fasce di popolazione e in certi settori sociali. Questa inedita attrattività (per molti aspetti ancora simbolica prima che effettiva in termini, per esempio, demografici) va collegata in primis allo sviluppo negli ultimi tre decenni almeno di sensibilità e di orizzonti di valore che possiamo definire come neo rurali, della sostenibilità ambientale, del ritorno alla terra e a ritmi e stili di vita opposti a quelli tipici del capitalismo. Sulla base di queste tendenze culturali, socio-demografiche e valoriali ormai di lungo corso (ancorché quantitativamente ancora limitate), la nuova attrattività dei luoghi remoti – e il suo essere potenzialmente ben più vasta di quanto sinora è stata – va ricondotta a mio avviso anzitutto a due fenomeni globali, quali il cambiamento climatico e la pandemia.
Le aree remote – e soprattutto le catene montuose europee come le Alpi, i Pirenei, i Carpazi o gli Appennini – sono particolarmente suscettibili alle drammatiche conseguenze dei cambiamenti climatici (Mercalli 2019; Beniston 2003): maggiore impatto dell’innalzamento delle temperature e dell’aumento delle precipitazioni locali, dissesto idrogeologico, eventi meteorologici estremi, piogge e siccità, sono tutti fenomeni che colpiscono con particolare violenza montagne, piccole isole, aree interne, ecosistemi fragili. Tra le macro-regioni europee, proprio le Alpi e gli Appennini – anche in rapporto al loro essere paesaggi culturali frutto di una lunga antropizzazione – stanno vivendo e vivranno questi fenomeni in modo ancora più drammatico (Schneiderbauer et al. 2021). Di conseguenza, molti luoghi remoti sembrano essere sempre più interessati da fenomeni di abbandono di massa (specie da parte dei più giovani) e di parallelo invecchiamento della popolazione, con effetti disastrosi sia sulle economie e sulle società locali sia sulla possibilità di preservare ecosistemi spesso dipendenti dalla costante manutenzione e cura umana (Dax et al., 2021; Copus et al., 2021).
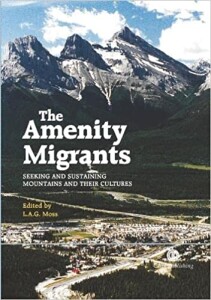 Eppure sono proprio le aree remote – in particolare i territori che preservano le loro risorse naturali e che sono percepite come una “alterità” rispetto all’universo urbano – quelle che negli ultimi anni hanno suscitato un crescente interesse da parte di importanti settori della popolazione in molte parti del mondo, principalmente quelle più ricche dell’Europa e del Nord globale. Come evidenziato dalla ricca letteratura ormai esistente sul fenomeno degli amenity migrants (Moss 2006; Steinecke et al., 2009) e quindi dei “nuovi montanari” (Corrado et al. 2014), un numero crescente di persone (specialmente di classe media, giovani adulti, con titoli di studio elevati e residenti nelle aree urbano-metropolitane) guardano con interesse a questi spazi di vita percepiti come lontani dal caos e dal sovraffollamento delle metropoli, dotati di un’ampia gamma di servizi eco-sistemici e di un’elevata qualità della vita, compresa oggi la possibilità dello smart working (Lardies-Bosque e Membretti, 2022; Barbera et al., 2019).
Eppure sono proprio le aree remote – in particolare i territori che preservano le loro risorse naturali e che sono percepite come una “alterità” rispetto all’universo urbano – quelle che negli ultimi anni hanno suscitato un crescente interesse da parte di importanti settori della popolazione in molte parti del mondo, principalmente quelle più ricche dell’Europa e del Nord globale. Come evidenziato dalla ricca letteratura ormai esistente sul fenomeno degli amenity migrants (Moss 2006; Steinecke et al., 2009) e quindi dei “nuovi montanari” (Corrado et al. 2014), un numero crescente di persone (specialmente di classe media, giovani adulti, con titoli di studio elevati e residenti nelle aree urbano-metropolitane) guardano con interesse a questi spazi di vita percepiti come lontani dal caos e dal sovraffollamento delle metropoli, dotati di un’ampia gamma di servizi eco-sistemici e di un’elevata qualità della vita, compresa oggi la possibilità dello smart working (Lardies-Bosque e Membretti, 2022; Barbera et al., 2019).
Ambivalenze della remoteness
Se dunque il cambiamento climatico – e le sue conseguenze, percepite e anticipate da diverse categorie di persone, con strategie di adattamento preventivo – rappresenta un push factor rilevante rispetto alla mobilità verso le aree remote, la pandemia da Covid-19 ha contribuito a una ri-tematizzazione della remoteness stessa, ovvero della estrema lontananza: questo è avvenuto non solo in termini di “distanziamento sociale” (e del nuovo ruolo sociale della distanza fisica, introdotto dalle misure di contrasto alla diffusione del virus) ma anche per quanto riguarda le percezioni e gli usi dello spazio – a livello fisico, simbolico e normativo.
Nel contempo, al rapporto tra luoghi “centrali” e località “remote” è stato attribuito socialmente un nuovo valore, anche se non senza un’ambiguità di fondo che riflette le disparità socio-economiche tra i diversi settori della popolazione, in rapporto alle risorse di cui essi dispongono. Per alcuni, i luoghi remoti hanno rappresentato durante i picchi della pandemia – e tuttora rappresentano – la controparte attraente di metropoli sovraffollate, inquinate e spesso percepite come insicure. Per altri (spesso proprio le popolazioni locali, rimaste “intrappolate” in quei territori estremamente lontani), la remoteness si è tradotta – e ancora rischia di tradursi – in un rischio di confinamento socio-spaziale, in un dover vivere tagliati fuori da servizi e opportunità, con un impatto ancora più grave vissuto in tempi di lock-down e mobilità ridotta (Rodriguez-Pose e Hardy, 2015; Perlik, 2011). Accade quindi che lo stesso luogo possa essere percepito come “remoto” (con un’accezione positiva, quasi “salvifica”) dai nuovi arrivati e come “emarginato” (con un significato invece negativo, quasi un “ghetto”) dai suoi abitanti originari, come si è ampiamente visto proprio durante i picchi della pandemia, in rapporto alle strategie di mobilità degli abitanti urbani e alle forme di immobilità dei residenti storici.
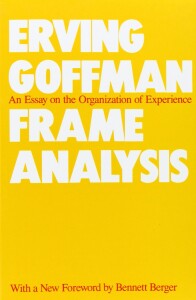 La “remotizzazione” dei luoghi che non contano
La “remotizzazione” dei luoghi che non contano
Una riflessione sul nuovo ruolo che può assumere oggi e in futuro la remoteness si lega giocoforza al riconoscimento che il mondo, ancorché globalizzato, non è “piatto” né a-dimensionale: «il luogo conta», infatti (“place matters”, come sostengono Dreier et al., 2004), e quindi conta la collocazione spaziale delle persone e delle attività. Come già analizzato cinquant’anni fa da Erving Goffman (1974), i contesti locali inquadrano (tramite il processo del framing) la costruzione, la riproduzione e il cambiamento della società, mettendo in forma una continua negoziazione socio-culturale tra una varietà di strutture e gruppi sociali nei territori e negli spazi stessi, e coinvolgendo diversi gruppi di abitanti: consolidati e nuovi, temporanei e permanenti, cittadini e stranieri (Membretti e Viazzo 2017).
È dunque la riflessione spazializzata (place-based e place-sensitive: Sotarauta 2020) sulle aree remote a mettere in luce come fattori diversi e intrecciati tra loro stiano oggi innescando e favorendo processi ambivalenti che potremmo definire di “remotizzazione” (Membretti 2021): processi legati alla crescente urbanizzazione globale e all’iperconcentrazione delle attività socio-economiche in determinati territori, con il conseguente allontanamento e “rimozione” di intere aree geografiche. La “remotizzazione” può essere dunque descritta come il crescente distanziamento, di tipo anzitutto simbolico – ma anche fisico, se si considera per esempio l’indebolimento delle connessioni infrastrutturali – fra le aree interne-montane e quelle urbano-metropolitane. Un processo di allontanamento che può portare sia all’isolamento sociale e dunque al risentimento da parte di chi abita i luoghi remoti nei confronti del “centro” (si vedano le forme regressive e difensive di populismo xenofobo e sovranista e il comportamento elettorale espresso da quanti vivono nei «luoghi che non contano»: Rodriguez-Pose, 2017), sia all’apertura di nuove opportunità di sviluppo in questi stessi contesti, grazie alla valorizzazione della propria posizione nello spazio (anche in rapporto dialettico con le città), e del significato culturale che ad essa può venire attribuito, a livello endogeno come esogeno (il potenziale della “contro-specificazione”, come si diceva, e il valore dell’alterità, in termini di modelli di sviluppo come di forme identitarie).
La “remotizzazione” si mostra come un processo bidirezionale in termini di percezione e rappresentazione: mentre le regioni “remotizzate”, come quelle interne e montane, si percepiscono sempre più lontane dal “centro”, è il “centro” stesso (che coincide in larga misura con le aree metropolitane e urbane ma anche con i lontani gangli del potere di organismi sovranazionali come la UE) a essere percepito in modo crescente come remoto (e quindi “rimosso”) da chi vive estremamente lontano da esso (e si sente da esso trascurato, left behind). Le grandi aree metropolitane – dove si esercita il potere politico, economico e culturale – cominciano dunque a essere viste come remote (in termini di connessioni spaziali e di immaginario) rispetto a quei microcosmi regionali o locali a cui i loro abitanti stanno attribuendo un crescente valore sociale, come luoghi di rifugio, in alcuni casi, o come spazi di identità resistente/difensiva in altri (per esempio proprio in relazione alle dinamiche pandemiche e ai movimenti no vax: Gruber, Lardies, Membretti e Tonelli, 2022). In Italia, sono interessanti in questo senso (e ambivalenti) i dati recenti relativi al “desiderio di restanza” (Teti 2022) espresso da molti giovani residenti nelle aree interne del paese, in rapporto al valore attribuito al proprio paesaggio culturale e al proprio contesto comunitario, così come alla complessa dialettica con la dimensione urbana (Membretti et al. 2023).
Pertanto, è l’ambiguità rispetto al valore e al disvalore dei luoghi remoti, in relazione a ciò che possono offrire come opportunità per certe categorie sociali o rispetto ai limiti che possono imporre ad altri gruppi sociali, che merita attenzione, così come si presenta ricco e sfaccettato il concetto di remoteness (o di estrema lontananza) e il relativo processo di “remotizzazione” più sopra abbozzato.
Politiche metromontane, per una messa a valore dei luoghi remoti
La riflessione che si può sviluppare sui luoghi remoti, in rapporto alla loro stessa percezione da parte di diversi gruppi sociali, sembra pertanto posizionarsi su di un piano concettuale assai diverso rispetto a quello fondato sulla contrapposizione centro-periferia. Dunque, le politiche che vanno messe qui in campo, e gli spazi di innovazione che si presentano, dovrebbero abbandonare questa visione dicotomica, polarizzante e, in ultima analisi, depotenziante rispetto a quei territori e a quelle persone ancora oggi spesso rappresentati come “ai margini” di altri territori (e di altri gruppi sociali) che pretendono di essere e di rimanere il “centro”. Servono piuttosto politiche di capacitazione, di empowerment, che sappiano riconoscere la diversità dei luoghi remoti come risorsa e non come elemento da omologare ai modelli di crescita urbano-centrici.
Come evidenziato proprio dal movimento verso questi luoghi dei neo abitanti e dal parallelo trend di “restanza” che si affaccia timidamente in molti casi puntuali, le aree interne e montane – tendenzialmente escluse ed emarginate, così come invece possibile esempio di modelli di vita e di economia lontani dal capitalismo neo liberista – sembrano chiamare un equilibrio territoriale radicalmente nuovo, una «inversione dello sguardo» (De Rossi 2018) sul nostro Paese. Si aprono spazi per l’emersione, ancora in larga parte da delineare dal punto di vista della ricerca così come delle policy, di uno spazio culturale, relazionale e di governance che possiamo definire “metromontano” (Barbera e De Rossi 2021): uno spazio in costruzione, teso tra urbano e rurale e in grado di favorire – nell’ambito di interventi di “ricucitura” e di interconnessione giocati sulla “giusta distanza” tra i territori – l’inclusione sociale, il benessere diffuso e l’equo accesso alle risorse per i diversi gruppi di popolazione interessati al loro utilizzo, in un quadro di sviluppo sostenibile e di giustizia sociale.
Nel cercare strategie di governance innovative per affrontare le sfide contemporanee a livello europeo come italiano, sembra esserci dunque spazio per una riscoperta (o forse una reinvenzione) dei luoghi remoti e per una messa a valore delle loro caratteristiche, del potenziale di diversità e di innovazione sociale da essi rappresentato. Nel contempo, si aprono occasioni per una ri-tematizzazione della remoteness stessa, ovvero del concetto di estrema lontananza, come lente attraverso la quale comprendere alcuni dei cambiamenti spazializzati in atto nella vita quotidiana e nel contempo come strumento per ipotizzare e poi provare a gestire scenari territoriali e di sviluppo alternativi rispetto a quelli della globalizzazione neoliberista e del ritorno prepotente dei poteri centrali.
Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2023
[*] Le riflessioni sviluppate in questo articolo sono il frutto del confronto e della collaborazione scientifica con i colleghi Thomas Dax e Ingrid Machold (BAB, Vienna) e Anna Krasteva (New Bulgarian University, Sofia), avviato con la rete internazionale ForAlps e quindi proseguito nel progetto Horizon2020 MATILDE: a loro va il mio sentito ringraziamento e il riconoscimento pubblico del prezioso contributo che mi hanno fornito nell’elaborare una prima concettualizzazione sul tema della remoteness rispetto alle aree montane e rurali europee. I temi qui trattati, in un primo momento da me affrontati nel long abstract “Compulsion to Locality? Mobility, proximity and the role of rural and mountain areas after the Covid-19 crisis”, presentato alla International Conference “Bodies in the climate change era”, Institute of Body & Culture, University of Konkuk, Seoul, South Korea (29-30.05.2020), sono stati poi in parte sviluppati anche in Membretti A., Dax T. and Machold I. (2022), “Reframing remote places and remoteness as a collective resource and value for Europe”, in Membretti A., Dax T. and Krasteva A. (a cura di), The Renaissance of Remote Places: MATILDE Manifesto, Routledge, 2022.
Riferimenti bibliografici
Ardener, E. (2012), ‘Remote Areas. Some Theoretical Considerations’, HAU: Journal of Ethnographic Theory, 2(1): 519–533. https://doi.org/10.14318/ hau2.1.023 (downloaded: 01/12/2021).
Augé, M. (1992), Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, Montrouge: Le Seuil.
Barbera, F., Bacchetti, E., Membretti, A., Spirito, A. e Orestano, L. (2019), Vado a vivere in Montagna. Risposte innovative per sviluppare nuove economie nelle Aree Interne, Torino: SocialFare.
Beniston, M. (2003), “Climatic change in mountain regions: a review of possible impacts”, Climatic Change, 59: 5-31.
Copus, A., et al. (2021), ‘European Shrinking Rural Areas: Key Messages for a Refreshed Long-term European Policy Vision’, TERRA. Revista de desarollo local, 8: 280–309. http://doi.org/10.7203/terra.8.20366.
Corrado, F., Dematteis G. e Di Gioia A. (a cura di) (2014), Nuovi Montanari. Abitare le Alpi nel XXI secolo, Milano: Franco Angeli.
Dax, T., et al. (2021), ‘Land Abandonment in Mountain Areas of the EU: An Inevi- table Side Effect of Farming Modernization and Neglected Threat to Sustainable Land Use’, Land, 10(6): 591. https://doi.org/10.3390/land10060591.
De Rossi A. (2018), Riabitare l’Italia. Le aree interne tra abbandoni e riconquiste, Roma: Donzelli.
Dreier, P., Mollenkopf, P. and Swanstrom, T. (2004), Place Matters: Metropolitics for the Twenty-First Century, Westbrooke Circle, Lawrence, KS: University Press of Kansas.
Gieryn, T. F. (2000), ‘A Space for Place in Sociology’, Annual Review of Sociology, 26: 463–496.
Goffman E. (1974), Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, Harvard University Press.
Gough, J. (2014), ‘The Difference between Local and National Capitalism, and Why Local Capitalisms Differ from One Another: A Marxist Approach’, Capital and Class, 38(1): 197–210.
Gruber, M., et al. (2022), ‘The Impact of the COVID-19 Pandemic on Remote and Rural Regions of Europe: Spotlight on Foreign Immigration and Local Develop- ment’, in GSSI Discussion Paper series in Regional Science & Economic Geography, 1/2022.
Habermas Jünger (1986), Teoria dell’agire comunicativo: critica della ragione funzionalistica, trad. it. di P. Rinaudo, Bologna: Il Mulino.
Harvey, D. (1985), ‘The Geopolitics of Capitalism’, in Gregory, D. and Urry, J. (eds.), Social Relations and Spatial Structures. London: Macmillan: 128–163.
Krasteva, A. (2020), ‘If Borders Did Not Exist, Euroscepticism Would Have Invented Them”, on Post-Communist Re/De/Re/Bordering in Bulgaria’, Geopolitics, 25(3): 678–705. http://doi.org/10.1080/14650045.2017.1398142.
Lardies-Bosque, R. e Membretti, A. (2023). ‘In-migration to European Mountain Regions: A Challenge for Local Resilience and Sustainable Development’, in Schneiderbauer, S., Szarzynski, J. and Shroder, J. (eds.), Safeguarding Mountains – A Global Challenge. Facing Emerging Risks, Adapting to Changing Environments and Building Transformative Resilience in Mountain Regions Worldwide. Elsevier.
Massey, D. (1994), Space, Place and Gender. Cambridge: Polity.
Membretti A. (2022), “Remoteness as an opportunity for de-peripheralization of rural and mountainous regions of Europe”, IMC – International Mountain Conference, Innsbruck, Settembre 2022.
Membretti A. (2021), “Remote Places of Europe and the New Value of Remoteness” Settembre 2021 (https://www.researchgate.net/publication/354753973_Remote_Places_of_Europe_and_the_New_Value_of_Remoteness), DOI: 10.13140/RG.2.2.15779.78886
Membretti, A. e Viazzo, P. P. (2017), ‘Negotiating the Mountains. Foreign Immigration and Cultural Change in the Italian Alps’, MARTOR – The Museum of the Romanian Peasant Anthropology Journal, 22: 93–107.
Mercalli, L. (2019), Il clima che cambia. Perché il riscaldamento globale è un problema vero, e come fare per fermarlo, Milano. Rizzoli.
Moss, L. A., (a cura di) (2006), The Amenity Migrants: Seeking and Sustaining Mountains and Their Cultures, Wallingford: CABI.
OECD. (2021), OECD Regional Outlook 2021: Addressing COVID-19 and Moving to Net Zero Greenhouse Gas Emissions, Paris: OECD Publishing.
Perlik, M. (2011), ‘Alpine Gentrification: The Mountain Village as a Metropolitan Neighbourhood’, Revue de Geographie Alpine/Journal of Alpine Research, 99(1), http://doi.org/10.4000/rga.1370.
Perlik, M., Galera, G., Machold, I. and Membretti, A., (a cura di) (2019), Alpine Refugees. Immigration at the Core of Europe. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
Rodríguez-Pose, A. (2017), ‘The Revenge of the Places that Don’t Matter (and What to Do about It)’, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 11(1): 189–209, Oxford: Oxford University Press.
Sassen, S. (2001). The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University Press.
Schneiderbauer, S., Szarzynski, J. and Shroder, J. (a cura di) (2021), Safeguarding Mountains – A Global Challenge. Facing Emerging Risks, Adapting to Changing Environments and Building Transformative Resilience in Mountain Regions Worldwide. London: Elsevier.
Sotarauta, M. (2020), ‘Place-based Policy, Place Sensitivity and Place Leadership’, Working Paper 46/2020. Tampere University.
Steinecke, E., Čede, P. and Flie, U. (2009), ‘Development Patterns of Rural Depop- ulation Areas. Demographic Impacts of Amenity Migration on Italian Periph- eral Regions’, Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft: 195–214.
Teti V. (2022), La restanza, Einaudi, Torino.
___________________________________________________________________________
Andrea Membretti, Senior Researcher presso la University of Eastern Finland, é Research Associate in Sociologia alla University of the Free State (Sudafrica) e Professore a contratto di Sociologia del Territorio all’Universitá di Pavia. È Faculty Member in Scienze Sociali al Gran Sasso Science Institute – GSSI. È consulente per organizzazioni pubbliche nel campo della pianificazione partecipativa. Il suo principale campo di studio è la migrazione da e verso i territori montani e rurali, europei ed extraeuropei, in relazione ai cambiamenti climatici, agli eventi estremi e ai cambiamenti socio-economici e demografici. È coordinatore scientifico del progetto Horizon2020 MATILDE (Migration impact assessment to enhance local integration in rural and mountain areas of Europe, 2020-2023). È autore di diversi studi. Ha scritto con Dematteis e Di Gioia, Montanari per forza. Rifugiati e richiedenti asilo nella montagna italiana (2018) e con Leone e Lucatelli, Voglia di restare (2023).
______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM
URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-richiamo-della-remoteness-ambivalenze-e-potenzialita-dellestrema-lontananza-nelle-aree-interne-e-montane/
Click here to print.










